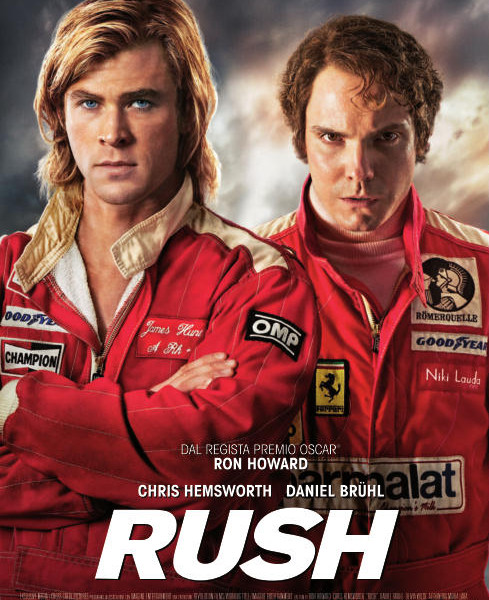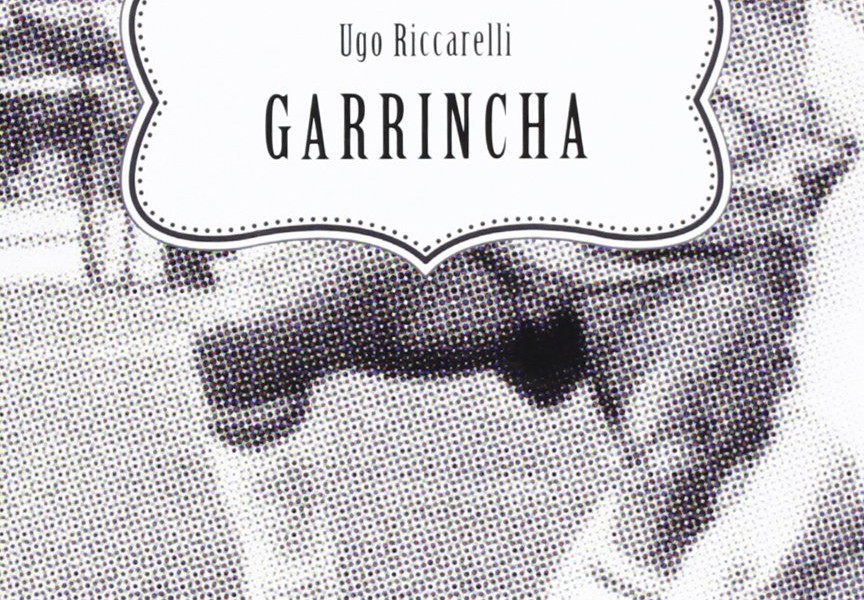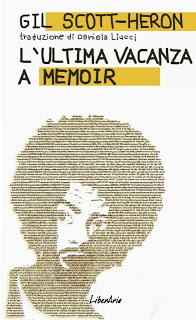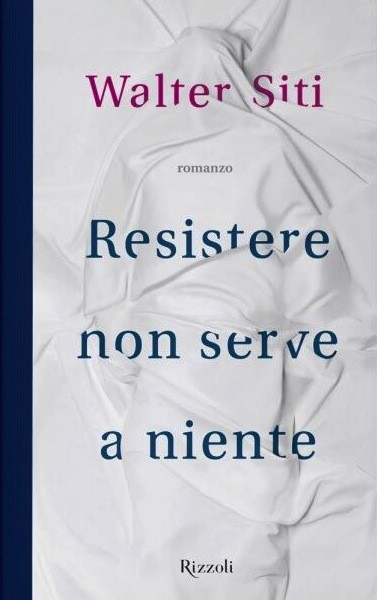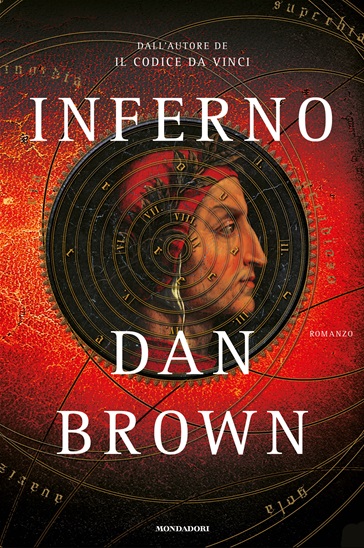«L’uso ha voluto che il poeta scriva in verso. Ciò non è della sostanza né della poesia, né del suo linguaggio, e modo di esprimere le cose»
Giacomo Leopardi, Zibaldone
La poesia è il riflesso della vita di un poeta: seguire i versi di Eugenio Montale significa soprattutto interpretare, ricomporre e decifrare gli indizi lasciati dal poeta stesso nella scacchiera della sua opera. Le composizioni del poeta ligure camminano sempre in parallelo con l’esistenza. La critica per inquadrare il periodo in questione – da Satura in poi – accosta al nome dell’autore gli aggettivi “secondo” eo “ultimo”: termini usati per mostrare un netto divario tra due stili molto diversi o per una scansione cronologica. Ma non per una classificazione qualitativa.
Satura è la massima cesura nella produzione poetica e umana di Montale. La raccolta al centro del nostro articolo, uscita nel 1971, colpì per i notevoli e vistosi tratti di novità. Non un fu uno choc, ma ci andiamo vicino. La potenza della rima lasciava spazio a un andamento più prosastico e colloquiale. Una serie di sequenze quotidiane, intime e private – ma non per questo meno magnifiche – prendeva il sopravvento. “Nel fumo”, tratta da Satura I, ne è un esempio altissimo:
Nel fumo
Quante volte t’ho atteso alla stazione
nel freddo, nella nebbia. Passeggiavo
tossicchiando, comprando giornali innominabili,
fumando Giuba poi soppresse dal ministro
dei tabacchi, il balordo!
Forse un treno sbagliato, un doppione oppure una
sottrazione. Scrutavo le carriole
dei facchini se mai ci fosse stato
dentro il tuo bagaglio, e tu dietro, in ritardo.
Poi apparivi, ultima. È un ricordo
tra tanti altri. Nel sogno mi perseguita.
Immaginatela meraviglia nel vedere come il poeta italiano per eccellenza, in quel periodo insignito delle più alte e importanti cariche civili e culturali, dall’alto dei suoi 75 anni, potesse estrarre dall’infinito bagaglio della sua parola una raccolta poetica così vitale e contemporanea. L’impatto fu proporzionale alla grandezza della figura che l’aveva generato. Il critico Romano Luperini scrisse che con Satura non solo cambiava l’immagine del poeta, ma anche il nostro canone letterario.
L’onnipresenza montaliana non deve sorprendere: caratteristica unica dell’autore è sempre stata la volontà di specchiarsi con il suo tempo, riflettendolo e filtrandolo nella poesia. Il colpo fu potente, ma non così inaspettato. Bastava vedere gli indizi…
1966, terza puntata della trasmissione radiofonica Montale parla di Montale. Il diretto interessato accenna a un filo romanzesco e autobiografico che lega le sue opere, paragonando in seguito le prime tre raccolte ai tre libri della Commedia dantesca. Nel 1977 dirà: «Nella mia vita ho scritto un libro solo». I versi parlano ancora più chiaramente, poiché il vero tratto distintivo dell’ultimo Montale è uno solo: negli Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro – nonostante la consapevolezza del dramma umano – era riposta nella Poesia una speranza e una fiducia nella dignità e nella purezza del ruolo letterario. Adesso, con Satura, questa speranza non c’è più.
«Dopo La bufera io non ho scritto poesia per anni. Ho scritto soltanto articoli. Così quando sono tornato alla poesia, mi è sembrato normale abbassare il tono dei versi, renderlo più prosastico».
Sempre Luperini – in Storia di Montale – intitola il capitolo su Satura in maniera emblematica: “Dalla poesia dell’assenza, all’assenza della poesia”. Poche chiarissime parole, capaci di riassumere il giro di boa. La Storia ha tolto ogni speranza e i numerosi riconoscimenti per l’attività letteraria non hanno fatto altro che imprigionare Montale in un contesto estraneo e nocivo.
I bambini
I bambini non si chiedono
se esista un’altra Esistenza.
E hanno ragione. Quel nocciolo
duro non è semenza.
Ma Satura è anche la massima espressione del pessimismo montaliano. Tutte le figure, fisiche e materiali, in cui era riposto un minimo di speranza e di investitura ideale sono evaporate sotto il sole di una realtà accecante. Dialettiche della salvezza-dannazione incarnate da figure passate come Clizia (Le occasioni) sono irrecuperabili. Idem la religione, Dio: «Tutte le religioni del Dio unico / sono una sola: variano i cuochi e le cotture» (“La Morte di Dio”)
Per Giorgio Zampa l’impossibilità di dare alla poesia ragioni vitali è conseguenza del fatto che la vita stessa si sia ridotta a un niente. Esiste solo questo presente e l’imperativo è viverlo. L’oscillare tra accettazione e rifiuto però non porta ancora – mi permetto di dire fortunatamente – al pessimismo assoluto. Certo, il vivere e sentire così profondamente il quotidiano ha svalutato la possibilità di una coscienza metafisica e allegorica, ma uno spiraglio tra queste impenetrabili tenebre c’è. Ed è fatto d’amore. È la Mosca, minuta figura aggrappata alla vita grazie all’ironica arte della sopravvivenza, a cui Montale dedica le due celebri sezioni di Satura, Xenia I eII.
Dicono che la mia…
Dicono che la mia
sia una poesia d’inappartenenza.
Ma se era tua era di qualcuno:
di te che non sei più forma, ma essenza.
La commistione tra assenza e ironia crea uno scarto fondamentale. In Le occasioni e in La bufera la mancanza del valore si tramutava nella valorizzazione della poesia in quanto tale. Ora, nel “trionfo la spazzatura”, la fine del linguaggio poetico rischia di ridicolizzare la figura del poeta, che nella speranza di una nuova vita rinnova se stesso.
Al tono sublime si sceglie il prosastico e il taglio giornalistico. Alla lirica, l’ironia. Ecco la grandezza di Eugenio Montale: il rifiuto, la crisi, la depressione, l’accettazione mista a rifiuto di un certo stile di vita non hanno portato al vuoto e al nulla. Affatto. C’è stato un giustificabile periodo di sconforto e silenzio, ma alla fine la risposta è arrivata. Un grande poeta non può rinunciare alla sua arma. In Montale la negazione di una determinata poesia non porta alla cancellazione di tale arte. Porta solo alla costruzione di un’altra poetica, affatto inferiore alle raccolte precedenti.
Da ciò viene fuori Satura, il libro poetico di Montale più rigorosamente calcolato e pianificato, dove la strutturazione retorica è un indistruttibile scheletro d’acciaio e le forme metriche e foniche sono studiate e applicate con lucida e precisa considerazione. Per quanto riguarda la rima, qui Montale impiega tutta la somma padronanza del mezzo per giocare alla strategia dell’occultamento: «Mi abituerò a sentirti o a decifrarti / nel ticchettio della telescrivente».
Si era troppo affezionati al primo Montale per accorgersi all’istante di tutto ciò?
C’è un gioco di contrari capace di contraddistinguere ogni livello della nuova opera; tutto ciò che viene dal basso si innalza a discapito del sublime, indifferentemente incarnato da Dio, dalla Scienza, dalla Filosofia. Basilare la partizione del libro in quattro parti, esattamente come i primi due libri dell’autore, ma con qualche interessante aspetto di innovazione. Le prime due serie di Xenia sono seguite simmetricamente dalle due parti di Satura, seguendo l’ordine cronologico della composizione. Sempre le due sezioni di Xenia combaciano in maniera ancora più netta perché contengono il medesimo numero di testi; quattordici. La struttura a un primo sguardo sembrerebbe quindi impeccabile e lineare visto che sulla retta del tempo vengono inanellate una per una le liriche scritte. Quasi un diario, ma non è ancora tempo per il Diario di Montale.
Nei suoi studi, Scrivano nota che Satura è sì pianificato al suo interno quasi più dei predecessori, ma è anche da questo stesso interno minato. È un libro a corso non obbligato. Bisogna leggerlo sincronicamente e non diacronicamente.
La rottura con il passato è netta. Le tematiche delle liriche precedenti non vengono rinnegate o diluite, ma radicalizzate in senso negativo. Se negli Ossi un miracolo poteva arrivare, adesso la perdita dei valori porta la realtà a estendersi monotona su un unico piano. Nonostante i molti voti (xenion) presentati agli Dei, i miracoli sono finiti. Linguisticamente si prefigura un contrasto dove al lessico ricercato e letterario si contrappone il gergo di tutti i giorni amalgamato alla perfezione dai media. Satura è il libro del plurilinguismo e del pluristilismo. I dati presentati da Riccardo Castellana parlano chiaro: nella raccolta il lessico comprende 1058 parole contro i 732 lemmi degli Ossi e 589 di Le occasioni. Tra questi termini abbiamo: latinismi, forestierismi, gergo quotidiano ed espressioni recenti. Formalmente prevale la composizione breve: è l’epigramma la forma con cui la satira si esprime. Ma non solo: la parodia, l’allegoria di “Botta e risposta I”, il pastiche di “L’angelo nero”, la preghiera di “Primo gennaio” e il genere gnomico-riflessivo abitano in molte parti dell’opera.
L’aspetto retorico è dominato dall’ossimoro, affinché si possano cogliere ed esaltare le antitesi e le contraddizioni del quotidiano, della vita e la loro convivenza. Luperini scrive che l’ossimoro diventa figura della realtà, dell’accettazione definitiva della verità della vita.
Insomma, vista la bellezze e la complessità di Satura, forse, più che parlare del “secondo” o “ultimo” Montale, converrebbe parlare del “Nuovo Primo Montale”.