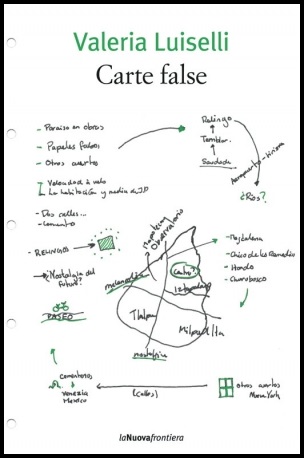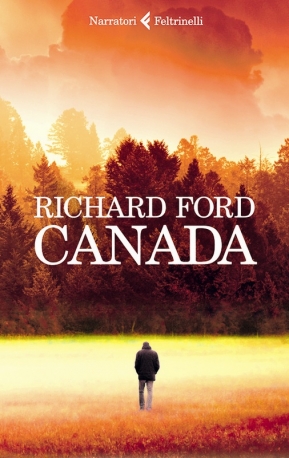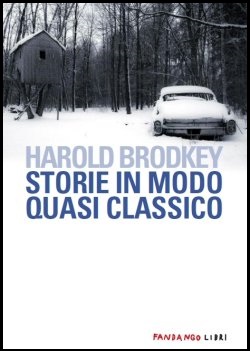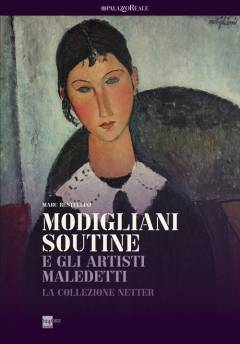Los Angeles anni ’50
«Sono stato un agente del dipartimento di polizia di Los Angeles per quasi dieci anni. Conosco ogni singolo poliziotto corrotto di questa città. In cambio di una tariffa modesta i miei contatti riveleranno informazioni su tutti i membri dell’alta società, le celebrità, i comunisti, i bianchi scopatori di negri, i farabutti interessanti che conoscono».
Questa è la storia di Fred Otash, 1922-1992: investigatore privato, ex poliziotto non modello, informatore della rivista scandalistica Confidential. Questo è il patinato mondo di Hollywood degli anni ’50. Prima di internet e dei blog. Poliziotti corrotti, puttane, finocchi, assassini, file segreti, riviste scandalistiche e attori depravati. Anni che rivivono nel nuovo libro di James Ellroy, Ricatto (Einaudi, 2013, pp. 75, € 10,00).
Non si fa scrupoli Freddy perché «la vita è una Grande Estorsione, non puoi perdere questa chance». E lui non se lo lascia ripetere due volte. In fondo nessuno è così immacolato e «più cose sai sulle persone, meno riescono a commuoverti». Nonostante tutto anche Otash ha, a suo modo, una morale: «Lavoro per chiunque tranne i comunisti. Faccio di tutto tranne un omicidio».
Purgatorio 2012
Freddy è morto da vent’anni. E ha trascorso tutto questo tempo in purgatorio, perché ha scoperto che è tutto vero. Sì, quelle scemenze religiose alle quali non credeva da ragazzo si sono confermate reali: esiste il paradiso per la brava gente, l’inferno per i bastardi e il purgatorio per quelli come lui. Ha convissuto per lungo tempo con i suoi peccati e i suoi guardiani adesso vogliono fare un patto: «Scrivi il tuo percorso perverso e potrai anche finire in paradiso con tutti gli onori. Insomma, è arrivato il momento di CONFESSARE». E il purgatorio certo non è un bel posto. Anche perché le sue vittime terrene lo vengono spesso a trovare in cella per vendicarsi in modo brutale. La settimana scorsa è passata Ava Gardner. L’attrice « […] era una nefasta ninfomane, con una delirante devozione per il salame nero. Le procurai un incontro con un mandingo dotato come un cavallo, e sul più bello i miei ragazzi sfondarono la porta e scattarono la foto. Il numero di “Confidential” di aprile 1954 titolava, insidioso: “Ava Gardner e l’asta africana!”». Sì, è giunto proprio il momento di andarsene da questo posto. I guardiani lo hanno anche messo in contatto telepatico con uno scrittore al quale raccontare la sua storia, un tale James Ellroy …
Romanzo breve (un po’ troppo forse) nato prima come soggetto per un serial sulla Fox (mai realizzato), poi uscito negli Stati Uniti lo scorso anno ma solamente in formato ebook con il titolo Shakedown, Ricatto viene adesso pubblicato in Italia anche in formato cartaceo da Einaudi Stile libero (una novità, essendo i più celebri romanzi di Ellroy editi da Mondadori e alcune opere minori da Bompiani). Dopo la “trilogia americana” (American Tabloid, Sei pezzi da mille e Il sangue è randagio) lo scrittore californiano torna dunque nei luoghi della sua città natale, che già era stata teatro di alcuni suoi grandi successi – la cosiddetta “tetralogia di Los Angeles”: Dalia nera, Il grande nulla, L.A. Confidential, e White Jazz). Inconfondibile, come sempre il suo stile. Sardonico, asciutto, sconcio. In una parola reale. E non importa se i fatti narrati siano tutti veri o no (come in molti romanzi di Ellroy la cronaca e la storia si mischiano con la fantasia, personaggi realmente esistiti come Otash incontrano figure letterarie), l’importante è che siano verosimili.
Una volta, in un’intervista a una tv francese, sul finire degli anni ’80, Ellroy si definì una persona ossessionata dalla violenza, dal sesso, dalla gelosia e dall’ambizione sfrenata, salvata dalla scrittura dopo anni di piccoli crimini minori e di abuso di alcool e droga. In fondo non assomiglia un po’ a Freddy?
(James Ellroy, Ricatto, trad. di Alfredo Colitto, Einaudi, 2013, pp. 88, euro 10)