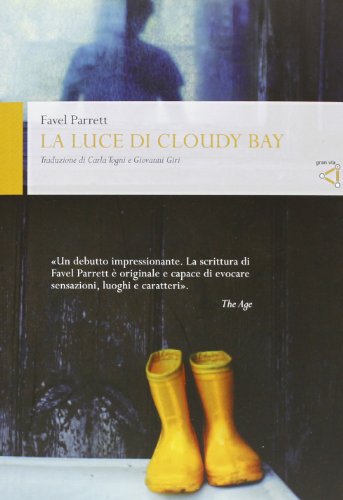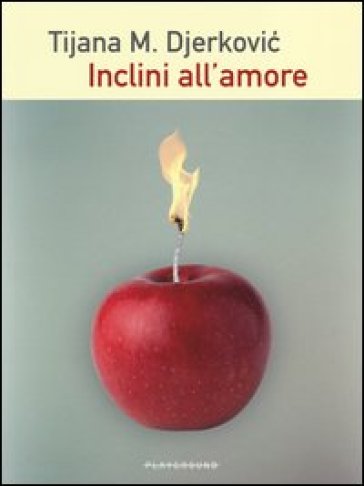La parola come consolazione. E come distrazione mentre intorno impazza la peste, la malattia, la morte. La parola come filo di una trama tessuta per ingannare e distruggere. E ancora, la sadica vendetta per colpire chi inconsapevolmente usa la parola come un’arma. Il primo è il caso del Decameron, di Giovanni Boccaccio. Il secondo dell’Otello, di William Shakespeare. Il terzo, infine, è il caso di Old Boy, film di Park Chan-wook. L’Italia del 1300. L’Inghilterra dell’età elisabettiana. La Corea del Sud dei nostri giorni. Tre epoche diverse, tre lingue e culture differenti, tre forme d’arte – prosa, teatro, cinema – che hanno un comune denominatore: la parola come motore immobile della narrazione.
I racconti boccacciani sono introdotti da un proemio. L’autore spiega qui che il libro è rivolto soprattutto a quelle donne che soffrono per amore. Il Decameron è composto da una serie di racconti dilettevoli, il cui compito principale è appunto quello di portare consolazione. E la stessa struttura dell’opera, la cornice, rimanda continuamente al racconto inteso prima di tutto come forma d’arte orale. Dieci giovani si incontrano nella chiesa di santa Maria Novella e per sfuggire all’epidemia di peste si rifugiano in alcune ville poco fuori le mura del capoluogo toscano. Ragazzi che per passare le giornate si danno appuntamento in giardino, luogo allo stesso tempo ameno e architettonicamente realistico, dove nasce una nuova società basata sulla narrazione dilettevole, dove a turno si è narratori e ascoltatori, dove si può sperimentare ma all’interno di determinate regole. Bisogna seguire dei temi che si assegnano a ogni giornata – amori finiti in tragedia, amori a lieto fine, le beffe che le donne fanno ai mariti, ecc. – e dar vita a una narrazione che rispetti allo stesso tempo l’estetica e l’etica.
Nel Decameron nasce una nuovo tipo di letteratura: una letteratura del piacere che si contrappone a una letteratura della penitenza molto diffusa durante e dopo la grande peste. E la parola, attraverso il racconto orale, è la base di questo cambiamento letterario.
Nell’Otello la parola è invece usata per distorcere la realtà. Per confondere, per ingannare. Altro che diletto. La lingua di Iago diventa la maggiore antagonista di Otello. Iago non agisce, parla. E attraverso le parole instilla nel Moro il germe della gelosia, facendolo muovere in un mondo che non ha più nulla di reale. E che terminerà con l’omicidio della moglie Desdemona. In questo senso non è un caso che l’ultima battuta di Iago sia: «Demand me nothing: what you know, you know: From this time forth I never will speak word» [Non domandatemi nulla: quello che sapete, sapete. Da questo momento non proferirò parola].
Ma la parola in Shakespeare può essere sì inganno, ma anche altro. Come dimostra l’ingenuo Otello che appare separato dalla realtà vivendo nel racconto delle sue gesta. Anche Otello è quindi soprattutto parola. E inizialmente parla in maniera armonica ed elegante. Iago finirà per penetrare prepotentemente anche in questo mondo: non solo distrugge la psiche dell’antagonista ma anche la bella sintassi del Moro, che andrà in frantumi, facendosi contorta e complessa.
Infine Old Boy, ovvero il film che Quentin Tarantino, presidente di giuria a Cannes 2004 dove la pellicola sudcoreana ha vinto il Grand prix, avrebbe voluto girare. E il regista di Kill Bill è evidentemente uno che di vendetta se ne intende. Oh Dae-su è un uomo normale. Ma nel 1988 viene improvvisamente rapito. Passerà quindici anni in una cella, con la televisione e gli esercizi fisici come unica compagnia. Un periodo che sfibrerà la sua mente e che irrobustirà il suo fisico. Quando improvvisamente viene liberato, cominciano a ronzargli in testa le domande e il desiderio di vendetta: perchè quei quindici anni di reclusione? Chi lo ha voluto? E per quale motivo è stato poi liberato?
Inizia così un complesso viaggio a ritroso nel tempo. Quando Oh Dae-su era ancora uno studente di liceo aveva visto per caso Woo Jin, il suo carceriere, mentre si apprestava ad avere un rapporto sessuale con la sorella. Un amore incestuoso che viene raccontato che passa di bocca in bocca. Un pettegolezzo che in poco tempo fa il giro della scuola. Come spiega Woo Jin: «La voce che hai messo in giro si è ingigantita. Dicevano che era incinta. Mia sorella si è fatta talmente travolgere che ha cominciato a crederci. Addirittura non ebbe più le mestruazioni e le si gonfiò la pancia. Strano vero?».
Circostanza che indurrà la giovane al suicidio. Ma il centro del film non va cercato nell’amore incestuoso. Ecco infatti la frase più importante della pellicola: «Per colpa della tua lingua mia sorella è rimasta incinta. Non è stato il cazzo di Woo Jin ma la lingua di Dae-su». La ragazza non è rimasta incinta durante, o comunque a causa del rapporto sessuale. Oh Kwang-rok è rimasta incinta dopo che la confidenza di Dae-su, ingenua, buttata lì senza enfasi a un amico, ha cominciato a ingigantirsi. Fino al punto di non ritorno: un’auto-suggestione talmente forte da provocare una gravidanza isterica.
La parola che ancora una volta provoca una morte. Desdemona prima. Oh Kwang-rok adesso. In Shakespeare il manipolatore Iago. Qui un inconsapevole Dae-su che non a caso cerca di espiare la propria colpa tagliandosi la lingua con un paio di forbici.