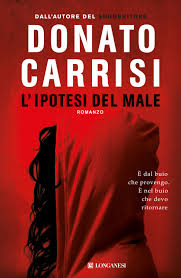L’auto del ragioniere era carica all’inverosimile, schiacciata da un arrugginito ma robustissimo portapacchi in ferro grezzo, buono per tener fermi e sollevati quei leggendari valigioni estivi di conserve, e vino di casa, e taniche d’olio d’oliva, in quantità tali da riempire un bunker nucleare, più che la piccola cucina a tre fornelli elettrici di un essenziale e asettico miniappartamento per villeggianti.
Il quartiere aveva già preso a svuotarsi da qualche giorno, e gli ultimi vacanzieri avrebbero abbandonato la città, e i suoi fiumi di asfalto rovente, entro quella mattina.
Erano le tre di notte per Ettore, che se ne stava lì, annoiato, affacciato alla finestra della sua piccola abitazione a respirare la città d’agosto. Erano le tre di mattina, invece, per la famiglia del ragioniere, alle prese con la partenza intelligente, pronti ad affrontare ore e ore di macchina, che li avrebbe condotti senza traffico alla tanto agognata meta balneare, da qualche parte verso sud.
L’auto partì nel silenzio, e quella strada non fu mai più così sgombra di macchine e generosa di posteggi. Ettore tornò dentro, dove il ventilatore acceso arrancava. Il materasso era nudo, senza lenzuola, la televisione accesa a basso volume a fargli compagnia. Come ogni estate trasmettevano vecchi film in bianco e nero, roba che d’inverno, in prima serata, nessuna emittente si sarebbe sognata di passare.
Quella notte era il momento de Il Gaucho, di Dino Risi.
Ettore si lasciò cadere sulla branda cigolante, a pancia sotto, cercando di forzare gli occhi a chiudersi, per tentare così di addormentarsi. Era dall’inizio dell’estate che viveva segregato lì, nella sua stanza, con indosso pantaloncini e canottiera. Era un tipo solitario Ettore, nessun amico, poche parole. Dal giorno del suo licenziamento, non aveva avuto più alcun impulso a uscire di casa, e nessuno mai, a parte il portiere per la consegna delle bollette, e la signora Augusta per la spesa, aveva bussato alla sua porta.
Alle quattro e trenta gli occhi erano ancora mezzi aperti, il sonno in quelle notti di fuoco faticava a venire, mentre la tv trasmetteva un episodio di una vecchia serie americana degli anni Settanta, tutta autoscontri, spari e inseguimenti. La domanda che Ettore si poneva in certi casi era chi stesse in quel momento guardando quel programma, come lui, da qualche altra parte della città o del paese. Quest’idea era la sola cosa che lo faceva sentir meno solo. Poi, verso le sei, ecco che il sonno sembrava arrivare, lento, trascinato. Niente e nessuno adesso gli avrebbe impedito di chiudere finalmente gli occhi, e di dormirsi così l’inutile mattinata di una giornata d’agosto.
Tutto, tranne il martellante e insistente ronzio di una zanzara.
Un’avanzata disordinata, intermittente, a disorientarlo, mentre Ettore scattava con le mani per schiaffeggiarsi senza alcun risultato, e l’insetto attorno, come aereo da ricognizione, veloce e invisibile, ad abbassarsi, per poi andar via, studiando dove scendere in picchiata per colpire. Aveva persino il sentore che quegli insignificanti insetti stessero strombazzando la Cavalcata delle Valchirie; maledetti.
E gli occhi rossi del ragazzo presero ben presto coscienza che non ci sarebbe stato riposo, almeno fino alla prossima notte.
La zanzara gli si posò per l’ennesima volta sull’avambraccio, Ettore la guardava in silenzio, da vicino, riuscendone a distinguere ogni parte. Era una bella zanzara, molto grossa, succosa. Aspettò il momento giusto, questa volta, per tentare di ucciderla, voleva che piantasse il pungiglione e che cominciasse a succhiare sangue, per prenderla di soppiatto, forse più vulnerabile mentre era occupata a sfamarsi. E sbam! Uno schiaffo potente ma lento, la zanzara riuscì a decollare prima che il colpo la raggiungesse. La cosa si ripeté in successione, e più volte la zanzara si posò sulle sue braccia per succhiargli sangue senza che Ettore riuscisse a spiaccicarla. Poi i raggi del sole riuscirono a nasconderla e il ragazzo smise di darle la caccia. Sulle braccia e le caviglie i segni di una battaglia persa senza appello, la zanzara quella notte lo aveva nettamente sconfitto.
La crema per le punture d’insetto era terminata, e l’unico sollievo che poteva procurarsi era quello di grattarsi; grattarsi in continuazione, con quelle unghie lunghe, irregolari e sporche a recidere il segno del morso della zanzara killer. Sapeva che il rimedio più semplice sarebbe stato quello di uscire di casa per andare a comprare un insetticida, oppure una soluzione corporea per tenere lontani i parassiti, ma non ne aveva alcuna voglia e allora smise di pensarci. Trascorse la mattinata spostandosi da un capo all’altro dell’appartamento, di giorno era la radio che prendeva il posto della tv. A pranzo la solita scatoletta di tonno con pomodori, una pesca gialla e una tazza di caffè. Nel primo pomeriggio, si dedicava invece alla visione di vecchi avvenimenti sportivi, classiche del ciclismo, partite di calcio degli anni Ottanta, la monografia su un grande campione di tennis. Il tutto con in mano un ghiacciolo al limone, l’unico vizio che si concedeva in quell’estate torrida. Aveva il congelatore pieno di quelle stecche di legno con attaccato su del ghiaccio al lontano sapore di agrume.
La controra la trascorreva sulla poltrona; si rese conto che era da ben due giorni che non dormiva e lasciò così che le palpebre si chiudessero lentamente, fino a quando, nuovamente, il ronzio di una zanzara lo riportò alla cruda realtà. Si convinse che fosse sempre la stessa, ne ricordava il colore, l’intonazione, i tempi, era persino cresciuta, aveva le dimensioni di un fagiolo. Passò famelica per un istante sulle sue orecchie, come a tenerlo sveglio per forza, per poi sparire nuovamente. Sembrava lo stesse osservando chissà da quanto, per sferrare così un nuovo attacco.
In seconda serata passavano Il Marchese del Grillo, con Alberto Sordi, era un ciclo a lui dedicato. Ettore ripeté compiaciuto e divertito le battute che conosceva a memoria, e festeggiò l’evento con un altro ghiacciolo al limone.
Alle due però il sonno tornò a bussare, e ricondusse così il suo corpo stanco ancora una volta sul letto nudo, per dare finalmente riposo a muscoli e pensieri. Sapeva che si sarebbe addormentato in pochi minuti e ne fu convinto fino a quando la zanzara non fece il suo ritorno. Gli si posò ancora sul braccio e, ingorda, diede inizio all’ennesimo banchetto, mentre tra i pensieri sempre più annebbiati e confusi gli venne in mente il conte Vlad, i vampiri, e se magari un po’ d’aglio e un crocefisso sarebbero riusciti a tenerla lontana, o forse un palo di frassino, merce assai più rara dell’oro nelle case moderne, arredate di mobili a basso costo, di truciolato e merda secca.
Senza batter ciglio, il ragazzo la lasciò fare questa volta, quasi invitandola a favorire, pensando che forse così se ne sarebbe andata via sazia e lo avrebbe lasciato in pace per tutta la notte, oppure che sarebbe scoppiata, con tutto quel sangue che stava poppando come una pompa idrovora. Rifece lo stesso pensiero sino all’alba, per tutte le volte che l’insetto gli si posò sulla sua pelle per morderla. Le braccia e le gambe erano colme di pizzichi in ogni centimetro della cute, ed Ettore, con gli occhi sgranati dalla stanchezza e dal sonno, che ormai non arrivava da giorni, se ne restava sulla sua poltrona senza aver più forza di alzarsi. Quella zanzara aveva cominciato a nutrirsi esclusivamente del suo sangue, e adesso se ne stava lì, attaccata al muro, grande come una noce, e un po’ appesantita dai banchetti luculliani che il ragazzo offriva a sue spese. Era di sicuro la più grande zanzara che avesse mai visto. Rimasero lì a fissarsi, Ettore avrebbe potuto alzarsi e prenderla a cuscinate, oppure ucciderla con una vecchia rivista, ma un senso di inerzia o compassione cominciarono a farsi largo nella sua mente. Inoltre, schiacciandola, avrebbe sicuramente imbrattato di rosso l’intera parete, così grossa e pesante era un bersaglio da colpire senza particolari sforzi.
Il ragazzo non mosse così un dito, e la zanzara restò in quella posizione per tutta la giornata.
Ore 15. Su un canale locale Viale del tramonto.
Ettore faticava a tenere gli occhi aperti, gli arti erano gonfi per via delle punture subite, sul viso la barba nera e incolta contrastava con il colorito pallido.
Fu allora che la zanzara si mosse per andare a posizionarsi sul bracciolo della sua poltrona. L’insetto guardò il ragazzo come incuriosito, con quella testa da alieno, ed Ettore non ebbe comunque voglia di cacciarla via. La zanzara con un balzo in avanti gli si posizionò sulla coscia, lo guardò nuovamente, quasi a cercare consenso, che la calma di Ettore pareva elargire. Prese così a succhiare nuovamente. La puntura fu questa volta più dolorosa del solito, l’animale iniziava a essere bello grosso e il pungiglione cominciava a sentirsi, proprio come un’iniezione.
Non ricordava bene se quella notte avesse dormito o meno, e neanche quelle precedenti; ormai Ettore non riusciva più a sentire lo scorrere del tempo, confuso, e in fase terminale.
Le persiane erano totalmente abbassate, lasciavano filtrare soltanto qualche stretto e netto raggio di sole. La zanzara, quella mattinata, la trascorse attaccata all’armadio, e anche se avesse deciso di andar via e di abbandonare quella casa, non avrebbe potuto più farlo poiché era diventata troppo grossa per qualsiasi fessura.
Smise di funzionare anche il vecchio ventilatore: la calma e il silenzio furono totali.
A ferragosto la maratona dei film di Totò.
Ettore aveva ormai gli occhi spenti, rugosi, non dormiva da giorni, e la zanzara gli aveva portato via molto sangue. L’unica domanda sensata che si pose fu quanti litri di sangue vi fossero in un corpo umano e per quanto ancora sarebbe potuta andare avanti quella situazione.
Quando cominciò persino a parlarle, e a rivolgerle domande sul come si sentisse in quelle mattine, la compassione verso la zanzara aveva ormai preso il sopravvento, diventata ormai unica e inseparabile amica di una lunga estate. Lei, che era sola come Ettore, e che avrebbe vissuto soltanto il tempo di una bella stagione, per poi morire.
L’insetto era ormai satollo del sangue del ragazzo, e grosso come un gatto, se ne stava sulla credenza del soggiorno a tenergli compagnia.
Cinque litri, poco più o poco meno, questa è la quantità di sangue presente nel corpo umano di un adulto. Se ne ricordò nell’ultima notte d’estate, mentre un vento fresco cominciò a soffiare da nord e la televisione smise di passare i bei film.
La zanzara, piena ben oltre della metà del vigore di Ettore, se ne stava ai suoi piedi, accucciata come un cane, quasi a vegliarlo, lei, causa della sua imminente morte e angelo dei suoi ultimi giorni.
Fece ritorno, arrancando, anche l’auto del ragioniere, sempre più rumorosa, di notte, così come era partita, al termine del controesodo. E ancora un soffio di vento entrò nella stanza buia, le pale del ventilatore ferme presero a fare un giro, un brivido percorse il corpo scheletrico di Ettore, che dal freddo inarcò le spalle e si abbracciò da solo come per riscaldarsi.
Con un balzo, l’enorme insetto raggiunse dapprima le sue ginocchia e, come un rapace addomesticato, poi la sua spalla.
I due si guardarono, Ettore, dal volto rassegnato e silente, lasciò scappare via un flebile sorriso e adagiando la testa su un lato della poltrona quasi invitò l’amica a favorire. Fu allora che la zanzara infilò il pungiglione nel suo collo, lentamente, quasi per non fargli del male, per tirar via così le ultime gocce di sangue che ancor lo tenevano in vita.
Gli occhi di Ettore, finalmente, si chiusero in una lenta e dolce dissolvenza, abbracciando il sonno tanto agognato.
Le notti di Cabiria di Fellini fu l’ultimo film che passarono quell’estate.
La zanzara aspettò anch’essa la morte accanto al suo amico, che non tardò ad arrivare con la prima notte di gelo.