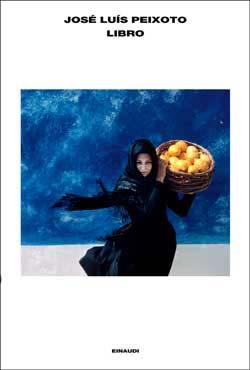«Forse tutta l’Italia va diventando Sicilia […] Gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su, verso il Nord, di cinquecento metri, mi pare, ogni anno… La linea della palma… Io invece dico: la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato… E sale come l’ago di mercurio di un termometro, questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali: su su per l’Italia, ed è già, oltre Roma… »
È Leonardo Sciascia a scrivere queste righe tratte da Il giorno della civetta, anno 1961.
Cinquantadue anni sono trascorsi dalla pubblicazione di questo importante libro, il più venduto e celebre dell’autore siciliano. Queste sue parole, queste sue considerazioni sono ancora fonte di riflessione e di ispirazione per tanti. Di indagine, di lotta e di impegno per altri ancora.
Un’opera “contemporanea” perché nulla è cambiato. Profetica, perché anticipatrice di tempi e storie. Linee che collegano, lineamenti che uniscono luoghi all’apparenza distanti, tratti, segmenti, strisce, tracce sparse che dal Sud, dalla Sicilia, dalla Campania e dalla Calabria arrivano al Nord Italia, a quella Milano considerata oggi «la capitale economica della ’ndrangheta», fino all’Europa e anche oltre. Il tutto, inquinando e diffondendo quel nauseabondo olezzo di malaffare ben al di là dei confini entro i quali si tendono usualmente a ingabbiare.
Lineamenti – I nuovi volti e confini delle mafie è lo spettacolo ideato, scritto e interpretato da Consuelo Cagnati e Andrea Maurizi del Teatro delle condizioni avverse, che Flanerí ha visto in anteprima al Teatro Tordinona di Roma e che sarà prossimamente in scena il 22 giugno a Viterbo, il 26 a Belluno e il 27 a Vicenza. Queste le date certe, ma Lineamenti, realizzato in collaborazione con Libera, l’associazione antimafia fondata da Don Luigi Ciotti, è uno spettacolo teatrale indipendente e nuove date si aggiungeranno successivamente. «Saremo in scena tutta l’estate» garantisce Consuelo che abbiamo incontrato dopo lo spettacolo. Dalla storia di Peppino Impastato, inoltre, è tratto un altro spettacolo della stessa compagnia e degli stessi autori, Malacarne, il 23 e 24 giugno in scena rispettivamente a Lecce e Taranto.
Passione e dedizione sono gli elementi caratterizzanti di chi lavora e fa teatro indipendente. Quando si parla di teatro civile, e antimafia per giunta, parlando di storie e cose concrete, elencando nomi e numeri, le difficoltà aumentano. Lineamentiè liberamente tratto da due libri importanti: Alveare – Il dominio invisibile della ’ndrangheta del nord di Giuseppe Catozzella (Rizzoli) e Gotica – ’ndrangheta, mafia e camorra oltre passano la linea di Giovanni Tizian (Round Robin).
Uno stile di scrittura e messinscena che ricorda quello inaugurato proprio da Peppino Impastato con la sua Radio Aut a Cinisi e il suo prendersi gioco di «mafiopoli». Palco spoglio, fondo nero, due piccole scale rosse, un asse di legno, alcuni nastri bianchi e rossi, una caffettiera e pochi altri oggetti sono gli unici elementi che accompagnano i circa sessanta minuti di Lineamenti. Il tutto intercalando momenti di satira e sberleffo ad altri più seri. Consuelo, che preparazione ha la stesura di un copione così denso?
Per evitare di mettere troppa carne al fuoco abbiamo scelto di individuare alcune macro aree, degli argomenti di partenza, dai quali poi tirare le linee della nostra rappresentazione. E quindi: speculazione edilizia, video poker, malasanità, e poi i Comuni sciolti per mafia, il caffè… Il paragone con Peppino ci lusinga. Quello della irrisione sarcastica era proprio lo strumento che lui e i suoi compagni interpretavano in quegli anni nella piazza di Cinisi contro Tano Badalamenti, il boss del paese. Alternando momenti più divertenti recitati da Andrea, come l’improbabile capocosca incappucciato della banda della Magliana incapace dei riti ancestrali con santini e puncicate nello stile di Cosa Nostra, e i miei monologhi più seri abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio. Mettere in scena uno spettacolo così e recitarlo è anche semplice per chi fa teatro. Scriverlo è stato più complicato. Tante interviste, studio, letture. Quando abbiamo capito che avevamo bisogno di due storie “calde” ci siamo rivolti a Tizian e Catozzella.
Il teatro civile è narrazione ma anche informazione. Per catturare il pubblico ci vogliono storie forti, appunto, e una messinscena accattivante…
Avevamo bisogno di personaggi che si muovessero all’interno di una situazione e che man mano raccontassero le varie problematiche in prima persona. L’asse portante dello spettacolo sono le due storie di Giovanni e Giuseppe, racconti di vita vissuta, del lavoro quotidiano di due giornalisti che con il loro bagaglio di origine meridionale, arrivano al nord, Emilia e Lombardia, e notano che anche in questi luoghi le cosche sono padrone del territorio.
Le storie di Giovanni, calabrese e figlio di vittima di mafia, e poi quella di Giuseppe, che racconta di suo padre immigrato sardo che già negli anni ’60 fa il cameriere in un grande hotel e si ritrova, lui innocente e stoicamente contrario, circondato da colleghi affiliati alle ’ndrine. È qui che vi è venuta in mente la celebre metafora della linea della palma di Sciascia?
È stato automatico il collegamento. Le linee della palma, del caffè forte e del caffè concentrato. Lo stesso Tizian parla di linea gotica nella sua inchiesta. E da qui è sorta l’idea di un palco spoglio e tante linee e nastri, e assi, come meccanismo narrativo. E poi il caffè… Ecco proprio l’apparente innocenza di una cosa per noi italiani normale e quotidiana come il caffè è fortemente significativa in ambienti mafiosi. «La mafia sta nel caffè del mattino», dico a un certo punto di un mio monologo, in una frase tratta da Alveare di Catuzzella. Il caffè, infatti, in molti territori è monopolio dei boss. A volte ne gestiscono la produzione, altre solo la distribuzione e lo impongono ai commercianti. C’è poi il carattere simbolico dell’apparentemente banale «offrire un caffè» che in Sicilia, come in Calabria e Campania il mafioso ti offre e assume un significato quasi di affiliazione. Stesse costrizioni si hanno con le macchinette del video poker imposto in bar e locali.
Tutti elementi che vengono condensati in appena un’ora intensa di messa in scena, dove citate, con abili stratagemmi satirici, anche Andreotti e le inchieste che toccano personaggi vicini a Berlusconi, come lo stalliere Mangano e Dell’Utri, legati alla nascita di Forza Italia.
Il nostro obiettivo era quello di “toccare” con la battuta dei monologhi di Andrea le indagini su “pezzi grossi”. «Oggi le mafie non cercano più i politici da corrompere. Si candidano direttamente loro» diciamo, citando Piero Grasso, nello spettacolo.Poi ci focalizziamo, però, sulle storie tangibili e reali che raccontano Giovanni e Giuseppe nelle loro inchieste dove la mafia calabrese, silenziosa, nascosta, poco eclatante rispetto a siciliani e campani, è invece la più inserita ed efferata. Infine, il tocco di speranza con il capitolo dei beni confiscati alle mafie che sono la grande vittoria di Libera e della lotta alla mafia. Che sequestra i beni ai mafiosi. Luoghi a cui viene data nuova vita, dove i giovani possono incontrarsi e raccontare anche queste storie, storie di legalità, storie di persone semplici ma eroiche, che quando vengono rivelate ai più giovani, nelle scuole, negli oratori, e in altri punti di aggregazione, formano le coscienze e gli uomini e le donne del futuro. Giuseppe Catozzella e Giovanni Tizian sono i due giornalisti che con i loro libri hanno reso possibile questo copione e questo spettacolo. Non tanto, però, per le cronache che raccontano, quanto per i motivi che li hanno spinti a raccontarle. Lineamenti non parla solo di loro, perché «ognuno di noi ha una quota di responsabilità», come dice Don Ciotti, «questo spettacolo parla di tutti noi. Parla della nostra quota, di cui dobbiamo farci carico, affinché non ci siano più eroi solitari».
Giovanni Tizian, 30 anni, giornalista della Gazzetta di Modena, Narcomafie è dallo scorso 29 dicembre sottoscorta per il suo libro Gotica, nel quale racconta delle infiltrazioni della ’ndrangheta in Emilia. Il padre Giuseppe è stato ucciso nel 1989 a colpi di lupara a Locri, perchè era banchiere onesto e non aveva voluto far favori ai clan.
Giuseppe Catozzella, ha 37 anni, collabora con L’Espresso e tiene un blog sul sito de Il Fatto Quotidiano. Del suo ultimo romanzo-inchiesta, Alveare, la casa di produzione cinematografica Wildside ha acquistato i diritti cinematografici, e sono stati tratti tre differenti spettacoli teatrali.
Lineamenti – I nuovi volti e confini delle mafie
di e con Consuelo Cagnati e Andrea Maurizi
Prossime date:
22 giugno – Sala Gatti – Viterbo,
26 giugno – Piccolo Teatro Pierobon di Paiane– Belluno
27 giugno – Parco Retrone ai Ferrovieri– Vicenza