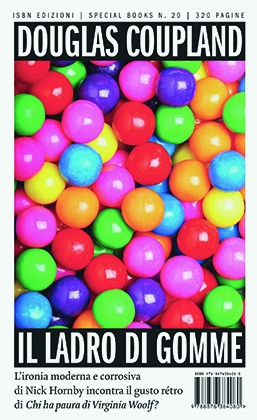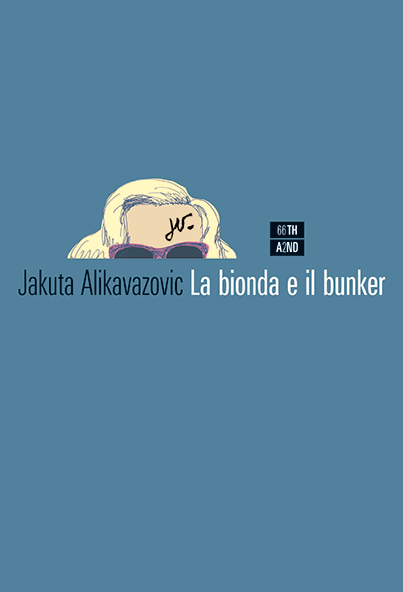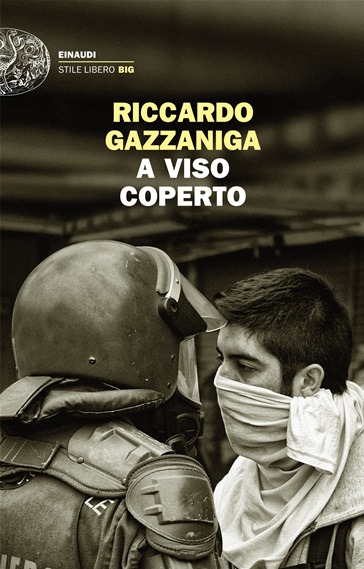Dopo aver fatto il suo esordio in Italia lo scorso anno con Fuga in blu (Transeuropa, 2012), Jakuta Alikavazovic torna in libreria con La bionda e il bunker (66thand2nd, 2013). Un romanzo, o meglio un enigma: Anna, fotografa, una bionda irresistibile; John, l’ex marito, scrittore; una fotografia che scatena inevitabile attrazione e gelosia, una collezione d’arte perduta, un amore nascosto, un copriletto blu. Questi, e molti altri, i tasselli con cui la scrittrice francese compone il suo rompicapo, sfiorando il genere noir e coinvolgendo il lettore nella ricerca di qualcosa di impalpabile: una forma d’arte, un mito, forse un segreto da nulla. Con una scrittura che unisce la precisione chimica alla perenne sensazione di disorientamento, di inganno, La bionda e il bunker è un meccanismo estetico perfetto.
Ne abbiamo parlato con l’autrice in occasione del Salone del Libro di Torino:
Avendo letto La bionda e il bunker dopo Fuga in blu, pubblicato in italiano lo scorso anno, ho avuto l’impressione che molti aspetti, sia per quanto riguarda la struttura sia il contenuto del libro, fossero analoghi, marcassero una sorta di percorso comune, sei d’accordo?
Mentre scrivevo questo libro, La bionda e il bunker, avevo l’impressione di scrivere qualcosa di completamente nuovo per me, e poi, una volta arrivata in fondo, quando ho cercato di leggerlo come un lettore e non come uno scrittore – o almeno quando ho tentato di farlo, perché non è facile – mi sono resa conto di tutti gli aspetti che il romanzo aveva in comune con Fuga in blu. Soprattutto a livello di struttura, perché per esempio la metafora architettonica è presente anche lì, e non so bene perché. Sai, è strano, perché so perfettamente di giocare con le mie stesse ossessioni, ma poi non sono conscia di come funzionino. Non so, potrebbe suonare un po’ naïf, ma forse questo è esattamente ciò che si intende per “stile” di uno scrittore: quando non si è consci di ciò che si sta facendo, ma in fondo si fa sempre la stessa cosa.
Certo. La mia prima domanda riguardava appunto l’architettura, perché mi sembra che la metafora di fondo influenzi ovviamente la struttura del libro ma anche il suo contenuto. Ad esempio: la scena in cui si descrive il Centre Pompidou è splendida, sembra di essere realmente lì, immaginare l’edificio in ogni sua parte, proprio come nel prologo di Fuga in blu, sulla costruzione del cinema Londra-Luxor. Quindi, mi chiedevo qual è l’importanza che dai a questa metafora architettonica, e se ti ha aiutato in qualche modo a sviluppare la storia stessa.
Sì, credo proprio di sì. Ovviamente è qualcosa che penso in retrospettiva, quando rifletto sul lavoro svolto. Credo davvero che sia utile, si tratta di vedere il romanzo stesso come se fosse un edificio, e il lettore fosse in grado prima di tutto di vederlo da fuori, proprio come si fa con la facciata di un palazzo o un monumento. È proprio ciò che offre la parte visuale o fotografica della scena, e credo che spieghi in qualche modo anche la freddezza dei personaggi, a livello superficiale. Quindi, all’inizio lo si vede da fuori, dall’esterno, e poi, se faccio il mio lavoro come si deve e il lettore accetta ciò che sto cercando di creare, sarà in grado di entrare nel romanzo e abitarlo come farebbe con un edificio. A quel punto la prospettiva cambia, radicalmente, e si vede il tutto da un punto di vista differente.
Questa è una prima spiegazione, poi c’è il fatto che ho letteralmente bisogno di marcare il mio territorio in quanto scrittrice. Non intendo a livello di mondo letterario, ma semplicemente per quanto riguarda me e la mia scrittura: dare una geografia al territorio sconosciuto di ciò che posso e non posso fare. Ora credo di aver trovato una sorta di comfort zone, e quello che cerco di fare è spingermi ogni volta al di là di questi confini.
Oltre a quella macroscopica, c’è anche una microarchitettura, quella che delimita l’ambiente prettamente letterario, no?
Sì, ed è ovviamente molto importante, addirittura dal punto di vista materiale: ad esempio, la libreria, così importante in Fuga in blu, dovrebbe essere realmente presa come una biblioteca ideale. In questo romanzo, forse, ci sono più riferimenti più diretti ad altri scrittori, ad altri romanzi. Per esempio, tutta la parte ambientata alla pensione Ritzi, a Venezia, è una sorta di omaggio a Il grande sonno di Raymond Chandler. Una delle prime scene, quella in cui Marlowe incontra il generale Sternwood nella serra, hai presente? Ho voluto creare al Ritzi la mia serra personale, più fredda, umida, e blu. Ecco, questo colore, il blu, è un altro di quegli aspetti che tornano sempre.
Spostiamoci invece sui personaggi: ancora una volta, in entrambi i romanzi, le figure femminili sono il fulcro principale della storia, ma non appaiono mai veramente in primo piano. Mi spiego: pur essendo protagoniste a tutti gli effetti delle vicende narrate, sono sempre ritratte dal punto di vista di qualcun altro, in particolare Anna, la bionda. Sono sempre come assenti, sfuggenti, misteriose.
È vero, anche se non so spiegarti con precisione per quale ragione. Senz’altro sono interessata al modo in cui la femminilità è costruita a livello sociale ed estetico, parafrasando forse Simone de Beauvoir: «On ne naît pas femmes: on les devient».
In qualche modo, è la mia esperienza di donna, o meglio di ragazza, che guarda le altre donne, con la perenne sensazione di non essere ancora arrivata a quel punto, di non essere ancora abbastanza. Credo che tutto al giorno d’oggi sia costruito in modo da spingere le ragazze e le donne stesse a desiderare un’approvazione sociale della femminilità, che corrisponde a un ideale costruito dal marketing.
Credo derivi dall’uso delle immagini nei film, immagini di desiderio e di donne ritratte come oggetti del desiderio, proprio come la foto di John nel libro. Nei miei romanzi però il soggetto deve sempre tornare in primo piano, lotta per tornare in primo piano ed esprimersi. Fuga in blu, per esempio, non voglio rivelare troppo, ma si conclude con la protagonista che finalmente è capace di affermare se stessa e di creare qualcosa, alla fine. Questo romanzo, invece, di cui voglio rivelare ancor meno, alla fin fine è tutto centrato su una donna che letteralmente ruba la scena, e decide che è la creatrice di qualcosa, non voglio dire cosa.
Il romanzo è una sorta di puzzle anche per quanto riguarda i generi letterari: narrativa, saggistica, noir, certi capitoli potrebbero essere letti come racconti brevi. Inoltre, quando Gray inizia a leggere il romanzo di John si instaura una sorta di gioco meta-letterario. È molto composito, come spieghi questa scelta?
È vero per tutto ciò che scrivo, specialmente in quest’ultimo romanzo. Gioca molto con i riferimenti alla realtà, con i diversi generi, c’è uno spunto noir, ma è anche una storia d’amore, c’è della saggistica, ecc. È come se riflettesse il mio stato d’animo quando inizio a scrivere un libro, quando improvvisamente tutto diventa cibo per il libro stesso. C’è un mistero al fulcro del romanzo, e funziona in qualche modo da campo magnetico, può attrarre al suo interno qualsiasi cosa, trasformando tutto in materia narrativa.
Inoltre, i riferimenti a personaggi realmente esistiti e alla mitologia formano una parte importante dell’ossatura del romanzo. Ti ha richiesto molte ricerche?
Sì, ho fatto svariate ricerche prima di iniziare a scrivere il libro. Poi ho presto a scrivere basandomi su quanto ricordavo, cercando di lasciare da parte le nozioni vere e proprie. In realtà, mi hanno fatto notare che ci sono anche un paio di errori, ma è perché scrivevo quello che ricordavo, senza tornare indietro a verificare.
La bionda e il bunker, inoltre, si compone di tanti brevi capitoli che intrecciano punti di vista, momenti e storie diverse: hai scritto il romanzo così come è stato pubblicato o questo ordine è frutto di un lavoro successivo?
In realtà sì, ho scritto il romanzo proprio in quell’ordine, saltando da una storia all’altra, da un personaggio all’altro. È stato molto strano, ma è stato un bel momento: vivevo praticamente come un’eremita, mi sono letteralmente chiusa in casa, per concentrarmi, come in un bunker, appunto (ride, ndr). E la struttura del romanzo mi ha completamente assorbita: era come danzare con il libro, come se mi conducesse in un ballo. Non ho scritto molti libri, ma questa sensazione è tra le più belle che si possano provare, ne divento quasi dipendente, perché so che finirò per scoprire qualcosa, su me stessa e sul libro. Entro in uno stato di concentrazione tale che non ha nulla a che vedere con la vita di tutti i giorni, è qualcosa di molto particolare.
Nel romanzo appaiono inoltre svariate forme d’arte: fotografia, architettura, scrittura… È come se il fulcro stesso della narrazione fosse l’idea di conservazione dell’arte: è davvero possibile? Credi che la scrittura stessa sia a suo modo una modalità di conservazione dell’arte?
Non saprei, ma sì, credo ci sia una vera tensione tra la volontà di mantenere le cose in salvo dalla distruzione e dalla decadenza, e l’inevitabilità della perdita. In fondo sono una romantica, quindi per me non si tratta solo di conservazione dell’arte ma anche dei sentimenti, dei sentimenti e delle relazioni, due aspetti in qualche modo equivalenti nel libro. Arte e amore diventano praticamente l’una lo specchio dell’altra. Quindi, a sopravvivere è solo il forte desiderio per qualcosa o qualcuno, e credo che i luoghi più sicuri dove possa sopravvivere siano la mente e il cuore dell’uomo. È un concetto melanconico, ma non privo di ottimismo: siamo tutti portatori di qualcosa di prezioso.
Per quanto riguarda la scrittura: sì, sono molto attaccata alla letteratura, non che per me sia un feticcio, o forse sì, lo è davvero (ride, ndr). Sai, diventare scrittore significa avere del tempo – che significa anche ovviamente avere una certa somma di denaro a disposizione –, non si ha bisogno di materiali specifici, non si ha bisogno di nulla di particolare. Quindi in linea di principio potrebbe farlo chiunque e significa creare qualcosa da zero. Quando poi il libro viene pubblicato, esce in un certo numero di copie, quindi è qualcosa di unico, ma allo stesso tempo non è unico. Una cosa che mi affascina tantissimo sono i libri antichi, usati: sono solo oggetti, ma il messaggio che contengono sopravvive. È come dopo un naufragio: certe cose vengono a galla, altre restano sommerse per anni, poi all’improvviso spuntano. Ed è incredibile che esistessero, che quel libro esistesse, magari quarant’anni prima che nascessi.
Cosa pensi della letteratura europea in generale e francese in particolare? Ti senti più affine a qualche autore specifico, hai modelli a cui ti affidi?
Be’, ci sono autori che amo, davvero, con cui ho stabilito una sorta di partnership. Autori europei, e ovviamente anche francesi. Ora però ciò che voglio più di tutto è trovare la mia voce, allontanandomi anche dagli scrittori che ammiro di più e fare il mio percorso. Con umiltà, ovviamente. È la stessa cosa che faccio quando devo fare ricerche prima di scrivere un libro: poi cerco di liberarmi delle informazioni accumulate, e lavorare solo sui ricordi che ne ho.
Stai lavorando su qualcosa di nuovo al momento?
Sì, ho appena iniziato a lavorare a un nuovo libro, ma ho iniziato da così poco tempo che non ne saprei proprio dire nulla: potrebbe cambiare tutto. Sai, di solito si ha un’idea del libro che si sta affrontando, se sarà lungo o corto, per esempio… Ecco, in questo momento non saprei dirti nemmeno questo (sorride, ndr).

(Jakuta Alikavazovic, La bionda e il bunker, trad. di Elena Sacchini, 66thand2nd, pp. 187, euro 15)