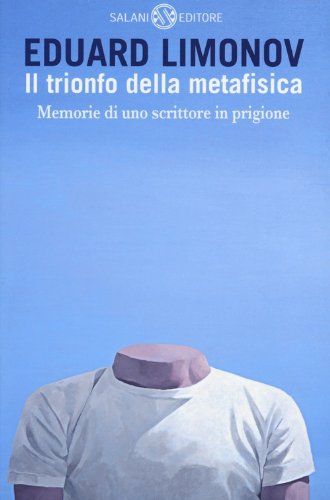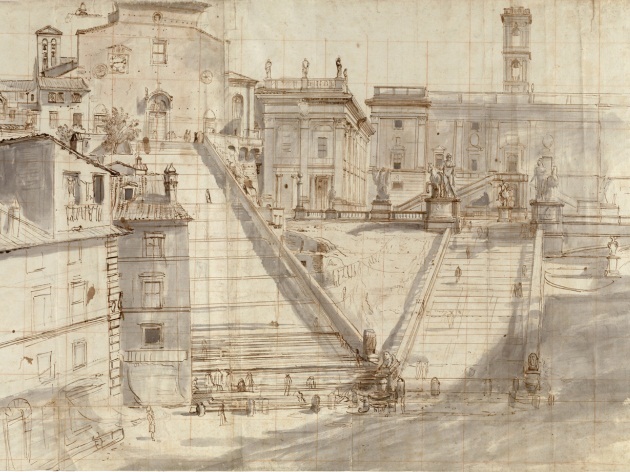Dopo il frastuono, i toni esagerati, le parole spese un po’ alla buona senza che dell’autore fosse mai stata letta una riga, forse è il caso di leggerselo un libro di Eduard Limonov e stare un po’ ai testi. L’opera che gli ha dedicato Emmanuel Carrère (Limonov, Adelphi, 2012) si è naturalmente giovata (tranne rari casi) delle prodezze del personaggio, sì da catturare un pubblico di lettori decisamente ampio. Lo scrittore francese raccontava la vita di quest’uomo sospeso fra Mosca, Parigi, New York e i Balcani in guerra e una montagna di guai spesso deliberatamente cercati. Una biografia romanzesca in sé, per qualità intrinseche al personaggio (un uomo che «mette insieme più vite di quelle di Plutarco»: dall’introduzione di Maria Candida Ghidini), prima che all’opera dell’ottimo scrittore francese, che però forse non ha contribuito granché alla conoscenza dei testi di Limonov, essendo uno di quei casi in cui il troppo dell’autore empirico rischia di venir meno alla verifica dei testi e quindi di deludere (per tacere della tendenza a spettacolarizzare il fatto letterario e di accontentarsi deliberatamente della “scena”).
Un buon libro per misurare l’apporto concreto di Limonov alle storie letterarie può essere Il trionfo della metafisica, tradotto in italiano da Salani. Lo scrittore russo, autodefinitosi nazi-comunista, arrestato con l’accusa di terrorismo (avrebbe creato «una banda armata illegale») vi racconta la sua esperienza di detenuto (zek) in una colonia penale i cui tratti sembrano discendere dritti dritti dalla storia (anche letteraria) del suo immenso e per certi versi terribile paese.Storie di steppe lontane dal mondo in cui non molto diversamente dai gulag stalinisti si giocano i destini di criminali veri o presunti, ma anche di carnefici, spie e aguzzini. Tra fatiche e umiliazioni, prove efferate cui i detenuti vengono sottoposti con la ferma intenzione dei carcerieri di annullarne ogni volontà, si affacciano sulla scena vari personaggi che Limonov, sempre tentato da un certo eroismo estetizzante, racconta con apprezzabile sobrietà.
Sbruffone lo resta sempre, l’ego tracima senza sosta, ma al netto di questa spuma, il racconto tiene e così la descrizione del sistema concentrazionario, degli uomini che lo popolano. Non poche nell’abiezione della colonia penale le tempre solidissime che suscitano la sua ammirazione. Proprio sul versante di una durezza autoimposta, di una disciplina più mistica che militare – da buddista – il narratore-personaggio si guadagna il suo diritto alla sopravvivenza. Una sfida non priva di ragioni: quelle che un individuo non disposto a rinunciare alla propria dignità di uomo oppone al mero arbitrio del potere. Ché in fondo, il sedicente nazi-comunista Limonov sembra molto preoccupato della libertà dei singoli. E ci racconta come il suo un paese libero non lo sia mai diventato. Limonov non gli risparmia nulla, e anche questo lo si immaginava conoscendo le sue eccentriche e cortocircuitate posizioni politiche. La registrazione del mondo carcerario dice a sufficienza dell’idea della vita umana che si ha dalle parti di Mosca – se vale il noto principio che dallo stato delle carceri si comprende il livello di democrazia di un paese. Sull’argomento in Italia qualcosa da dire non mancherebbe. Così, se Putin si mostra sensibile ai consigli di Berlusconi in materia di televisione – come raccontano le cronache recenti – è immaginabile che l’ex agente KGB ne sapesse abbastanza da solo, se è vero, come scrive Limonov, che nella colonia penale «il notiziario televisivo è obbligatorio».
(Eduard Limonov, Il trionfo della metafisica. Memorie di uno scrittore in prigione, trad. di Giulia de Florio e Elena Freda Piredda, Salani, 2013, pp. 250, euro 16)