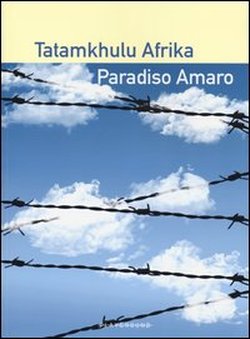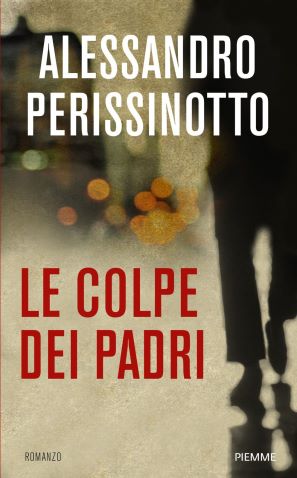La conservazione metodica del dolore (Einaudi, 2012) è il primo romanzo di Ivano Porpora, un giovane autore che prova, con il suo libro, ad attraversare l’articolato tessuto della sofferenza umana.
L’opera – presentata dalla casa editrice in un’elegante veste grafica arricchita da una meravigliosa tavola in acquerello di Gipi – è un viaggio tanto difficile quanto affascinante nell’animo umano, in cui realtà e sogno, malattia e salvezza, rassegnazione e slancio sono strati diversi di un unico magma che brucia sottopelle e che ci lancia addosso quel senso di miseria che solo la linea sottilissima che divide la vita e la morte può darci.
La storia si può riassumere in un uomo, Benito, che soffre di una delle malattie più “infami”: l’epilessia. Una malattia che ha cancellato una parte della sua storia, circa dieci anni. Ora ha l’occasione della vita, una mostra fotografica che può aiutarlo a riprendere per mano il “presente”.
Tra le molte domande che mi vengono in mente per l’autore, ce n’è una che vorrei fargli in particolare e che gli rivolgo immediatamente.
Se, da quanto ho capito, non c’è nulla di autobiografico in questo libro, dove hai trovato la forza di intraprendere questo “viaggio” nel dolore? Con che parole definiresti questo libro?
La definizione migliore l’ha data finora Andrea Gentile parlando di «letteratura necessaria». Non è che non ci sia nulla di autobiografico: ogni libro, forzosamente, parla del me. In questo caso sono dovuto venire a patti con la mia epilessia, più pietosa di quella di Benito ma non per questo di finzione –; è che a un certo punto ho capito che, volendo investigare a fondo le mie possibilità di scrittura, l’unica strada possibile stava nel setacciare il mio territorio inesplorato. Questo mi ha portato a una sofferenza che non auguro a nessuno, a riscoprire ferite lontane e che sanguinavano ancora, ma anche a nuove possibilità.
Lo stile del libro è ondivago come ondivagaè la narrazione. Tutto sembra realizzato per affondare nello stomaco più che nella testa. Eppure non cadi mai nella tentazione di colpire a effetto. Questo è un merito, lo sai? Il tuo libro, a mio avviso, è una delle opere più complesse (e non complicate, ben intesi) uscite negli ultimi anni.
Che dire? Grazie… Non mi piacciono le opere che colpiscono alla testa. Né mi piacciono i libri facili, i libri che scorrono che è un piacere. Sarò io, ma penso che siamo già in un gran clima di facilità, di sedani sconditi. Mi piace lavorare sul brasato…
Nella tentazione del compiacimento intellettuale, comunque – a onor del vero – son caduto diverse volte; spesso l’editing, spesso il mio stesso lavoro di riscrittura mi hanno fatto lavorare di machete togliendo tutto ciò che mi causava un lieve sorriso. Ecco, diciamo che seguo questa regola: se levo un sopracciglio è un buon segno, se levo un sorriso taglio.
A proposito dello stile. Perché questa scelta di mescolare dialetti, poesie, canzoni, filastrocche? Mi permetto di intravedere, con le dovute differenze, qualche rimando in chiave contemporanea di certi andamenti, a volte persino dissociati, di un certo Gadda. In fondo anche lui ha provato a indagare il dolore.
Gadda lo conosco poco; pochissimo. Non me ne faccio un vanto, anzi: credo sia una coglioneria quella del vantarsi di non aver letto i classici. Sto semplicemente seguendo la mia strada, con diversioni e riallacciamenti a un percorso che avrei dovuto/voluto compiere e per mille motivi non ho compiuto. La scelta quindi è meno gaddiana e più, se vogliamo, vicina a scelte linguistiche proprie non solo di una letteratura ma di stili musicali (il rap in particolare), pastiches classici, di un certo tipo di ricerca linguistica (mi vengono in mente le opere teatrali di Giovanni Testori, quelle di Raffaello Baldini, quelle di Emma Dante), una certa iconografia, pure non lineare (da Max Papeschi alle fotografie di Richard Avedon a quelle di David Lachapelle), alla regia di mille registi diversi tra loro.
Sono tutte narrazioni. Se proprio devo citare un nume cui mi ispiro in merito al respiro letterario, parlo di Bohumil Hrabal. Credo che da lui cerco di trarre una commistione tra diversi registri, la capacità di frammentare il discorso e poi riunirlo. Che poi lo stile sia profondamente diverso dipende, appunto, dallo stile che è voce personale.
Famiglia e lavoro, giovinezza ed età adulta, fallimento e successo. In quale dicotomia troviamo il maggiore turbamento?
Più che in una dicotomia, in una sorta di taglio trasversale a queste voci: Famiglia, Giovinezza, Fallimento. Diciamo che le dicotomie indicate sopra son diverse tra loro perché una esprime in realtà un passaggio (giovinezza ed età adulta), una un contrasto di tipo sì/no (fallimento e successo), una la necessità di una negoziazione (famiglia e lavoro). Se mi si chiede però quale di questi settori attira il mio interesse, direi senza ombra di dubbio la prima coppia. La famiglia come luogo di fallimenti, violenze, ricordi, speranze, affetti, vincoli e doveri; il lavoro come frustrazione, guadagno, possibilità, ruolo. A ben vedere lì c’è già (quasi) tutto.
Tra flash, feedback e continue dislocazioni temporali a volte il lettore si perde per poi essere riacciuffato per i capelli quando meno se lo aspetta. I personaggi, alcuni strampalati e persino grotteschi, sembrano usciti da una certa cinematografia italiana anni Settanta. Dove hai pescato per dipingere quest’affresco così variegato?
Dalla mia testa. Ne esce sempre qualcosa di nuovo; scelgo – per capire se questo nuovo è buono – la massima secondo cui ciò che cammina coi propri piedi e segue una sua direzione (non necessariamente omogenea con quella della narrazione, ma nemmeno troppo laterale) è buono. Ci sono tanti personaggi della Conservazione che sono stati scartati perché sviavano la narrazione ma erano buoni (Fobèn e la ragazza indiana su tutti), altri che erano nella narrazione ma non erano buoni (un agente di commercio che aveva un ruolo più importante); altri che invece, proprio per il loro spessore, valicano quelle pagine (Mario e Severo su tutti).
È un po’ come un atto di equilibrismo, scrivere, un po’ come il passare sul filo del francese Philippe Petit; esiste il filo e più nulla, a un certo punto, e se quel nulla prende corpo e diventa il precipizio tra le due torri rischi di cadere.
Tornando alla cinematografia, direi che da alcuni attori e registi il libro dipende, più che prendere forza. Senza Tognazzi o Fellini, Scola o Mastroianni, la Melato o Ferreri, Olmi o Manfredi, e poi ancora Wertmüller e Vitti e Giannini e Pasolini e Noiret e Monicelli e lo stesso Gigio Alberti – su cui il fisico di Benito poggia – il libro non sarebbe, o non sarebbe così.
C’è qualche autore che senti di prendere come punto di partenza o di riferimento?
Autori ce ne sono eccome, e non solo letterari. Quindi faccio il gioco di castrarmi e prenderne solo dieci – sotto perderebbe di senso, il gioco. Per la letteratura dico Hrabal, Dostoevskij, Collodi e lo scorrimento logico/illogico di Murakami; per il teatro Nekrošius; per la fluidità di parola Frankie HI-NRG MC e Caparezza; per i giochi di parole Sergio Caputo; per il cinema Michel Gondry; per la musica Tchaikovsky. Ne ho puniti troppi e ne è venuto fuori un clima in parte falsato (non so nulla di musica classica, per dire, né ho nominato Ascanio Celestini o gli Zebda, o Neruda, o ecc.), ma va bene così.
Ormai è qualche mese che è uscito il libro. Sei soddisfatto di come sta andando? Come hanno risposto critica e pubblico? Quali sono stati l’apprezzamento che più ti ha colpito e la stroncatura, se c’è stata, che più ti ha fatto arrabbiare?
Sulle vendite non so nulla. Detto questo, le critiche sono state spesso molto positive, e questo mi fa piacere, e sempre contestualizzate, e questo è un bene. Preferisco qualcuno che mi faccia notare un problema a qualcun altro che mi dica: «Tutto perfetto». Anche perché, prendendo in mano La conservazione e Moby Dick, non ci vuole un genio per vedere dove stia il “tutto perfetto”…
La domanda che mi pongo spesso è: Dove voglio andare? E visto che so dove voglio andare, le critiche contestualizzate sono come pane per gli uccellini, qui da me. Per quanto concerne le stroncature, ne ho avuta solo una. Un’altra – più sul metodo che sul libro in sé – è diventata un’interessantissima conversazione con Giorgia Tolfo.
L’unica volta in cui ho avuto una critica a mio vedere pretestuosa – il lettore si è fermato a una frase della prima pagina, per poi chiudere il libro – ho scritto al critico, ringraziandolo comunque per l’attenzione e sperando, in futuro, in un ripensamento. Non ho ricevuto risposta.
Perché questo titolo? Chi ha proposto la copertina? Entrambe le scelte risultano davvero efficaci.
Il titolo è opera di mia moglie – segno che al contrario di quanto spesso dichiaro qualcosa di autobiografico c’è. Un giorno mi urlò, durante una discussione, che racchiudere i miei ricordi in due scatole e lì lasciarli non fosse altro che creare una conservazione metodica del dolore. Ho pensato fosse il titolo migliore per un romanzo ancora senza chiusa.
Il merito sulla copertina, invece, è tutto mio. Sono appassionato di fumetto, della concezione artistica di Gipi, mi piace leggerlo e sentirlo parlare. Da lì a contattarlo il passo è stato breve – e, concordo, molto convincente.
Ti ringrazio per l’intervista, rinnovo i complimenti personali per questo libro e ti auguro un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della promozione.
Grazie a voi, e in bocca al lupo!
(Ivano Porpora, La conservazione metodica del dolore, Einaudi, 2012, pp. 328, euro 18)