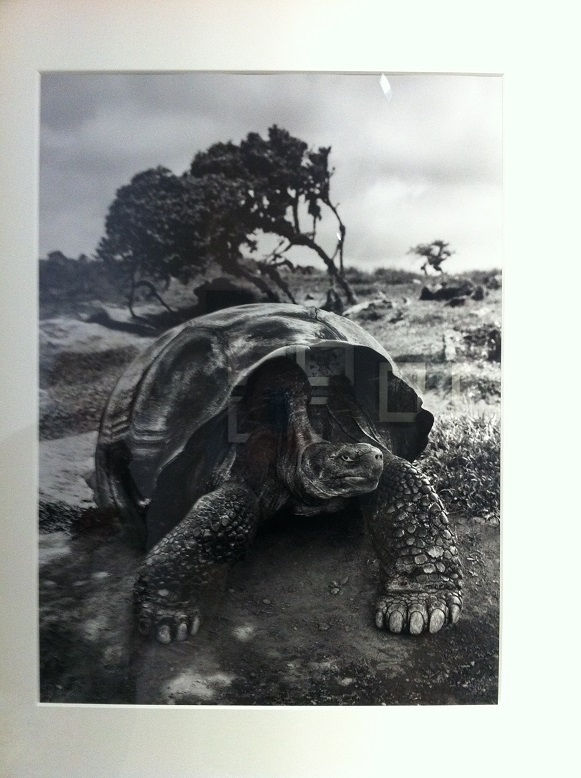Un protagonista senza nome che compie un viaggio dalla provincia italiana a sconfinate praterie americane in cui piovono frammenti dello shuttle appena esploso in cielo. Un viaggio verso un luogo, ma soprattutto verso la scoperta della storia della propria famiglia e di se stessi.
Le cose brutte non esistono (66thand2nd, 2013) è questo e molto di più, e ce l’ha raccontato benissimo l’autore, Riccardo Romani, nell'intervista che ci ha rilasciato durante il Salone del Libro di Torino.
Le cose brutte non esistono racconta, tra le altre cose, storie di guerre e di disperazione, in un filone che conduce dai reportage e dai documentari alla stesura di un libro. Un romanzo che è soprattutto un viaggio, senz’altro negli Stati Uniti, la Bosnia, l’Argentina e la provincia italiana, ma anche un viaggio dentro se stessi e attraverso la propria storia. Quanto c’è del tuo passato da scrittore di reportage, e di te stesso, nel romanzo?
Guarda, è chiaro che, con il lavoro che faccio, per anni ho accumulato immagini, emozioni e le ho messe via, le ho conservate in un archivio personale, sperando che un giorno mi tornassero buone. Quello che ho sempre pensato, fin dai primi anni, è che una cosa che accade dall’altra parte del mondo spesso ha delle conseguenze in un posto molto lontano, sempre di più nel mondo in cui viviamo oggi, soprattutto con le guerre e i conflitti. Quindi mi piaceva l’idea di portare della realtà, del realismo, all’interno di un intreccio fatto di amori, di passioni, di tristezza, di sofferenza. E questa credo sia la parte che ovviamente il reporter si porta dietro del libro. Il libro inizia con un evento che io ho vissuto veramente, l’esplosione dello shuttle [l’esplosione dello Space Shuttle Columbia, nel febbraio del 2003, che creò una pioggia di resti e detriti nel cielo sopra il Texas, ndr], una cosa surreale, e ovviamente poi c’è la Bosnia che è stato il mio primo viaggio in un teatro di guerra.
Quindi, esatto, nel libro c’è molto di me stesso pur non essendoci niente di propriamente autobiografico – anche in Argentina per esempio ho vissuto per un periodo –, ripeto, ci sono tante cose da cui non potevo esimermi, e sono in gran parte realistiche. E poi c’è invece tutta una parte che invece è puramente fictional, di fantasia.
Un altro aspetto che mi ha colpito, è che si tratta in fondo della storia di una complicata situazione familiare nella piccola provincia italiana. Una storia di genitori assenti, padri fedifraghi e di madri succubi e accondiscendenti: una realtà molto spesso sviscerata nei romanzi contemporanei. Perché sono storie che vale la pena ancora raccontare?
Perché è una microfotografia che è sempre e comunque connessa con la mondialità. È quello che dicevo prima, nel romanzo, ciò che succede a Greto, che è un paesino in provincia di Ferrara, ha delle ramificazioni che poi vanno appunto fino all’America, per esempio. Secondo me, il tentativo – riuscito o meno non lo so, ed è una valutazione che faccio dopo, a posteriori, perché prima non me ne sono mai reso conto – è quello proprio di abbattere tutta questa barriera: la provincia, piuttosto che la grande città, l’America, che non è l’America delle città, ma è un’America dove il sogno americano non viene neppure lambito, cioè viene visto solo in lontananza. È un’America poco raccontata, oppure raccontata solo per immagini.
Ecco, si tratta di questo: c’è molta più comunanza a volte tra la provincia italiana e la provincia americana di quanto noi crediamo. In fondo, un piccolo paese in provincia di Ferrara può meritare attenzione, non solo perché ci è andato a vivere uno che ha un’esperienza di un certo tipo, ma perché le dinamiche sono le stesse rispetto a un piccolo paese nel cuore del Texas, ci racconta una storia che non è proprio ingabbiata in quei determinati connotati o cliché che noi ci aspettiamo abbia la provincia italiana. Al di là delle aspettative, invece, a Greto vive un colonnello che operava in zone di guerra con generali ad alto livello, e che non è mai finito nelle breaking news – questo era il suo lavoro in realtà, non finire nelle breaking news, ovviamente. Quindi, se le basi sono queste, perché non raccontare la provincia italiana?
Mi è piaciuto molto il personaggio di Alfonso Duro (o di Javier, se preferisci), che è decisamente un personaggio atipico, come non se ne trovano molti. La mia impressione è che sia una metafora che rispecchia, credo, la parte nascosta che esiste dentro tutti noi, quella ricerca all’interno di sé che anche il protagonista deve compiere. Si tratta di una semplice suggestione o c’è qualcosa di vero?
No, è quello che io dico adesso ai lettori che ho incontrato e sto incontrando un po’ in giro per l’Italia alle varie presentazioni: c’è un Alfonso Duro anche nella tua vita, e c’è sicuramente, avrà un nome, avrà una forma; è così. Alfonso Duro è un ideale di qualcosa che noi forse nell’età dell’illusione coltiviamo, ma che poi insomma quando si cresce siamo tutti poi costretti a vedere per quello che è, è un po’ il passaggio all’età adulta.
Non lo so, lo dico adesso per la prima volta. Le cose brutte non esistono è il mio primo romanzo, quindi scopro cose nuove in continuazione, probabilmente ti sto per dire delle cose che non avrei detto un mese fa. Però Alfonso Duro sta prendendo sempre più questa forma, la forma di qualcosa di importante che io ho messo lì con una funzione che sul momento non capivo, però mi piaceva, anche perché ne ho incontrati nei miei viaggi di personaggi del genere, sfuggenti, che non capivi mai cosa facessero. E io, curioso come sono, cercavo sempre di informarmi sulle loro storie, mi per esempio è capitato di incontrare personaggi elegantissimi, non so, a Kabul, dove tutti sono impolverati, e che cosa ci fa qui questo? «No, sono qui di passaggio, sto andando a Dubai perché poi vado a Singapore». «Ma cosa fai nella vita?» «Mah, lavoro…»
Ecco, sono ideali, Alfonso Duro è un ideale che deve rimanere tale, ed è quello che forse il libro vuole comunicare, perché poi quando andiamo a scoprire gli altarini, quasi sempre avremmo voluto non cercare di capire nulla. Nel libro a un certo punto infatti si dice che la verità, in fondo, è la realtà che ci conviene, no? Spesso la verità sarebbe meglio tenerla a distanza.
Parliamo di donne. Le donne di questo libro, dalla madre del protagonista, a Senida, fino ai ruoli molto particolari di Barida e Morena, attrice americana…
Morena esiste, è un’attrice famosa, adesso ancora abbastanza famosa in Italia. Quando io l’ho conosciuta e quando lei mi ha invitato a fare quest’esperienza non lo era, perché quella era una serie televisiva dall’audience molto bassa, ma comunque abbastanza conosciuta in America, al punto da poter radunare così tanti fan. Ecco, questo lo posso rivelare, chi è non lo rivelerei mai, ma esiste, è un personaggio reale.
Si tratta comunque di donne che apparentemente molto distaccate, prive di sentimenti, caratterizzate da una freddezza che all’inizio lascia piuttosto perplessi. Tutte però nascondono qualcosa che si è spezzato dentro di loro. Cosa? E perché ha deciso di raccontare questo tipo di mondo femminile?
Dunque, principalmente perché ne ho incontrate tante, e adesso ad esempio il tema del femminicidio è anche un argomento piuttosto in auge, purtroppo, anche in Italia, se ne parla molto. Però, anche in questo caso, si tratta di un meccanismo inconscio: nei teatri di guerra le donne sono senz’altro le prime a soffrire, le prime a essere utilizzate, sono merce di scambio. E il fatto di raccontare storie di donne che hanno avuto la forza e la fortuna di uscire da quel mondo e ricostruirsi mi affascinava. Il problema è che sono donne che, appunto, come hai detto tu, sono “spezzate” in qualche modo, e in questo caso vale sempre il discorso che facevamo all’inizio, quello che è successo in Bosnia dieci anni fa non si può chiudere con una riconciliazione pubblica, con un perdono pubblico: ci sono delle conseguenze inaudite che le persone, gli esseri umani si portano appresso, e che poi causano altre conseguenze nelle persone che loro incontreranno, come in questo libro.
A volte si tratta di conseguenze inattese, per esempio Barida – che a me piace tantissimo, ne sono anche un po’ innamorato, perché è sfuggente, e mi piacciono sempre le persone sfuggenti – è una donna che tu speri che alla fine si lasci andare, ma non può, perché ha qualcosa dentro di interrotto. Il mondo è pieno di persone così e, a volte, scoprire il loro passato serve proprio a dare un senso al nostro.
E poi sono tutte donne che amo fisicamente, è ovvio, perché non le posso avere.
Un’altra curiosità, qualcosa che senz’altro ti chiederanno tutti, perché il protagonista del libro non ha un nome?
Con l’editor, Leonardo Luccone di 66thand2nd, ci abbiamo pensato a lungo, abbiamo discusso, ci siamo fatti domande. Non ho sentito il bisogno di dargli un nome. Non ho sentito quel bisogno perché un po’ i nomi mi fanno paura, e poi perché forse è una voce che volevo che rimanesse in qualche modo sollevata dal resto dei personaggi, insomma, e in definitiva perché questo è un personaggio che subisce la presenza di tutti gli altri nel corso della storia, e quindi è un po’ nella sua natura. È un personaggio che è cresciuto con un’infanzia distaccata dalla realtà, un personaggio che non sa come sia fatto il mondo finché non lo affronta, con le conseguenze che chi legge il libro, speriamo, vedrà.
Non era necessario. E poi, appunto, incuriosisce anche il fatto che non abbia un nome in fondo, non era così importante. E forse, cosa che quando racconto sciocca un po’ tutti, è anche perché in fondo non sono riuscito a trovare un nome, una connotazione idiomatica, che fosse più forte rispetto a lasciarlo senza nome.
Non sono io, comunque, questa è una cosa che mi chiedono tutti: no, non è autobiografico, non sono io.
A proposito del protagonista, mi ha colpito molto il fatto che, da uomo che subiva tutto ciò che gli accadeva, tutta la sua storia, a un certo punto durante il viaggio si trasforma: è come se non respingesse più i suoi istinti, anzi, arriva a un usare violenza su una ragazzina, quasi si trattasse di un’eredità nociva lasciatagli dal padre. Cosa scatta dentro quest’uomo per far sì che a un certo punto si compia una trasformazione del genere? E soprattutto, il fischio che lo perseguita potrebbe essere interpretato come una giustificazione metaforica di tutto ciò che compie?
Brava, tu mi hai dato una lezione, un collegamento che non avevo mai fatto, mi fa molto piacere, è questo il bello di condividere il libro con altre persone. Sì, quest’ultima cosa che hai detto è una possibilità, il fischio è una condanna, è una malattia molto seria, che io ho studiato con un caro amico che purtroppo ne è stato colpito, e lui arriva al punto di, forse usare violenza è un’esagerazione, ma comunque approfittare in maniera laida di questa ragazzina che in fondo è lì a sua disposizione, forse anche per quello. Se tu ci pensi, arriva un momento del libro in cui lui ha perso completamente le speranze, si rende conto che tutti quelli che doveva cercare non erano in realtà dove dovevano essere, e non sa più chi andare a cercare. E questa è una lettura molto umana, no? Quando tutti se ne vanno ti senti disperato e quindi in qualche modo autorizzato a fare delle cose che sono bieche.
Ma la cosa più conscia che io ho pensato, invece, è che non volevo eroi: c’era una purezza in lui che non gli apparteneva, ed è inevitabile che quando uno abbandona un luogo ovattato, come sono l’adolescenza e la gioventù, per entrare in un luogo un po’ più contaminato, com’è l’età adulta senza avere un’esperienza di vita, è inevitabile che faccia delle cose brutte, anche solo per provare come ci si sente. E poi, ricordiamolo, il padre era veramente un poco di buono, quindi forse c’è anche una questione genetica. In ogni caso, non ci sono eroi, questo è il concetto che più mi stava a cuore.
Per concludere: è vero che, come asseriva il padre del protagonista per giustificare e mitigare tutto ciò che era capace di fare, le cose brutte non esistono, e il giudizio dipende solo dagli occhi di chi le guarda? Speriamo, no?
«Spero» è l’ultima parola del libro, quindi sì, anche se il libro si è concluso così dopo tutto un lungo processo che non ricordo neanche più.
L’idea del fatto che le cose brutte non esistono, sì, è una sorte di chiave di lettura, la frase appare due volte nel libro: è una frase che il padre diceva al figlio per coprirgli gli occhi di fronte a un brutto spettacolo, che era appunto quando lui portava queste ragazze, queste sue amanti a fare certe cose, non proprio per quell’epoca lecite.
E alla fine, lui che forse rifuggiva questa visione, lui che non voleva credere a quel tipo di realtà, finisce per rifugiarcisi. Ed è una forma di sopravvivenza, in cui il fischio, questa malattia insopportabile, diventa il minore dei mali, no? Se tu riesci a credere che le cose brutte non esistono anche il fischio alla fine diventa un compagno di viaggio: dipende da noi, dipende da come vogliamo leggere le cose e da come si vuol leggere questo libro. Il mio obiettivo era il libro trasmettesse anche dell’ironia, nonostante i fatti narrati che sono molto crudi, e soprattutto speranza, perché in fondo io sono uno che la speranza ce l’ha.
(Riccardo Romani, Le cose brutte non esistono, 66thand2nd, pp. 224, euro 15)