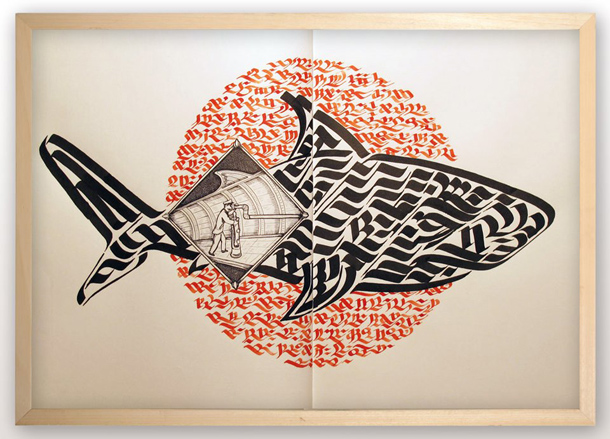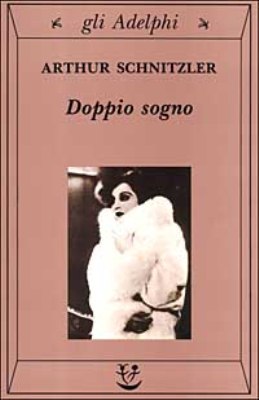Il titolo breve, un numero, un’unità di misura, quella buona per pesare le piccolissime quantità; poi un buco strettissimo e spesso introvabile, attraverso il quale Riccardo Pessione ci conduce al suo interno, varcandolo in prima persona e noi con lui, a seguirlo, circospetti. 80mg (Miraggi edizioni, 2013) è il titolo dato a quest’opera prima, è la quantità di metadone concessa dallo Stato come ultima spiaggia, come estrema possibilità di ritornar fra i “normali” e smettere così d’essere uno zombie.
Gianni Cheni ha poco più di vent’anni, JK per gli amici, che siano essi veri o presunti tali, e vive nelle periferie di Torino, sorte su dal boom industriale tutte d’un fiato, veloci e asettiche, «un brutto sogno in cemento», fatte di caseggiati di stampo democristiano e lande desolate. Pessione, qui alla sua prima prova di romanziere, subito ci immerge nel vortice dei dannati, delle anime in pena e dei corpi lacerati dalle droghe.
Tutto appare da subito sbiadito, invernale, e la nebbia e l’aria del mattino sembrano rendere tutto impercettibile. La tossicodipendenza appiattisce ogni cosa, e la vita ha un solo fine, quello di trovare una “spada” il prima possibile.
E quando la crisi d’astinenza avanza, si è disposti a tutto, e sembra quasi dar ragione al nostro protagonista nel leggere delle lenzuola sudate, dei crampi, del puzzo di piscio e di merda che accompagna il tossico, nel tempo sempre più lungo, tra una botta di eroina e un’altra. Come nelle più classiche delle storie di droga, se la donna può racimolare qualcosa prostituendosi, l’uomo diventa predatore, e impugna le pistole, per tentare così un assalto disperato a una banca, a un ufficio postale.
I guai, quelli veri, arrivano di seguito, e il vortice si fa sempre più forte, e così la fuga, dall’Italia rampante degli anni ’80, che esalta gli yuppie e dimentica tutti gli altri. Nel frattempo JK lascia dietro di sé pure l’amore, Laura, unica possibilità di un futuro tranquillo, reale e possibile, alternativa a tutto il resto, per rifugiarsi in quella che era, ancora più di adesso, La Mecca di ogni tossicodipendente, Amsterdam. Il viaggio del dannato ha così inizio, un continuo scendere verso gironi sempre più cupi e lontani. La fauna che popola le sue giornate olandesi, rende quindi, sempre più esagitata e disperata la sua fuga, perso tra coffe shop, pusher e vampiri. Il racconto si fa macabro, splatter, ricordando la migliore letteratura sul genere, e l’incontro con Mister Fifty Fifty sarebbe facilmente trasportabile in una pellicola pulp; anche se in questo caso si sta dalla parte della preda, molto meno comico e sempre più drammatico. Il protagonista sembra alla ricerca di qualcosa di definitivo, come spesso accade per le anime in pena, qualcosa o qualcuno che ponga un punto ai suoi passi sciagurati. Si arriva come a un bivio, da una parte la morte e dall’altra la vita, il carcere, che viene a riprenderlo e a riportarlo in Italia. C’è tempo dunque per la rinascita, per dar spazio poi alle successive ricadute, e così ancora a riprendersi, per poco, per far finta di star bene per un anno o due, per poi essere nuovamente risucchiati, oltre che dalle droghe, dall’alcol, dalla depressione. Mentre nel frattempo ci si sposa e si mette al mondo un figlio. E così via, senza mai trovare pace, in bilico, a cercare comunque di sopravvivere, come sempre.
Con coraggio, Pessione, butta giù su carta i suoi peggiori anni, senza remore, né autocensure. Ed è l’aspetto ovviamente umano e autobiografico ciò che più colpisce, una vita allo stremo, affannata. In ultimo, quasi assolve ciò che lo ha spinto sino ad accarezzare la morte senza però mai ucciderlo: «In un certo senso, l’eroina mi ha salvato la vita. Me l’ha resa sopportabile. È stata una soluzione». Rimane un ultimo piccolo appunto: il racconto soffre a volte di alcune lungaggini, concentrate soprattutto nella trasposizione di alcune situazioni che si ripetono, e che Pessione sembra voler farci rivivere ogni volta, sempre uguali per noi, sempre diverse per lui.
(Riccardo Pessione, 80mg, Miraggi edizioni, 2013, pp. 314, euro 14,90)