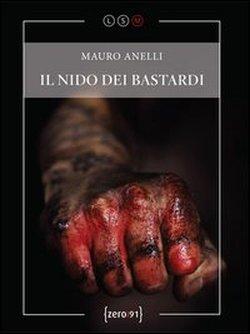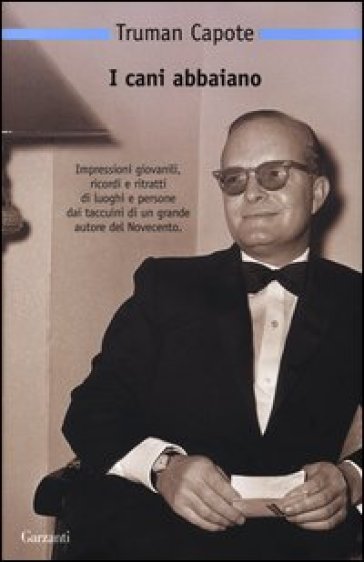Negli ultimi tempi la poesia italiana si aggira nei corridoi della lirica senza sapere bene dove andare. La nostra vecchierella nazionale, come spesso accade ai vecchierelli, si sente scoraggiata, inutile e poco compresa. Ma per fortuna a consolarla ci sono i vecchi amici, come Vittorio Sereni (1913-1983), che, se fosse ancora in vita, tra pochi mesi compirebbe cento anni.
Nato a Luino sulle sponde del Lago Maggiore vicino al confine svizzero, Sereni esordisce nel ‘40 con la sua prima raccolta di versi, Frontiera. Sono quadri dipinti con colori tenui in cui i toni dell’azzurro e del verde vengono animati da qualche raggio di sole pallido, scorci di città, momenti di vita sognata, presenze anonime che attraversano la vita come in un film muto e rallentato. Eppure in queste immagini prima e dopo il movimento, si intuisce qualcosa oltre l’inquadratura, fine o inizio che sia. È l’addio alla giovinezza vissuta con la malinconia degli ultimi giorni di vacanza, e il benvenuto a una condizione di maturità che coincide con la laurea, il dolore per la scomparsa di alcuni amici di gioventù (la poetessa Antonia Pozzi) e soprattutto l’avvicinarsi di una guerra già presentita.
Piazza
Assorto nell’ombra che approssima e fa vana
questa che mi chiude d’una sera,
anche più vano
di questi specchi già ciechi,
io non so, giovinezza, sopportare
il tuo sguardo d’addio.
Ma della piazza, a mezza sera,
vince i deboli lumi
la falce d’aprile in ascesa.
Sei salva e già lunare?
Che trepida grazia,
la tua figura che va
Chiamato sul fronte tunisino, il giovane Sereni è fatto prigioniero in Sicilia e passerà gli anni dal 1943 al 1945 in vari campi di prigionia algerini, lontano da tutto. Mancherà gli appuntamenti fondamentali che la sua generazione e tutta l’Europa stanno compiendo proprio in quegli anni, Liberazione e Resistenza comprese. Da qui nasce un sentimento di uno scoraggiato straniamento, di destino diviso. Nel frattempo tiene un piccolo taccuino di guerra, che sistemerà e pubblicherà subito dopo il conflitto, Diario d’Algeria. È un libro enigmatico, profondo e torbido che lascia sottilmente sgomenti già i primi lettori. Nonostante la giovane età Vittorio Sereni è già un poeta affermato.
Non sa più nulla, è alto sulle ali
il primo caduto bocconi sulla spiaggia normanna.
Per questo qualcuno stanotte
mi toccava la spalla mormorando
di pregar per l’Europa
mentre la Nuova Armada
si presentava alla costa di Francia.
Ho risposto nel sonno: – È il vento,
il vento che fa musiche bizzarre.
Ma se tu fossi davvero
il primo caduto bocconi sulla spiaggia normanna
prega tu se lo puoi, io sono morto
alla guerra e alla pace.
Questa è la musica ora:
delle tende che sbattono sui pali.
Non è musica d’angeli, è la mia
sola musica e mi basta –.
Campo ospedale 127, giugno 1944
Rientrato in Italia si impiega prima presso l’ufficio pubblicitario della Pirelli e poi presso la Mondadori. Sono gli anni del dopoguerra e il conflitto continua, entro i confini nazionali, a lacerare il tessuto politico e sociale. Sereni, come tutti, ha un doloroso conto aperto con il passato che cerca di colmare con la poesia, uno sguardo di rimando. Nel 1965 esce il suo terzo lavoro, Gli strumenti umani. I sensi di colpa continuano a chiamare, e può succedere che finiscano per infilarsi nella vita di tutti i giorni calando sulla vacuità delle cose un velo d’angoscia che diventa ossessione.
La spiaggia
Sono andati via tutti –
blaterava la voce dentro il ricevitore.
E poi, sputa: – Non torneranno più –.
Ma oggi
su questo tratto di spiaggia mai prima visitato
quelle toppe solari… Segnali
di loro che partiti non erano affatto?
E zitti quelli al tuo voltarti, come niente fosse.
I morti non è quel che di giorno
in giorno va sprecato, ma quelle
toppe d’inesistenza, calce o cenere
pronte a farsi movimento e luce.
Non
dubitare, – m’investe della sua forza il mare –
parleranno.
Siamo ormai nella piena maturità, Sereni ha condotto una brillante carriera aziendale ed è diventato il direttore editoriale Mondadori, un poeta funzionario di altri poeti che ha ridotto al minimo il proprio ingombro di scrittore e si è messo al servizio di alcuni dei nomi più roboanti del nostro secondo Novecento. Il vizio della poesia rimane a guardarsi allo specchio e in sé riconosce il (non?)senso di una vita intera dedicata alla testimonianza individuale e collettiva. Il limite che regola la realtà dei vivi è ormai solo una soglia posticcia.
Sarà la noia
dei giorni lunghi e torridi
ma oggi la piccola
Laura è fastidiosa proprio.
Smettila – dico – se no…
con repressa ferocia
torcendole piano il braccino.
Non mi fai male non mi fai
male, mi sfida in cantilena
guardandomi da sotto in su
petulante ma già
in punta di lagrime,
non piango nemmeno vedi.
Vedo. Ma è l’angelo
nero dello sterminio
quello che adesso vedo
lucente nelle sue bardature
di morte
e a lui rivolto in estasi
il bambinetto ebreo
invitandolo al gioco
del massacro.