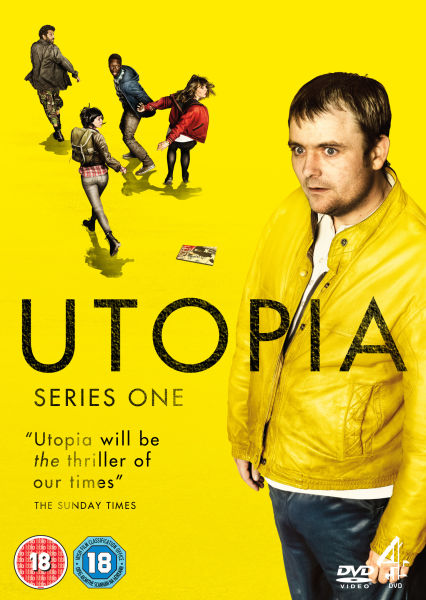Pubblicato negli Stati Uniti nel 2002, Quando l’imperatore era un dio (Bollati Boringhieri, 2013), seguito ideale di Venivamo tutte per mare, edito nel nostro paese lo scorso anno, racconta una pagina sconosciuta della storia americana, ovvero le vicende della prigionia della popolazione giapponese e nippo-americana dopo l’attacco di Pearl Harbor avvenuto il 7 dicembre del 1941.
Se leggenda vuole che l’Europa abbia brindato all’attacco giapponese che ha definitivamente convinto gli Stati Uniti a entrare in guerra contro il Terzo Reich, Otsuka ci ricorda con delicatezza che quando gli stati combattono tra loro macinano negli ingranaggi della guerra anche tante piccole storie individuali, e che non sono solo le bombe a fare le vittime.
La prima di queste vittime, nella piccola storia che si dipana nelle 153 pagine del romanzo, è un padre. Arrivano di notte a strapparlo alla pace della villetta in cui abita e lo portano via, ancora in pantofole, gettando la famiglia nell’orrore dell’ignoranza della sua sorte. Qualche tempo dopo arrivano le notizie, ma non sono buone notizie, il padre viene condotto in un campo di concentramento, poi in un altro, poi in un altro ancora. Le altre vittime vengono mietute all’apparire dell’Ordine di evacuazione firmato dal presidente Roosevelt, a seguito del quale la madre è costretta a preparare i bagagli per sé e per i figli e a impacchettare con cura la sua vita per consegnarsi a una lunga prigionia presso un campo nel deserto dello Utah dominato da sole, vento e polvere.
La madre, il padre, il bambino e la bambina sono contemporaneamente le vittime di tutte le guerre e i protagonisti a tutti gli effetti di una vicenda assolutamente unica. Da un lato, infatti, sono individui senza nome, spersonalizzati e universali, dall’altro, l’autrice li descrive attentamente calandoli in maniera precisa nel loro proprio contesto e cesellandone dettagliatamente i gesti e le abitudini. Il linguaggio di Otsuka, che si declina in maniera differente a seconda che il punto di vista sia quello della madre, del padre, dei bambini o di un più generico “noi”, è semplice e diretto come i pensieri dei protagonisti quando vengono evocati da dettagliapparentemente insignificanti. Non per questo, però, questo racconto, apparentemente freddo e distaccato, manca di pathos, anzi, il lettore ne è avvinto per effetto di una irresistibile forza debole che consente di compatire i personaggi senza aver bisogno di evocare atrocità, come quando, attraverso la lente familiare, ci viene raccontato il senso di colpa per avere il viso del nemico, o quando ci viene spiegato, attraverso la nostalgia degli alberi e delle limonate, l’orrore della segregazione.
Nel 1988 il governo statunitense ha chiesto scusa offrendo ventimila dollari come risarcimento agli internati, «ma la memoria è importante, io scrivo per difenderla», spiega Otsuka, che in un’intervista a Newsweek racconta che anche sua madre, che allora aveva dieci anni, suo zio e sua nonna hanno avuto esperienza del «campo recintato» e della squallida baracca descritti in questo romanzo.
Quando l’imperatore era un dio è un libro che vale sicuramente la pena di leggere, un po’ per restituire alle vittime della storia la consolazione della memoria, un po’ per riconoscere che, nei ricorsi della storia, potrebbe capitare a chiunque di indossare oggi o domani, senza saperlo e senza volerlo, il volto del «sabotatore fra i cespugli […] lo sconosciuto davanti al cancello […] il traditore nel vostro giardino».
(Julie Otsuka, Quando l’imperatore era un dio, trad. di Silvia Pareschi, Bollati Boringhieri, 2013, pp. 153, euro 13)