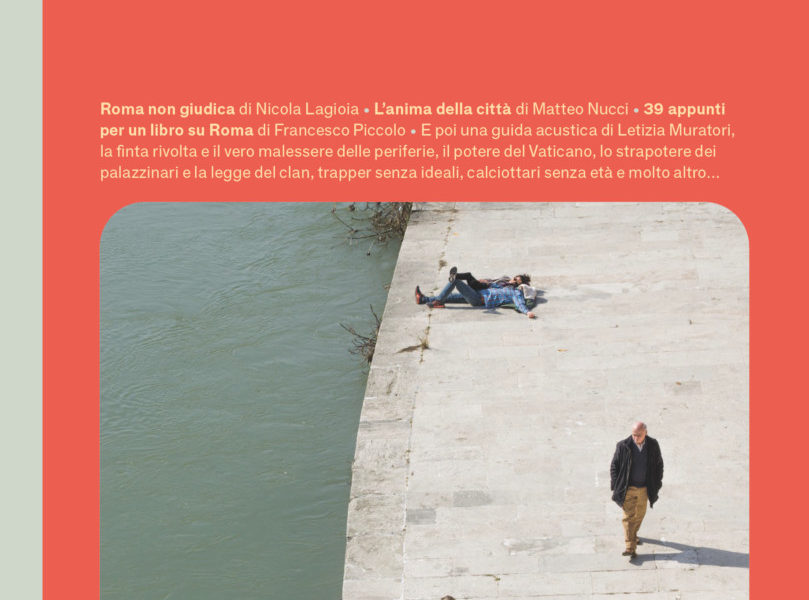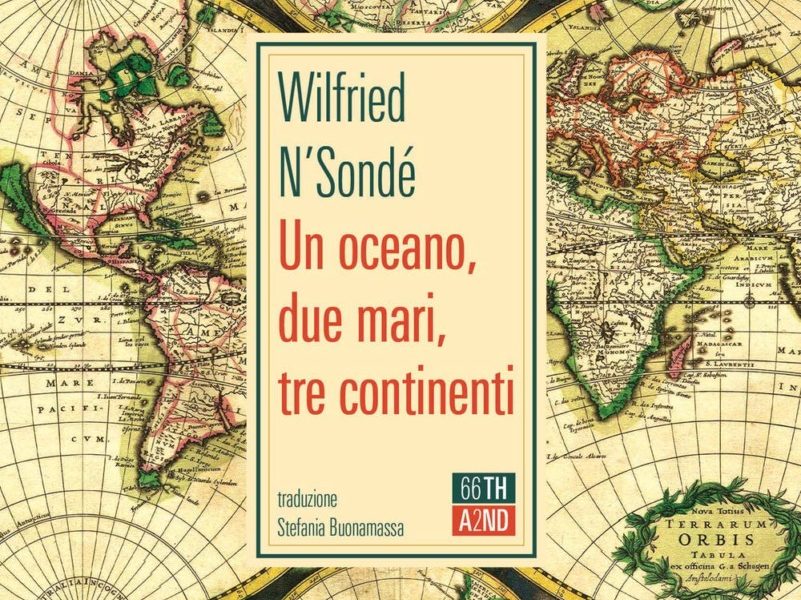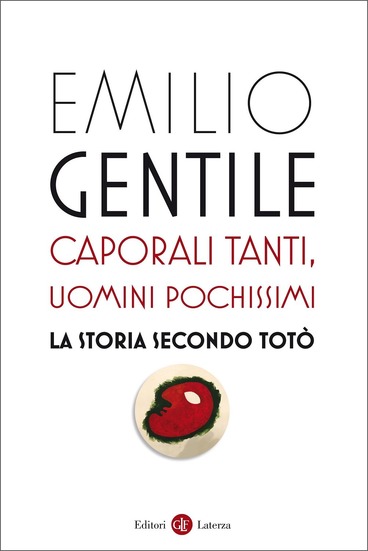Uscito nel 2004, Tutti i giorni è la seconda opera di Terézia Mora come scrittrice di narrativa, e per questo romanzo l’autrice ha ricevuto il Premio della Fiera del Libro di Lipsia. Il titolo è un omaggio a Ingeborg Bachmann, ed è forse solo una felice coincidenza che Terézia Mora sia stata insignita del Premio Bachmann per il suo libro d’esordio.
Tradotto finora in più di dieci lingue, in italiano viene pubblicato per la prima volta nel 2009, nella traduzione di Margherita Carbonaro, per i tipi di Mondadori, e nel 2020 lo riscopre la casa editrice Keller, sempre nella traduzione di Margherita Carbonaro. Un’operazione valida, giustificata dal successo di critica e anche di pubblico del libro, e anche dell’autrice, ormai di consolidata fama come una delle voci tedesche più originali dell’inizio del Ventunesimo secolo.
La trama di Tutti i giorni è complessa, non facile da seguire, e la ricostruzione rischia di perdersi in mille rivoli. Il punto di partenza è una maldestra confessione d’amore: Abel Nema, ungherese per metà, dopo la festa dell’esame di maturità si dichiara a Ilia Bor, l’amico del cuore in cerca di Dio. La delusione gli fa commettere l’unico atto chiaro e comprensibile della sua vita: di notte dà in escandescenze e rompe le vetrine dei negozi. Da quel momento in poi la sua vita è un esilio volontario, una sorta di vita monacale senza rapporti sentimentali e legami di qualunque profondità. Dopo un incidente, come per miracolo, diventa capace di imparare le lingue straniere perfettamente, persino senza accento, ma il protagonista trascorre la sua esistenza praticamente senza parlare, come rivela, ma solo a chi conosce l’ungherese, il suo nome. Nema con l’accento sulla e, che in tedesco non esiste, significa muto. Abel, che è quasi Bábel, ovvero Babele, è Béla, un nome comune, e insieme fanno Némabéla, una rima baciata.
Abel è un ragazzo di bell’aspetto, uno che non passa mai inosservato. Vive nella Babele moderna in un campo sempre circoscritto, pur cambiando spesso domicilio. Come se quel trauma giovanile, quella delusione d’amore, lo avesse privato della capacità di provare sentimenti. Terézia Mora non offre ambientazioni chiare, le città non hanno nomi, ma dalle descrizioni si delinea prima Sopron, in Ungheria, la città natale dell’autrice, lasciata nel 1990 a diciannove anni, e poi Berlino, la città in cui approda e dove tuttora risiede. Luogo e tempo sono volutamente indefiniti, anonimi, perché il lettore deve rivolgere tutta l’attenzione ai processi interni, intimi.
Inoltre Abel Nema non possiede il senso dell’orientamento, sbaglia strada ovunque, si perde, quindi i luoghi non hanno, non possono avere alcuna importanza nella vita di un protagonista che fatica a ritrovare persino la strada di casa. Sono importanti invece gli interni, così come le comunicazioni non verbali che Mora descrive con molta precisione in quello che i critici tedeschi hanno definito un canto epico a molte voci, un quadro contemporaneo con la guerra balcanica sullo sfondo, la coraggiosa rappresentazione della vergogna di “stare al mondo in tempi cattivi”.
Abel Nema parla dieci lingue, ma tranne quando fa l’interprete non lo vediamo comunicare. Per il lettore rimane un estraneo, eppure è sempre al centro della narrazione. La sua persona riunisce il destino dei rifugiati della guerra balcanica, l’estraneità, il multilinguismo e la vita in e di una metropoli. La narrazione che scorre seguendo più fili, i frammenti e i cambi di prospettiva rendono il romanzo una polifonia simile a quella che Terézia Mora ha incontrato nei libri da lei tradotti dall’ungherese al tedesco, in particolare in Harmonia Caelestis di Péter Esterházy, che le è valso, nel 2002, un premio per la traduzione.
Abel è un perfetto programma per tradurre, un robot che non sente fame, non si ubriaca e ha bisogno di pochissimo riposo notturno. Quando si stanca Abel si esprime infatti come una macchina parlante. Da bambino abitava in un armadio, in seguito trova alloggio in magazzini e sottotetti. La sua vita è un vagabondaggio incessante senza legami con persone e territori. Sembra non provenire da nessuna parte e ha i documenti di uno stato che non esiste più. Nel corso del romanzo perde più volte i documenti d’identità, trascorre periodi come membro inesistente della comunità, ma il migrante Abel trova sempre qualcuno che gli tende una mano. Attraversa ambienti molto vari, incontra persone curiose, ciascuna delle quali offre al lettore una storia ai limiti, alle periferie della normalità. Un microcosmo affascinante, a tratti repellente, che lotta per rimanere in superficie; incontriamo delinquenti e rassegnati, miti e violenti, persone di profonda cultura e altre che ne sono completamente prive. In un vortice di avventure Abel Nema sfiora quest’umanità variopinta, e in qualche caso ne rimane vittima suo malgrado, perché la sua indifferenza e la sua estraneità a tutto e tutti non è uno scudo. Così fino alle ultime pagine, quando Mora mette in atto una svolta che fa riflettere il lettore a lungo su salvezza, felicità e felice ignoranza.
Tutti i giorni è un romanzo sull’estraneità, in cui Abel è sempre davanti alla porta ma non entra mai. Accetta solo una mano, quella di un bambino, il geniale Omar: da lui si fa condurre, con lui varca anche una soglia. Abel Nema conduce il lettore lungo il romanzo: con lui non è possibile parlare, ma intorno a lui comunica un mondo vasto e vario. A volte usando toni drammatici, tragici, o solo asciutti, ma non manca una certa dose di umorismo che alleggerisce temi pesanti e procura sollievo.
Tutti i giorni è un romanzo di 500 pagine di alto valore letterario. Tradurlo non può che essere stato un compito molto delicato e molto difficile. Rispondendo generosamente ad alcune domande, Margherita Carbonaro, la sua traduttrice, ce ne dà un’idea e svela anche qualche curiosità.
Prima che lo pubblicasse l’editore Keller, Tutti i giorni di Terézia Mora era già nel catalogo di Mondadori nella tua traduzione del 2009. Hai ritoccato la traduzione, oppure è andata semplicemente in ristampa?
Ho tradotto Tutti i giorni molti anni fa, fra il 2008 e il 2009, e naturalmente sono molto contenta che Keller abbia ripreso adesso la mia traduzione, uscita allora da Mondadori. Ho avuto la possibilità di vedere e correggere le bozze di questa nuova edizione, come avevo chiesto all’editore. Confesso che ero convinta che avrei cambiato parecchio, a distanza di anni, ma poi – anche a causa del fatto che, come spesso succede, in quel periodo avevo anche altre scadenze – mi sono limitata a rileggere e a fare qualche intervento qua e là, ma non ho modificato sostanzialmente la traduzione. Ho capito anche che era meglio non farlo. O meglio, che non sarai stata in grado di farlo. Se mi ci fossi messa davvero, avrei avuto la tentazione di cambiare troppo e forse avrei fatto peggio. Mi rendo conto che ci sono lavori che più di altri si legano a cose che stai vivendo in un certo periodo. Come un libro può parlare a un lettore in maniera diversa quando lo legge per la prima volta e quando poi lo rilegge tempo dopo, lo stesso succede naturalmente anche – e forse tanto più – al traduttore.
Questo romanzo è un microcosmo di migranti, a cominciare dal protagonista, quindi anche un mondo linguistico polimorfo, con riferimenti culturali ed espressivi a molte realtà. Reso presumibilmente in un tedesco piuttosto insolito, dovuto forse anche all’origine ungherese della scrittrice. Come te la sei cavata, è stata una sfida impari?
A distanza di tanti anni non riesco a ricostruire le riflessioni che il testo mi aveva suscitato allora, le difficoltà e i problemi concreti di traduzione. Ho nel computer un file che li raccoglie, e da qualche parte un quaderno pieno di scarabocchi e appunti più o meno illeggibili, ma probabilmente non ho più le chiavi per leggerli. Mi scuso perciò se invece di entrare in questo tipo di dettagli divago e racconto brevemente qualcosa di più personale. Mentre ci lavoravo, il libro mi aveva parlato in una maniera molto forte. La città – Berlino – in cui si muove Abel Nema è quella in cui avevo vissuto anch’io, forse un paio d’anni prima che ci arrivasse lui. Anche se il filtro attraverso cui Mora ne parla è decisamente particolare, avevo comunque nella mente una mappa, anche temporale, in cui sistemare le cose raccontate. Quella mappa però in quel periodo, mentre traducevo il libro, si trovava con me a Pechino dove abitavo allora. Dentro casa, e dentro la mia testa, c’erano il tedesco e l’italiano, fuori casa c’erano la Cina e il cinese (e anche l’inglese), e lì io ero – non sempre ma spesso – nema, la muta, l’estranea, la straniera. Faceva parte della mia vita quotidiana l’essere straniera: era una qualità del corpo, della voce, degli occhi, che mi accompagnava ovunque andassi. Almeno a quell’epoca, era impossibile sfuggirvi. Qualcosa di quella situazione deve essersi insinuato quantomeno nel modo in cui leggevo e percepivo il libro mentre lo traducevo.
Puoi condividere con noi qualcuna delle tue riflessioni riguardo alla traduzione di questo libro?
Tutti i giorni è un libro forte, pieno di energia – così l’ho sentito io. La sua lingua, la sua sintassi sono cariche di energia. La voce di Mora è tesa, nervosa, mordace e ironica, tagliente ma anche delicata. E nello stesso tempo la sua lingua e la sua sintassi sono leggere. A volte, traducendo, avevo la sensazione di quando ci si sta per tuffare, e poi l’istante del tuffo, o di quando si sta in cima a una pista di sci e si è pronti a buttarsi e ad assecondare la velocità. La lingua di Mora è piena di cunette che ti permettono di spiccare brevi salti, da una frase all’altra. Era stata proprio quella per me la sfida, e la difficoltà principale: seguire il suo ritmo, renderlo così come lo sentivo nelle orecchie. Certamente il tedesco di Mora è molto particolare, e lo è perché è scritto da qualcuno che ha intonato originariamente la propria voce su un’altra lingua. Avere dentro di sé lingue diverse è un modo magnifico di nutrire la lingua in cui si scrive. A me il tedesco di Mora piace molto proprio per le qualità a cui ho appena accennato: forza, leggerezza, nervi.
In un’intervista pubblicata sull’«Indice», a cura di Daria Biagi, Térezia Mora ha detto di trattare gli oggetti della sua scrittura come se questi fossero fisicamente liberi nello spazio, il che comporta continui cambiamenti del punto di vista che si riflettono a volte in alternanze dei tempi verbali anche all’interno di una stessa frase. «Può darsi che qui entri in gioco la mia lingua materna, l’ungherese, che non ha generi grammaticali e che per esprimere il tempo ha solo due forme che possono alternarsi nella frase, e che non prevede neanche un ordine fisso per le parole». Purtroppo non conosco l’ungherese. Sono affascinata da quello che lei dice, ma è qualcosa che riesco a cogliere solo in forma di eco. Probabilmente è meglio così, perché comunque era quell’eco, quel tedesco in cui evidentemente risuona un eco che io dovevo tradurre, era il tedesco di Mora – e non l’origine dell’eco.
Devo comunque dire che traducendo non pensavo affatto all’“anomalia” di quel tedesco. Forse c’entra in questo anche il fatto che la mia vita stessa in quel periodo era multilingue. E così è stato anche per i giochi sonori che compaiono nel testo e per le parole in altre lingue – note o ignote – che il lettore non dovrebbe, spero, sentire come inserti in qualche modo estranei, come “parole straniere” ma come elementi naturali di quell’impasto e di quella storia.
(Terézia Mora, Tutti i giorni, trad. di Margherita Carbonaro, Keller, 2020, 496 pp., euro 19,50, articolo di Andrea Rényi)