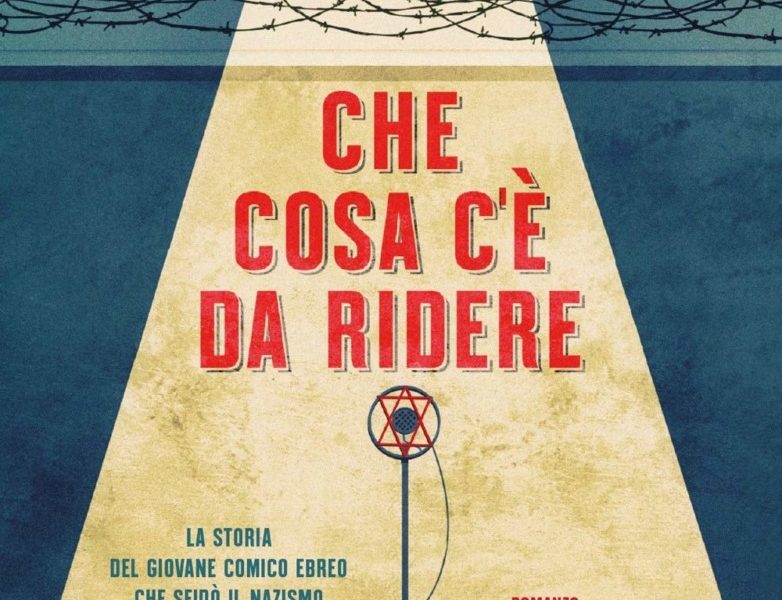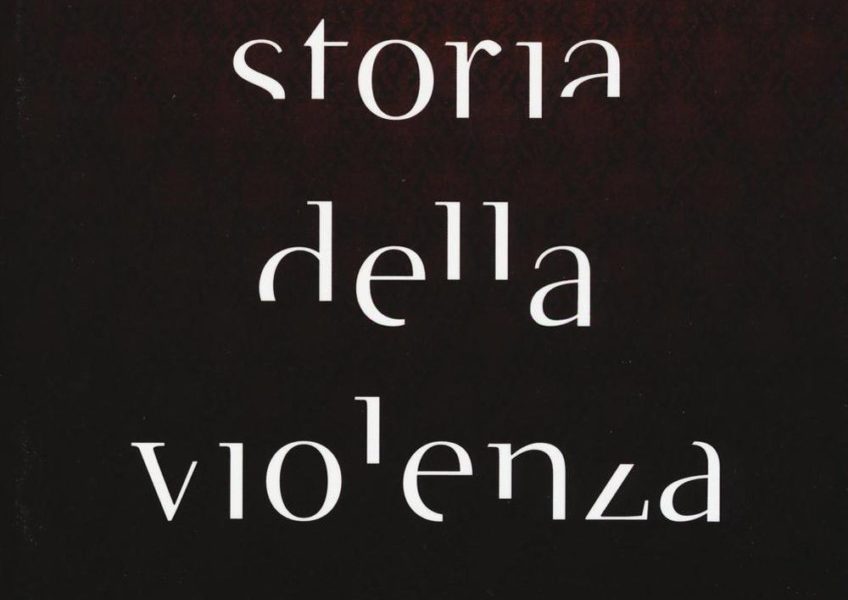La tradizione cinematografica degli ultimi cinquant’anni ha arricchito l’immaginario culturale di un nuovo standard di qualità, proponendo opere concepite da artisti che alle speculazioni intellettuali preferivano le sensazioni. Non si è trattato di una controriforma rispetto alle Nouvelle Vague, ma qualcosa di straordinario accadde poco dopo, quando l’ispirazione artistica manifestatasi in seno alla contestazione giovanile maturava la consapevolezza della propria sterilità.
Il cinema aveva imboccato nuove strade, chiaramente tracciate, straripante di attrazioni, frequentate da personalità molto diverse da Godard e Buñuel. Le probabilità di avvistare un brachiosauro erano molte, così come era alto il rischio di imbattersi in un Terminator prototipo T-800.
A Mark Cousine siamo debitori per aver lavorato al documentario The Story of Film: An Odyssey, in cui il regista non manca di integrare la ricostruzione storica con la forte componente emotiva che dall’opera si trasmette al ricercatore. Cousine ci spiega come la sperimentazione cinematografica fosse passata nelle mani di un nuovo gruppo di sognatori che sembravano ignorare la contemplazione per inseguire la meraviglia e lo sbalordimento.
I sogni di Spielberg, Cameron e Lucas non avevano una destinazione elitaria, erano sogni di altra fattura rispetto a quelli che tormentavano Dalí e che lo intrattenevano in lunghe conversazioni con Buñuel. Come ci racconta Cousine, erano sogni in cui «gli sconfitti incontrano il sublime».
Erano mutati anche i parametri adottati dal pubblico per misurare la qualità artistica del nuovo cinema delle sensazioni.
![]()
Complessità, significato e originalità divenivano gradualmente i tre banchi di prova della critica. Il cinema sperimentale pareva dunque andare incontro alle stesse sorti dell’arte astratta, ovvero contestato in più occasioni sul piano della difficoltà di realizzazione dell’opera, della comprensibilità della trama e dell’originalità sia dei mezzi realizzativi che della trama stessi.
Cinema astratto e arte astratta, però, non condividono né origine né sorte. Il primo nasce come una delle manifestazioni tecnologiche dell’arte, e la sua versione astratta o intellettuale avrebbe avuto minore fortuna rispetto all’arte contemporanea, ovvero l’arte che nel corso del Novecento ha scelto di essere astratta, minimale, pop.
Se i cinefili fossero raggruppati in partiti, i membri del partito di Lucas conterebbe più membri del partito di Malick. Di Star Wars si lodano senza riserve la complessità, la trama e l’originalità del tutto, di The Tree of Life si discute dell’accessibilità al messaggio filosofico nascosto.
L’ultimo film di Charlie Kaufman ha riproposto la questione, prevedendo l’intervento dei critici su riflessioni preliminari che preparano lo spettatore alla visione (v. “Il mondo è più grande della nostra testa”. Su Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman). Tuttavia, fra le due tradizioni non vi è un parallelismo assoluto, l’esperienza degli astrattisti può dirci molto sul ricorso spesso improprio alle misure della complessità, del significato e dell’originalità che condizionano il giudizio di una parte del pubblico.
Procedendo a esplorare le correnti sperimentali degli albori del cinema, si incontrano proiezioni di realtà nuove che provocano la razionalità dello spettatore proprio perché non sembrano neppure competere alle facoltà immaginifiche umane, come quelle della serie Opus realizzata da Walter Ruttmann a partire dal 1921.
Forme voluttuose occupano lo schermo, alternandosi secondo una sequenza che il cervello umano potrebbe forse sovrapporre all’immagine del nuoto spensierato delle meduse. Ruttmann aveva filmato un vetro sul quale aveva steso della pittura, aveva atteso che si asciugasse, e infine vi aveva aggiunto dell’altra pittura filmandola mentre si espandeva. Un giorno disse: «un’opera d’arte esisterà soltanto se nascerà dalle possibilità e dalle esigenze dei materiali di cui è fatta».
La vocazione astratta di Ruttmann non era altro che una dedizione verso la materia, il suo astrattismo non condivideva la stessa vocazione che aveva ispirato l’astrattismo di Kandinskij. Era però evidente come il cinema astratto contenesse nel proprio corredo genetico il proposito anarchico e beffardo dei dadaisti.
Nel 1914, il pittore Francis Picabia commissionava al regista René Clair la realizzazione del film Entr’acte, proiettato durante l’intervallo di un balletto. La pellicola conteneva soggetti comuni come una ballerina e un cannone. Fuori dal comune era invece la prospettiva pensata da René Clair, il quale posizionò la camera sotto la ballerina e dentro il cannone. Questo è ciò che disse Picabia: «il ne respecte rien si ce n’est le désir d’éclater de rire», ovvero «non rispetta nulla tranne la voglia di scoppiare a ridere». Curioso come in un’intervista degli anni Cinquanta, Tristan Tzara descrivesse Dada come una forma di «disgusto applicato a tutte le forme della civiltà moderna, al linguaggio [..] L’assurdo superava i valori estetici. Non bisogna dimenticare che in letteratura un invadente sentimentalismo mascherava il cattivo gusto che con pretese di elevatezza si accampava in tutti i settori dell’arte».
Queste parole avrebbe potuto dirle uno come Spielberg, se non fosse che Tzara riteneva come Dada non avesse riguardi «per la storia, la logica, la morale comune, l’Onore, la Patria, la Famiglia, l’Arte, la Religione, la Libertà, la Fratellanza e tante altre nozioni corrispondenti a delle necessità umane, di cui però non sussistevano che delle scheletriche convenzioni, perché erano state svuotate del loro contenuto iniziale». Osserva Cousine, il dadaismo non era altro che anarchia e sberleffo, e prima ancora, secondo Fernaldo Di Giammatteo l’esperienza dadaista «negava qualsiasi valore all’arte, si opponeva all’estetica e ai gusti della borghesia».
Alle idee di Libertà, Fratellanza, Famiglia, uno come Spielberg assocerebbe forti sensazioni raccontate attraverso storie concepite con notevole riguardo per le necessità dell’essere umano. Tra Ruttmann e Spielberg vi è un abisso vocativo, il primo adottava come motto la frase di Cartesio «non voglio neppure sapere se prima di vi sono stati altri uomini», il secondo deve tutto alle parole del fantasma del soldato Joe in Joe il pilota del 1943, che guardando la sua amata correre verso l’uomo che incarna la vita che continua, può finalmente dirle «Goodbye darling…».

L’incompatibilità di questi due modi di concepire il cinema, spiega come il tentativo di ricorrere alle misure della complessità, del significato e dell’originalità dell’opera sia spesso improprio e fallimentare.
Non si può che rimandare a Kandinskij, e a quell’aneddoto che contiene la più autorevole ed efficace chiave di lettura dell’astrattismo: «stavo tornando a casa [..] quando d’improvviso vidi un quadro di una bellezza indescrivibile imbevuto di ardore interno [..] su cui non vedevo altro che forme e colori e il cui contenuto era incomprensibile. Trovai subito la chiave del mistero: era un mio quadro che era appoggiato alla parete di lato. Il giorno successivo, alla luce del sole, cercai di ricreare in me l’impressione che il quadro mi aveva fatto il giorno prima. La cosa mi riuscì però solo a metà; anche ponendo il quadro su un lato riconoscevo sempre gli oggetti [..] seppi così che in modo preciso che l’oggetto nuoce ai miei quadri».
Kandinskij era artisticamente impegnato in una conversione che assunse connotazioni religiose. Restava la forte vocazione pittorica, combatteva contro la frustrazione spirituale dovuta all’adempimento inappagante ai dogmi del realismo, trovava sollievo estatico nel liberarsi dalla mimesis.
Più tardi, Picasso avrebbe preso le distanze dalla tensione kandinskijana a «dipingere l’invisibile», che dal suo punto di vista equivaleva a «dipingere l’indipingibile». Picasso si faceva portavoce delle convinzioni di Courbet e Cézanne, Kandinskij avrebbe lasciato in eredità l’idea che l’emancipazione dalla rappresentazione dell’oggetto è possibile.
«Jeder Dada kann», ovvero «Dada lo può fare chiunque», era il motto dei detrattori del dadaismo e per estensione dell’astrattismo. Ma come nella tradizione pittorica coesistono l’astrattismo di Kandinskij e la coscienza del mondo oggettivo di Picasso, così è possibile scoraggiare il tentativo dello spettatore di valutare la dignità artistica di un film sul piano della complessità tanto quanto non è sostenibile desumere che Pollock lo possa fare chiunque.
L’astrattismo respinge ogni tentativo di dedurre un significato che spesso non va oltre la semplice voglia di ridere, risponde a un’emozione di stomaco, traduce in arte tutti quegli stati d’animo che non trovano un compimento nel linguaggio. La datazione proposta del primo acquerello astratto di Kandinskij coincide con l’anno 1910.
Il positivismo soccombeva alla disillusione, la sensibilità di alcuni artisti e pensatori riceveva lo stesso impulso che avevano ricevuto i dadaisti: quello della ribellione agli schemi scheletrici della logica e del linguaggio. A distanza di un anno, l’umanità riceveva in eredità due opere universali che erano riuscite nel tentativo fino ad allora inconcepibile di aprire un buco nero nel linguaggio stesso: il Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein (1921) e l’Ulisse di Joyce (1922).
Tutto veniva messo in discussione. Si erano create le condizioni per la sperimentazione, che avrà luogo proprio in quel buco nero che Wittgenstein e Joyce avevano aperto nella realtà oggettiva. Da quel momento, la sperimentazione si sarebbe compiuta in misura maggiore nell’arte rispetto al cinema, ma avrebbe imparato a convivere con la celebrazione artistica dell’oggettività che proprio nel cinema si sarebbe compiuta in misura maggiore rispetto all’arte.
Negli anni Cinquanta il cinema aveva già sperimentato il Neorealismo, mentre Yves Klein si era emancipato dalla materia. Negli anni Sessanta le Nouvelle Vague impegnavano intellettualmente il pubblico, mentre l’arte si sperimentava scegliendo sempre più spesso la sua variante non figurativa. Negli anni Settanta, un uso straordinario del controcampo sublimava la scena in cui lo squalo attacca il ragazzino sotto lo sguardo impietrito del capo della polizia, mentre Nam June Park posizionava un Buddha di bronzo davanti una videocamera accesa. Seguono gli anni di protesta, la globalizzazione. Si impone un quarto parametro di misurazione della qualità artistica: la morale. A partire dagli Oscar del 2024, saranno premiati solo i film che rispettano gli standard di inclusione delle minoranze.
Come aveva osservato Jean Rouche, che si tratti di brachiosauri o di un modo per essere John Malkovich, «il cinema, l’arte del doppio, rappresenta già il passaggio dalla realtà al mondo dell’immaginazione».