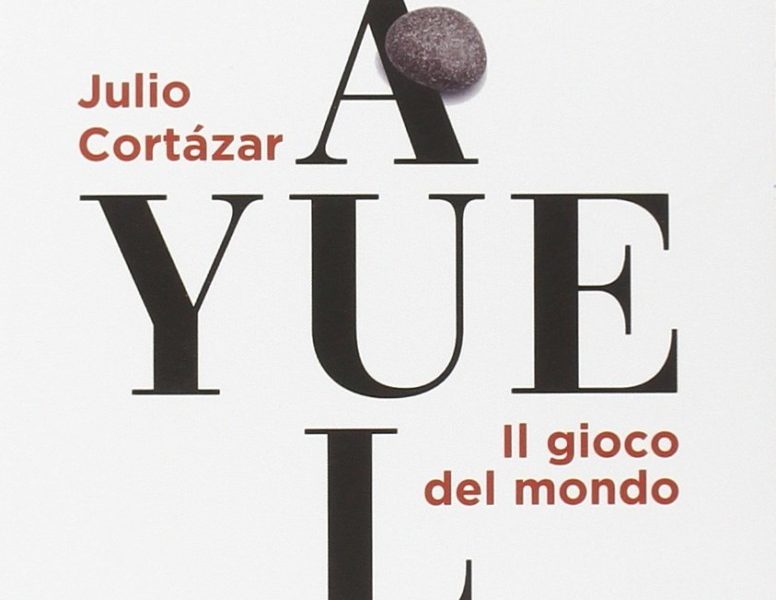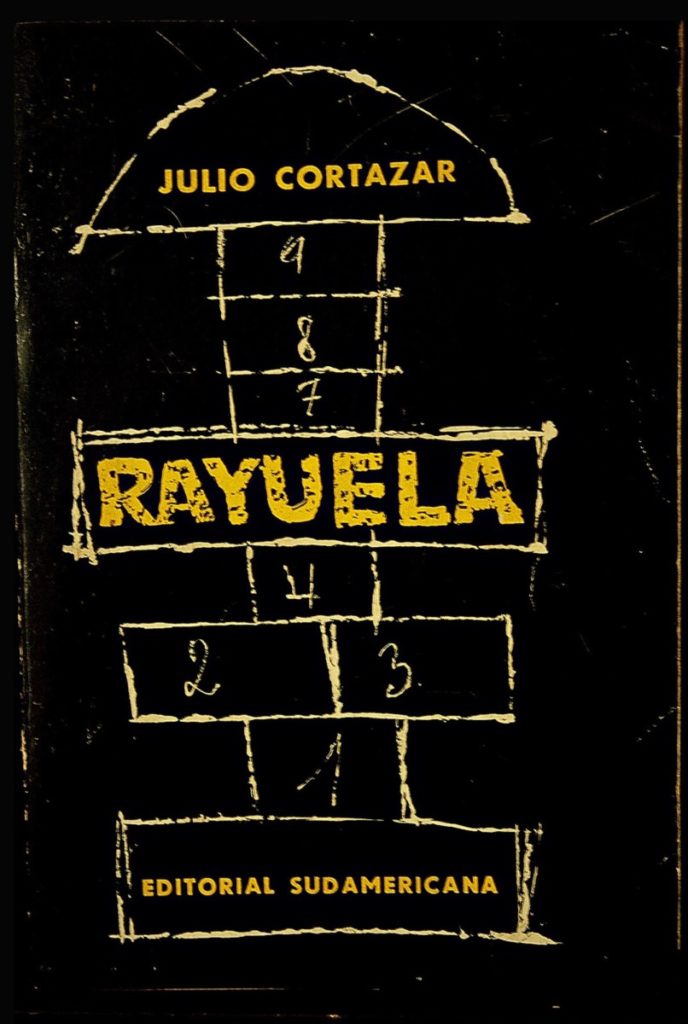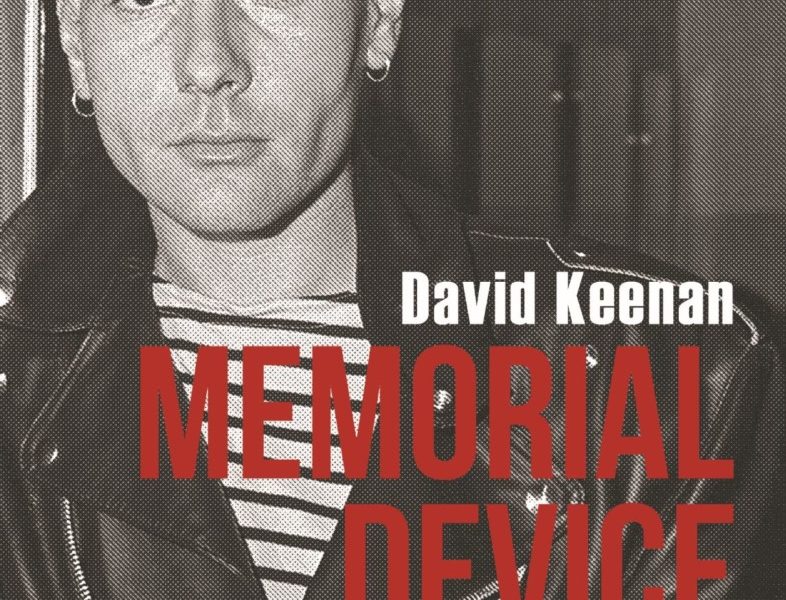La parola Ferdydurke, in polacco, non vuol dire niente – si ispira probabilmente al nome di un personaggio di Babbitt di Sinclair Lewis, o forse a un’eccentrica espressione francese. In realtà, però, è proprio la sua bizzarra assenza di significato, il suo nonsense misterioso, a adattarsi bene al tono grottesco del romanzo di Witold Gombrowicz. Ferdydurke, pubblicato nel 1938, assomiglia fin dalle prime pagine a un’esibizione da circo, ma anche a un sofisticato atto di tortura: è una parodia violenta e sgangherata della Polonia del tempo, una premonizione della tragedia in cui l’Europa stava per crollare. È il caos della letteratura che svela, e anticipa, quello della realtà: d’altronde nel romanzo di Gombrowicz ci si trova di continuo di fronte a immagini confusionarie, a lotte dove i corpi si ingarbugliano l’uno con l’altro, a smorfie, facce deformate, ridicoli ma rischiosi duelli intellettuali.
Ferdydurke, tra i libri più significativi del Novecento, è da poco stato ripubblicato da il Saggiatore, che negli ultimi anni ha riproposto varie opere dello scrittore polacco: la particolarità di questa edizione è che alla traduzione di Irene Salvatori ha contribuito anche Michele Mari, che ha ricreato in italiano tutta la complessità e la schizofrenia linguistica del testo originario.
Giuso, il protagonista del romanzo, è un trentenne che non si sente ancora accettato dal mondo degli adulti; dopo una notte tormentata gli si presenta in casa un ometto dall’aria severa: si tratta del professor Pimko, che decreta inderogabilmente che Giuso debba tornare a scuola; l’uomo regredisce così all’adolescenza – non nel corpo ma nella percezione che il mondo ha di lui. La sua rocambolesca avventura di trentenne-liceale si articola a questo punto in tre atti. Prima di tutto Giuso si ritrova tra i banchi della scuola, che Gombrowicz descrive attraverso l’inutile teatrino delle lezioni: i professori sono apatici, gli alunni annoiati, i programmi tediosi; è tutto fasullo, imposto una volta per tutte, e niente può essere messo in discussione. La propria presunta maturità viene percepita dagli adulti (gli educatori) solo in contrasto all’immaturità degli adolescenti; i professori descritti da Gombrowicz, infatti, non sono altro che maschere informi, e acquistano una precaria identità unicamente all’interno della fatiscente istituzione scolastica.
Il tema della forma e dell’identità verrà affrontato con costanza durante il corso del romanzo: nella seconda parte Giuso va a vivere in una famiglia della borghesia polacca che si atteggia a moderna e progressista; finisce poi per regredire ancora di più all’infanzia tra le grinfie «ziesche» della nobiltà terriera, tutta intrisa di paure e falsi valori. Ogni evento fa parte della stessa spirale folle con cui Gombrowicz racconta il paradossale infantilismo di una società ipocrita e ottusa, fieramente convinta della sua maturità – cioè di possedere un volto, una forma definita.
Tra una parte e l’altra Gombrowicz inserisce due intermezzi simili a parabole, che dovrebbero racchiudere il significato profondo del romanzo ma che finiscono per esaltare ancora di più la potenza del caos e dell’informe: nel primo intermezzo si racconta dello scontro mortale – e spassoso – tra due professori, il maggior paladino della Sintesi e quello dell’Analisi; nel secondo una serie di eventi casuali durante una partita di tennis conduce alla confusione più totale, che ha il suo picco nel vagito di un bambino, chiaro simbolo di un’immaturità onnipresente e vittoriosa.
Quello dell’immaturità, in Ferdydurke, è però un concetto ambiguo. La società polacca di Gombrowicz, nel suo pensarsi saggia e adulta – nel progressismo della borghesia come nel conservatorismo della nobiltà –, non fa altro che atteggiarsi, ostentando un insieme di pose ridicole. È l’immaturità travestita da maturità; sono i bambini che fingono di essere adulti. Il gioco delle apparenze è infatti ossessivo, e i personaggi si sentono continuamente osservati e giudicati, nel terrore costante di perdere lo status che li contraddistingue. È proprio lo sguardo dell’altro a distorcere i lineamenti, a rendere i volti orridi, alterandoli in smorfie sempre più marcate.
Ferdydurke è insomma una critica sociale sotto forma di satira, ma anche una stravagante indagine esistenziale. L’immaturità non è solo la peculiarità di un mondo smarrito tra finte ideologie e ormai sull’orlo del baratro; immaturo è l’individuo informe, che non può essere mai un tutt’uno con sé stesso, che non può raggiungere la coerenza senza atteggiarsi oppure sformarsi del tutto.
Cosa rappresenta allora l’immaturità di Giuso? È un’imposizione della società che non vuole accettarlo nel novero degli adulti, oppure la sua è in fondo una regressione volontaria? Si tratta forse di un’immaturità positiva, più autentica proprio perché palesata? Giuso è un personaggio capriccioso incapace di responsabilizzarsi, un ipocrita come tutti gli altri o magari un ribelle? L’adolescenza perenne, forse, è l’unica scelta sensata in un universo che ha le fattezze di un incubo buffonesco – un universo nel quale, a conti fatti, è meglio non diventare mai adulti.
Di conseguenza, è l’opera stessa di Gombrowicz, la sua struttura romanzesca, a presentarsi come informe: Ferdydurke è un insieme di parti irregolari, non combacianti, in cui predominano stravaganze stilistiche e giochi di parole (emblematiche le mille variazioni del termine «culo», che scandiscono ossessivamente il ritmo della storia); è un vortice disordinato di realismo e follia, una satira tragicomica dove morte e vita, risata e dramma, si perdono l’una nell’altra; in fin dei conti, Ferdydurke è un tentativo di rappresentare il caos accettandone tutte le sue beffarde declinazioni.
Sarà la storia stessa del libro, d’altronde, a essere contrassegnata da un destino tipicamente gombrowicziano: partito per l’Argentina come giornalista, lo scrittore vi sbarcherà a pochi giorni dall’invasione nazista della Polonia; deciderà quindi di fermarsi e rimarrà lì per ventiquattro anni. Per farsi conoscere nell’ambiente intellettuale argentino intraprenderà lui stesso, con l’aiuto di un gruppo di suoi allievi, la traduzione di Ferdydurke; il problema era che Gombrowicz parlava male lo spagnolo, mentre gli allievi non conoscevano il polacco. Con il francese come unico punto di incontro, il romanzo, per forza di cose, cambierà forma durante la traduzione, si stravolgerà in una paradossale esaltazione della sua filosofia.
Ferdydurke, a più di ottant’anni dalla sua prima pubblicazione, è dotato di un’attualità paradossale, a tratti inquietante; l’ironica descrizione dell’universo scolastico, per esempio, così come il progressismo di facciata della borghesia, appaiono più contemporanei che mai. Ancora più lampante, nella sua modernità, è l’immagine di Giuso, il trentenne impossibilitato a crescere, intrappolato in un’adolescenza perenne, con il mondo intorno che fa di tutto per ricordargli la sua colpevole immaturità. La società polacca degli anni Trenta ha insomma molto in comune con la nostra; o forse le smorfie di Ferdydurke deformano da sempre – e per sempre – le nostre facce.
(Witold Gombrowicz, Ferdydurke, trad. di Irene Salvatori e Michele Mari, il Saggiatore, 2020, 336 pp., euro 22, articolo di Claudio Bello)