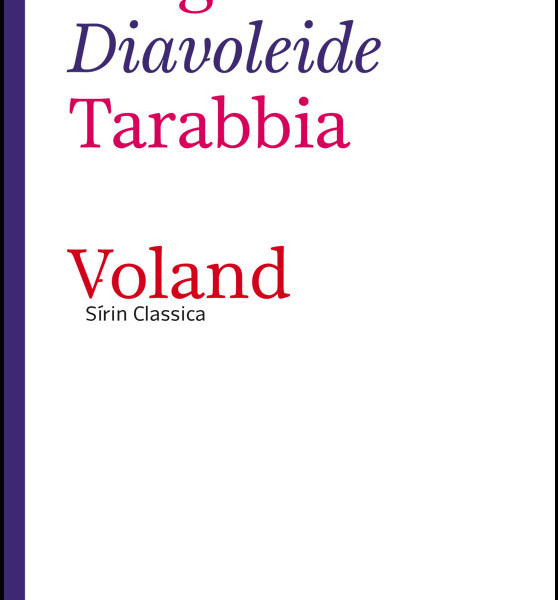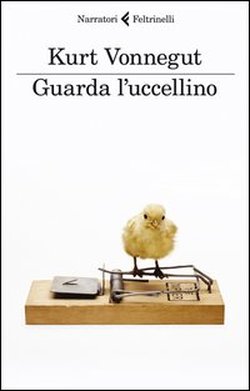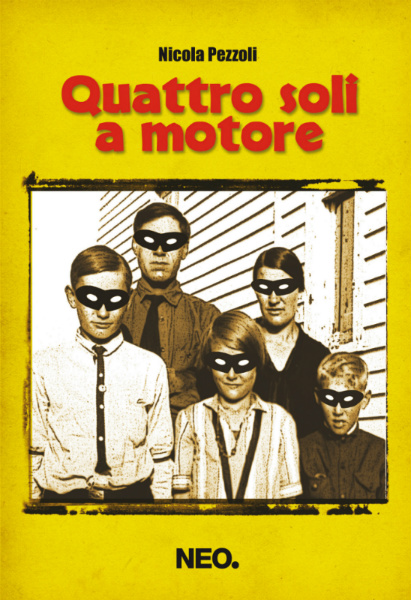Black Comics Home Studio, lo Studio Alveare. Nella provincia di Latina, a Itri, in una sala di registrazione tappezzata da pagine di vecchi fumetti in bianco e nero, gli ÆMÆT sono di nuovo al lavoro. La rock band, completamente rinnovata nel 2010 dalla voce di Cristian Suardi e, nel 2012, dal chitarrista Giovanni Ialongo, si sta preparando con grande impegno all’uscita del suo primo disco. Un EP, Muse of Lust, pubblicato nel Settembre 2011, un tour che li ha visti portare in giro gli strumenti per tutto il Lazio, un’energia che non smette di creare e sperimentare.
Pubblichiamo in esclusiva per Flanerí l’intervista al bassista in nero, Cristian Ciccone, che abbiamo incontrato durante una pausa dalle lunghe sedute di registrazioni di questi giorni. Cristian, insieme al batterista Stefano di Russo, rappresenta il nucleo originario degli ÆMÆT.
ÆMÆT, chissà quante volte vi siete trovati a correggere fan e giornalisti sulla pronuncia di questo nome così particolare. Possiamo sapere cosa significa e perché lo avete scelto?
ÆMÆT è un termine ebraico e significa verità. Lo abbiamo preso da un film muto del regista tedesco Paul Wegener, Der Golem del 1915 (ci piace molto l’espressionismo tedesco). Secondo la leggenda, il rabbino utilizza questa parola sacra per dar vita alla materia informe, al golem appunto, e così facendo acquista parvenze divine, poiché dà vita. Un gesto che dà vita e dà verità, ed è un po’ quello che la musica è per noi: vita vera. Inoltre, come hai sottolineato tu, ognuno lo pronuncia come vuole, e credimi, ne abbiamo sentite di tutti i colori…
Vi riconoscete in qualche genere in particolare? Come definireste la vostra musica a chi si appresta ad ascoltare i vostri pezzi per la prima volta?
Credo che l’unica etichetta possibile sia quella di rock alternativo, ben mescolato con elementi grunge e new wave. Tuttavia è giusto precisare che siamo in perpetuo divenire, e le etichette ci stancano presto; il nostro obiettivo è la continua ricerca e sperimentazione.
Come molti altri gruppi italiani, emergenti e non, avete scelto di scrivere i testi delle vostre canzoni in inglese. Siete soddisfatti della resa testuale attraverso un codice che non è propriamente vostro? Chi di voi scrive i testi?
Il mercato italiano ci interessa, ma non quanto quello europeo, americano o asiatico. La lingua inglese ci permette un mercato planetario, e questa è la sola ragione per cui l’abbiamo scelta. Ovviamente, per quanto riguarda la resa testuale, siamo più che soddisfatti. Scrive soprattutto Cristian Suardi, il cantante. Ma in quest’ultimo lavoro ho contribuito anch’io in minima parte. I due stili sono molto differenti eppure perfettamente complementari: Cristian S. lavora molto sulle immagini: è onirico, intimo, emozionale; un po’ il contrario di Cristian C., che preferisce dare all’ascoltatore indizi precisi per permettergli di afferrare un significato inequivocabile, e spesso tagliente. Potremmo fare un test. Secondo voi chi ha scritto il testo di “Hangman”?
Avete intenzioni di trasferirvi, quindi?
Per ora non ci sono le possibilità, né tanto meno le intenzioni. Nel nostro “Alveare” c’è tutto ciò di cui abbiamo bisogno, e ricreare uno spazio del genere altrove sarebbe certamente molto difficile. Abbiamo tuttavia l’intenzione di spostarci all’estero in occasione di un tour, soprattutto nel nord Europa. Ci stiamo muovendo già da ora per quest’obiettivo, ma siamo consapevoli che dovrà passare ancora un po’ di tempo, che dedicheremo senz’altro alla promozione di questo nuovo lavoro in cui crediamo molto.
Di cosa parlano le vostre canzoni? Quali tematiche ha ispirato la vostra “Muse of Lust”?
Muse of lust è un cd cupo, malinconico… e tuttavia dolce: tutti i brani raccontano di un’esperienza sentimentale profonda, intensa, vissuta in maniera quasi sacrale; il lavoro cerca di scoprire se si tratti, in fondo, di un’esperienza felice o infelice. La frase che racchiude bene il senso dell’intero lavoro, a mio avviso, è tratta da “Coagulation”: «All these sorrows for an explosion of richness». Chi può negare che la massima gioia sia nascosta, spesso, dietro il più estremo dolore?
Diverso è il discorso per i nuovi brani. Le riflessioni sono più ampie e traggono molto della loro forza dal mondo reale in cui siamo immersi, che visto in maniera oggettiva sembra dominato più da forze malefiche che non vòlte al bene collettivo. Ma sarà il caso di riparlarne quando uscirà il cd…
Il 2012 è stato un anno ricchissimo di concerti ed eventi musicali davvero unici; uno dopo l’altro, a Roma e nel resto d’Italia. Abbiamo avuto l’impressione che non saremmo mai riusciti a vederli tutti. Domanda sognatrice, prima di quale gruppo avreste voluto suonare?
Bella domanda. Nell’ambito della musica italiana credo che il gruppo più indicato sia Il teatro degli orrori; ho la sensazione che l’energia dei nostri attuali concerti si inserirebbe molto bene in apertura di un loro spettacolo. A livello internazionale penso ai Muse, più o meno per le stesse ragioni. Ma immagino che stiamo davvero parlando, ora, di fantamusica…
E i vostri concerti, invece? Qual è quello che vi ha dato più emozioni?
Difficile rispondere a questa domanda: ormai cominciano a essere numerosi i concerti che abbiamo svolto in questi due anni. Per la risposta di pubblico ottenuta penso alla data della Locanda Blues, a Roma, nel maggio di quest’anno. Siamo arrivati lì come perfetti sconosciuti, e quando siamo andati via sembravamo un gruppo capace di lavorare tranquillamente con la propria musica rock. Sono queste le esperienze che alimentano le nostre convinzioni, perché è giustissimo credere in se stessi, ma è altrettanto giusto realizzare che il tuo prodotto funziona ed è apprezzato da un pubblico caloroso.
Durante il vostro ultimo live avete regalato al vostro pubblico numerose anticipazioni dei nuovi pezzi. Si percepisce un deciso cambio di rotta tra Muse of Lust e il nuovo lavoro. Che percorso avete intrapreso e cosa ha influenzato le vostre scelte?
Muse of Lust è stato un lavoro velocissimo, realizzato in pochissimo tempo e conserva tutti gli elementi del debutto. È, come detto, un’opera lenta, claustrofobica. Nel nostro nuovo lavoro abbiamo ovviamente sentito il bisogno di allontanarci da quel tipo di approccio, cercando maggior brevità e aumentando decisamente il numero di bpm (battiti per minuto, ovvero la velocità del metronomo, n.d.r.). Direi che la molla che sta dietro al nuovo lavoro è la rabbia: sappiamo benissimo che le cose non vanno, o meglio che vanno fin troppo bene, ma non per quelli come noi, che vogliono sentirsi liberi. Quindi non ci resta che rabbia, frutto di lucida consapevolezza e attraversata da terrificante angoscia – io personalmente mi sgomento ancora quando mi fermo a pensare cosa sia realmente questa società. Ma queste sono solo vanità artistiche, per ora noi stiamo benissimo…
A questo punto siamo curiosi di sentire il nuovo album. Grazie mille, Cristian. A presto!
Per rispondere alla sfida lanciata da Cristian, potete ascoltare “The Hangman” qui:
http://soundcloud.com/aemaet/the-hangman-muse-of-lust
Trova gli ÆMÆT (praticamente ovunque!):
Facebook: http://www.facebook.com/Aemaet
Myspace: http://www.myspace.com/aemaetband
Soundcloud: http://soundcloud.com/aemaet
Youtube: www.youtube.com/aemaetband
Tumblr: aemaet.tumblr.com
E la galleria del «Black Comics Home Studio» su Flickr: http://www.flickr.com/photos/aemaet/sets/72157631553411138/