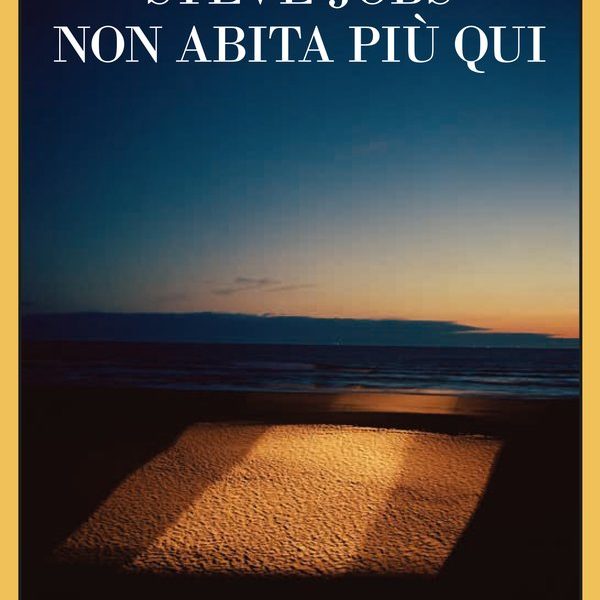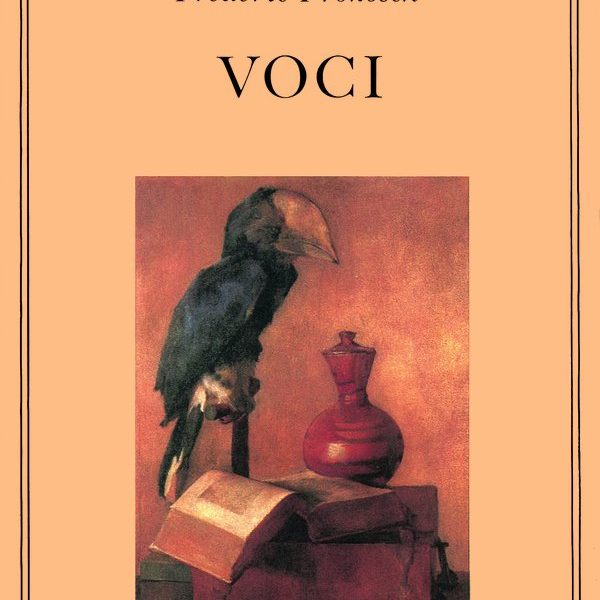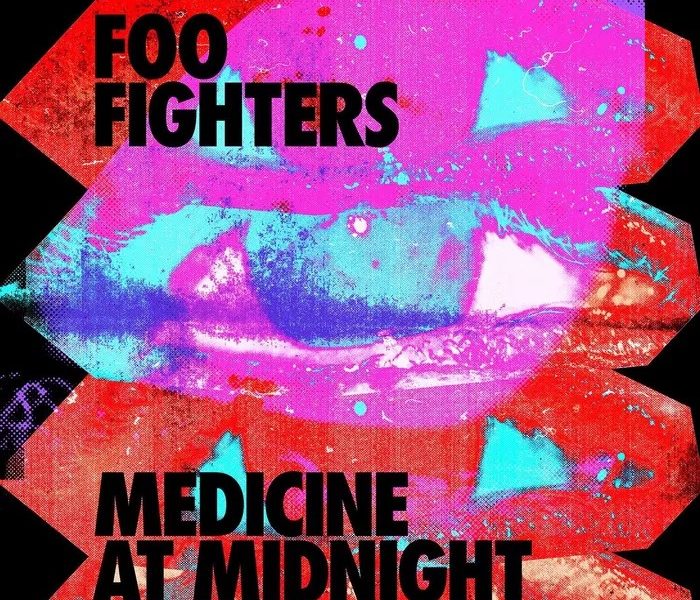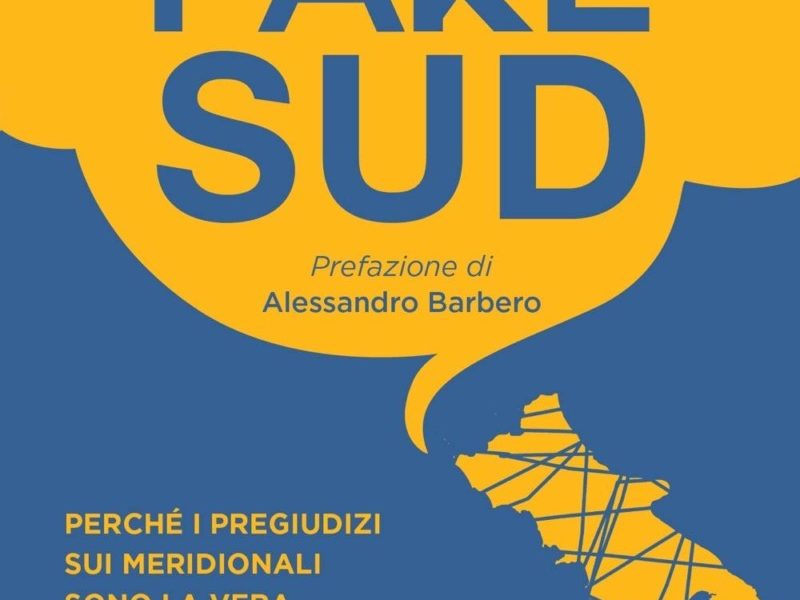Se dal portafoglio estraggo la mia stropicciata carta d’identità non digitale, e provo ad aprirla con cura per non strapparla del tutto, la foto al suo interno ritrae un uomo che io non riconosco. Non nego che possa essere una mia foto di una certa mattina di un certo mese di qualche anno fa, ma oggi io quell’uomo con la barba e i capelli corti, gli occhi sottili, il naso lungo, non lo riconosco. Non gli somiglio affatto, non ha niente del me di ora. E mentre mi avvolgo in queste considerazioni, ripenso a una breve, ma molto affascinante invettiva di Giovanni Arpino ripubblicata dalle Edizioni Henry Beyle, Contro la fotografia (2014), in cui il raffinato polemista scrive: «La peggiore macchina che l’uomo abbia in uso è quella destinata a partorire fotografie».
Non riusciva a soffrirle, le fotografie, Giovanni Arpino. Di qualsiasi tipo. Pensava fossero ingannevoli e velenose, capaci soltanto di fermare un particolare secondo di un particolare momento della nostra esistenza, di ridurci e limitarci a quell’istante. Una riduzione e una limitazione che vanno a scontrarsi con le possibilità di sentirsi l’età che desideriamo avere in qualsiasi frangente: di riconoscersi giovani da vecchi e vecchi da giovani, di rifuggire l’oggettività dell’età. Le fotografie, soprattutto i nostri ritratti fotografici, sono invece delle lapidi definitive. Diventano un vincolo ermeneutico su noi stessi, almeno «finché non si scopre», continua Arpino, «che quello che le fotografie dicono è così facile, epidermico, momentaneo e imbambolato, per cui hanno sempre torto».
Sul perenne torto delle fotografie conviene Ferdinando Scianna, tra i maggiori fotografi e fotoreporter del Novecento, che firma una nota alla fine del volume. Sostiene anzi che la posizione di Arpino è «tutto sommato moderata». Per Scianna «fredda e necrofila è la fotografia. Nel momento in cui ci illude di immortalare un istante contemporaneamente lo uccide e ci fa capire che l’istante solo esiste se è istante di vita, se è vivo esso stesso, se noi siamo vivi con lui».
Ma quando, è lecito chiedersi, l’istante è davvero istante di vita, quando prende vita? E una fotografia potrebbe mai riuscire a cristallizzare un istante di vita?
Ecco, quando è arrivato sugli scaffali delle librerie il nuovo saggio di Ferdinando Scianna, Il viaggio di Veronica. Una storia personale del ritratto fotografico (Utet, 2020), ho istintivamente indirizzato la lettura alla ricerca di alcune risposte per questi interrogativi sospesi.
Di risposte, in questo racconto estremamente appassionante dei ritratti nella storia della fotografia, ce ne sono molte, disseminate nei densi capitoli di riflessioni e aneddoti e immagini.
E tra queste immagini, la prima che mi cattura è quella di una carta d’identità (le piccole ossessioni guidano sempre lo sguardo). Osservandola con grande attenzione, noto che è la carta d’identità dello stesso Scianna e chiude il capitolo «Dalla fisiognomica alla fotografia giudiziaria» con una riflessione sulla capitale relazione tra fotografia, società e identità. Tre termini che elencati così, potrebbero sembrare tre concetti assoluti, tre categorie debitamente distinte, eppure si sintetizzano tutti in quel pezzo stropicciato di carta che conserviamo con cura nel nostro portafoglio.
Pensiamoci bene, scrive Scianna: se ci trovassimo a prendere un aereo o se un agente di polizia ci chiedesse di mostrare i nostri documenti, la prova insindacabile della nostra identità sarebbe la foto nella nostra carta d’identità. Lo è stato per circa un secolo, e continuerà a esserlo fino a quando altre prove, come il riconoscimento del DNA, non sostituiranno questa pratica. Ma finora, per la società noi siamo gli uomini e le donne che i nostri documenti ritraggono: «Sembra una faccenda puramente tecnica e ha invece una portata culturale enorme, perché questo significa che la nostra società a un certo momento della sua storia ha deciso di delegare all’immagine, non più alla persona, il concetto di identità».
Devo accettarlo, al di là di qualsiasi elucubrazione filosofica: per il mondo sono – e posso soltanto essere – quel piccolo ritratto incollato sul mio documento. Aveva certo ragione Giovanni Arpino a lamentarsi. Tuttavia, restano insolute quelle domande che prima abbiamo sollevato. Ebbene, per non sottrarre del tutto al futuro lettore la possibilità, e soprattutto il piacere, di scoprire le risposte da solo, mi limito a citare soltanto un altro capitolo, le pagine dedicate a Henri Cartier-Bresson.
«Figura paterna e magistrale», per Scianna Henri Cartier-Bresson, oltre a essere il teorico del «decisive moment» e l’autore di alcuni degli scatti più celebri della Storia, è una sorta di sinonimo della parola fotografia. L’importanza della sua opera, sottolinea l’autore del Viaggio di Veronica, incarna la cultura europea che tenta di definirsi oltre le «aritmetiche della moneta unica» e trova la sua massima espressione nell’arte del ritratto.
Per Cartier-Bresson il ritratto nasce da un istante di vita condiviso tra il fotografo e il fotografato (ci ritorna in mente quando Scianna scrive nella postilla ad Arpino che un istante è vivo se siamo «vivi con lui»). L’istante di vita che anima il ritratto fotografico ha l’aspetto di un’antinomia: da una parte deve essere frutto di una confidenza, di una sintonia; dall’altra deve scaturire da una folgorazione, essere fulmineo, cogliere «l’istante decisivo»: «Anche se il ritratto si fa nella reciproca consapevolezza e connivenza, vale, per raggiungere il buon risultato, quello che vale per ogni altro tipo di fotografia: riconoscere come una folgorazione l’istante decisivo. Nessuna messa in scena. Tutto deve avvenire nella spontaneità. Niente lunghe sedute. Un solo rullo in macchina. Basta e avanza. Se dopo trentasei scatti il ritratto non c’è, inutile insistere: non ci sarà».
Condizioni impossibili, si direbbe subito. Eppure, per convincerci delle teorie di Cartier-Bresson e di Scianna, ci basta ammirare il ritratto dei coniugi Curie o di Coco Chanel: prove di quella filosofia dell’istante in cui siamo noi in tutto il nostro essere. Allora è vero che un istante di vita può essere cristallizzato in un’unica foto, ed è vero che in un solo attimo può essere fermata un’intera esistenza.
Riprendo in mano la mia stropicciata carta d’identità. Adesso, forse, comincio a riconoscere quell’uomo, inizio a convincermi che potrei essere io, in tutte le stagioni della vita, passate presenti e future.