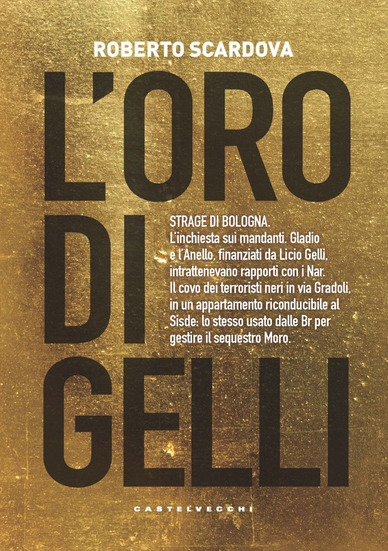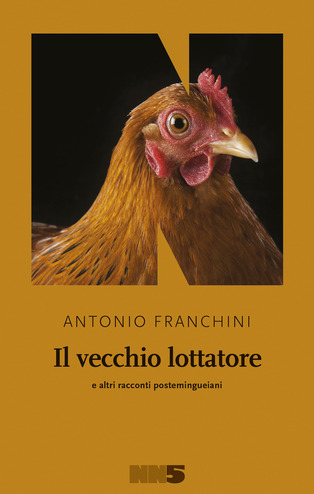Agli albori del XX secolo, William Somerset Maugham pubblica un romanzo unico nella sua produzione, straniante e sinistro, dall’innaturale posa gotica: Il Mago (oggi Adelphi, 2020). A renderla un’opera affascinante è di certo la chiara ispirazione dell’autore a una controversa figura del suo tempo, che aveva avuto la fortuna e la disgrazia di conoscere a Parigi: Aleister Crowley esoterista britannico a oggi considerato il padre dell’occultismo moderno. A lui si ispira la figura del protagonista, Oliver Haddo, uomo dalla mole colossale, dallo sguardo fisso e inquietante, dai modi altezzosi che oscillano tra il macabro e il ridicolo. In questi termini Maugham costruisce una satira mirata e precisa di questa figura spaventosa e di tutto ciò che rappresenta: per farlo mette in piedi una macchina che si muove agilmente nel genere horror e gotico, senza fronzoli né slanci romantici.
Così Il Mago finisce per raccogliere in sé tutti gli elementi tipici del genere, da laboratori oscuri come quello di Haddo, a incantesimi e visioni sinistre evocate nelle menti di giovani vergini innocenti, difese dal loro premuroso e impavido promesso sposo pronto a dare battaglia al mostro che minaccia il sogno d’amore.
Avanzando tra le pagine del romanzo di Maugham e seguendo queste chicche di genere è possibile seguire un sentiero che conduce direttamente al vero colosso a lui contemporaneo, che qualche anno prima pubblicava Dracula (oggi Feltrinelli, 2011) destinando a un cambiamento di rotta definitiva tutti gli autori gotici.
Lo spettro di Stoker aleggia sul Mago, plasmandone temi e risvolti, schemi narrativi e personaggi: Oliver Haddo incarna un antagonista pericoloso, temibile ma anche capriccioso e infantile nei suoi slanci vendicativi verso gli scettici. Maugham ne architetta una fisicità che poco ha dell’umano e vira piuttosto verso il mostruoso. In questo modo l’autore vuole descriverci una bestia senza cuore, arida e avida, proprio come Stoker con il suo Dracula più mostro che uomo, se non fosse per un vago sembiante. Entrambi i personaggi seguono spietatamente i loro istintivi propositi, che sia creazione di vita o desiderio del sangue della vecchia Inghilterra.
Per raggiungere i propri scopi, tanto il mago che il vampiro non mostrano scrupoli a tiranneggiare giovani donne, indifese, dall’incantevole candore che molto cozza contro l’animo putrido dei loro aggressori. Si tratta di Margaret e di Mina, vittime e prede dei due antagonisti. Margaret è una bellissima, ben educata aspirante artista che vive e studia a Parigi in attesa del matrimonio con il suo tutore e benefattore Arthur Burdon. Mina, promessa sposa dell’avvocato Jonathan Harker, è una brillante stenografa, il cui diario guida il lettore come un faro all’interno dell’articolato intreccio narrativo.
Entrambe sono oggetto di desiderio dei due mostri: il terrificante Haddo irretirà la docile Margaret attraverso visioni sataniche e incantesimi che legheranno la psiche della fanciulla alla sua persona, condizionandola a tal punto da indurla a sposarlo e a diventare cavia per i suoi crudeli esperimenti.
Così Mina viene assediata dal Conte che, per farla sua eterna sposa, la vampirizza conducendola a perdere la propria anima e a divenire anch’essa una creatura non morta. Dunque è innegabile il richiamo che entrambe avvertono nei confronti dei loro assalitori, ai quali restano misticamente legate senza possibilità di fuga, pur consapevoli di andare incontro a un destino di morte e perdizione.
In questo snodo narrativo si inseriscono i due promessi sposi, innamorati di Margaret e Mina a tal punto da superare il fragile limite della propria umanità per riaverle con sé. La centralità delle figure di Arthur e di Jonathan sta nel rappresentare il bene che insorge contro il male, l’uomo che è in grado, attraverso il proprio intelletto, di avere la meglio sulla bestia.
Arthur Burdon in particolare incarna nell’opera di Maugham la razionalità che è la principale chiave di lettura del romanzo: da chirurgo e medico emerito, risulta sin da subito scettico nei confronti dei bizzarri racconti e resoconti di Haddo che suonano alle sue orecchie come vaneggiamenti di un folle. A causa del suo scetticismo viene quindi punito dal mago che gli sottrae la donna amata con quelle stesse arti occulte che Arthur ha osato deridere.
Dopo un primo intervallo narrativo il chirurgo apprenderà gradualmente la veridicità dei vaneggiamenti del mago. Eppure sceglierà comunque di contrastarlo con mezzi umani: in un silenzio assoluto, afferra il collo di Haddo e vi affonda le dita fino a strangolarlo. Sarà lo stesso Arthur a finire il mago e a ucciderlo in una modalità che, alla luce degli incantamenti e delle stregonerie presentate nel romanzo, risulta quasi banale.
Altrettanto tangibile appare la morte di Dracula, trafitto al cuore con un paletto di frassino da Jonathan Harker, dopo pagine di incalzanti inseguimenti del vampiro. Così il giovane avvocato, inizialmente affatto convinto di cedere alla superstizione che aleggia intorno al mostro, riesce a spezzare in tempo la maledizione di Mina e a salvarla, e con lei, tutta la minacciata Inghilterra.

Superstizione, magia e occultismo sono il motore che alimenta il meccanismo letterario, che lo esalta e lo conclude. Tra il mondo razionale e pragmatico dei protagonisti e quello fumoso e impenetrabile dei mostri, gli autori collocano provvidenzialmente un personaggio che costituisce il tramite tra due realtà altrimenti inconciliabili: Maugham si serve del Dottor Porhoët, medico e collega di Arthur, segretamente affascinato dal mondo dell’occulto e pertanto studioso della materia. Sarà lui a svelare all’amico i segreti di Haddo e fornire spiegazioni sugli esperimenti condotti dal diabolico mago, permettendo così ad Arthur di poter combattere la propria nemesi ad armi pari.
Di certo più famoso è il tramite del tedesco Van Helsing, figura emblematica esperta di miti e creature occulte, guida essenziale per la vicenda di Mina e Jonathan, deus ex machina in grado di approntare una strategia per sconfiggere Dracula definitivamente ed evitare il compiersi dei suoi piani abietti.
Sebbene il soggetto di Stoker come quello di Maugham si ispiri a un personaggio storicamente esistito, si può notare all’interno de Il Mago una finalità ben diversa da Dracula: se entrambi vogliono condannare ed estirpare il concetto di magia da un mondo moderno dove non c’è più spazio per la superstizione, Maugham rende questo attacco satirico, aggiungendo alle note di Stoker un velo di ironia totalmente assente in Dracula. Non a caso il Mago si ispira a un personaggio esistito e contemporaneo, per evidenziare forse l’insensata esistenza di maghi e occultisti nel XX secolo. Così Haddo assume sembianze sì mostruose ma anche ridicole: è un uomo obeso, la cui mole viene tristemente strizzata dentro abiti pomposi e fuori moda, come in una mascherata nostalgica e grottesca. Le azioni che compie sono sì terrificanti, in grado di seguire con etichetta adeguata i risvolti del genere, eppure vengono costantemente descritte come fuori luogo e stranianti. In questo modo Haddo risulta uscito da un altro secolo, da un contesto più simile a quello di Shelley (oggi Feltrinelli, 2013) dei suoi mostri e scienziati vanagloriosi, e dimostra per questo una difficoltà di fondo a trovare posto nel contesto moderno in cui Maugham lo inserisce forzatamente.
Di qui probabilmente la scelta di uno stile asciutto e narrativo, di una prosa veloce e scorrevole che non incontra gli ostacoli di descrizioni volte a creare una giusta atmosfera gotica. Allora si allontana da Stoker e dai suoi artifici retorici, dalla forma epistolare che assume i toni della lirica, che pur tentando di liberarsene, si perde a volte in dettagliate articolazioni figlie del Romanticismo.
Ma di Stoker e del Gotico, Maugham riprende gli espedienti narrativi per riuscire a dare una giusta collocazione a quel suo romanzo fuori dal coro, che insegue la messinscena dell’occulto, ne scimmiotta gli atteggiamenti ma ne segue anche religiosamente i canoni: così Il Mago finisce per partecipare a questo ballo in maschera tutto letterario, sfoggiando un manieristico costume gotico.