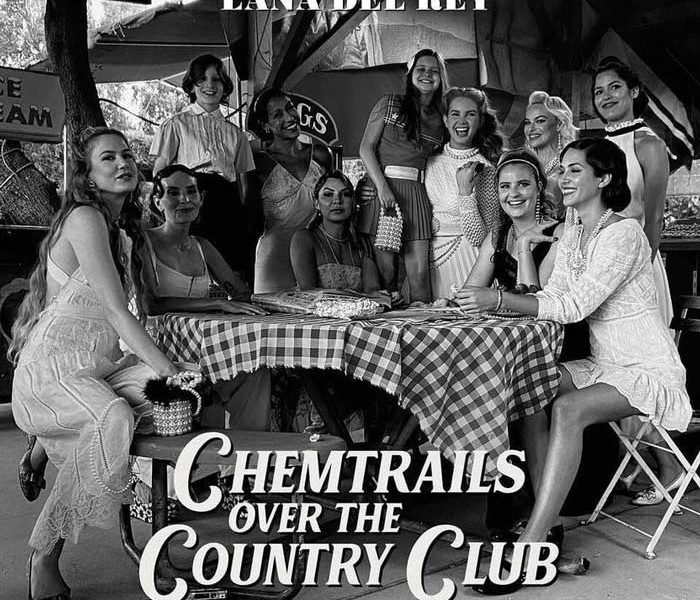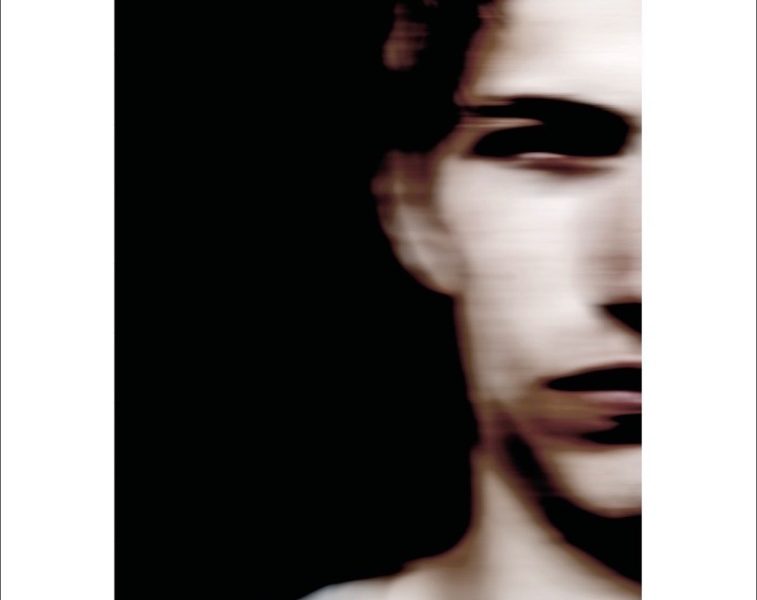Oltre a far parte della redazione di Flanerí, di cui cura la sezione Critica, Gabriele Sabatini si occupa da diversi anni di storia dell’editoria italiana. Nel 2018 aveva cominciato a raccogliere alcune vicende editoriali pubblicando Visto si stampi per Italo Svevo. Ora con Numeri uno (minimum fax, 2020) prosegue idealmente quel lavoro con un obiettivo più preciso: raccontare le storie di alcuni libri che hanno inaugurato collane negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento. Da Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, pubblicato da Rizzoli nel 1940, proprio alla vigilia dell’entrata in guerra dell’Italia, fino a Il soldato, per cui Carlo Cassola rischia nel 1958 di rompere il legame con Einaudi pubblicando nella nuova collana di Feltrinelli diretta dall’amico Giorgio Bassani, Sabatini ripercorre con leggerezza e rigore storico le vicende di personaggi e di libri che hanno segnato non solo l’editoria ma anche la cultura italiana dello scorso secolo.
In un anno in cui le occasioni di incontro sono ridotte all’essenziale, abbiamo deciso di parlare del suo libro per telefono.
Com’è nato Numeri uno?
Numeri uno è nato soprattutto come conseguenza di Visto si stampi (Italo Svevo, 2018): un piccolo libro che raccoglieva alcune vicende editoriali il cui legame è stato trovato nel momento della costruzione, e che originava anche da una serie di articoli pubblicati su Doppiozero. La voglia di approfondire e raccontare altre vicende editoriali con un respiro maggiore mi ha portato a pensare a un altro libro, simile nell’approccio, con capitoli che raccontassero ognuno un singolo libro attraverso le lettere dell’autore agli editori e agli amici, attraverso i diari, ma anche attraverso gli articoli di giornale – che permettono di vedere anche l’accoglienza che il libro ha avuto al momento dell’uscita –, e raccogliendo qua e là degli aneddoti, oltre che restituire il progetto di pubblicazione attraverso la voce degli stessi autori.
Mentre per Visto si stampi il legame non era immediatamente percepibile, nel caso di Numeri uno si tratta di otto libri che hanno inaugurato delle collane importanti degli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento – con qualche eccezione.
Poi in realtà il libro è nato anche perché tramite Carlotta Colarieti ho avuto l’occasione di sottoporre il progetto a Alessandro Gazoia, editor di minimum fax. Ovviamente come spesso succede il progetto è stato modificato: si aggiungono e si eliminano dei pezzi, ma il risultato alla fine è un libro abbastanza compatto, con capitoli di una lunghezza che mi ha consentito di avere un po’ più di aria nell’architettura rispetto al ritmo serrato di Visto si stampi.
Si tratta in tutti i casi di collane e case editrici che hanno fatto l’editoria di quel tempo. In che modo le hai scelte?
Trovata una miccia, cioè parlare di libri che hanno inaugurato delle collane, bisognava costruire con dei criteri. Si è cercato in questo caso di scegliere libri che hanno ancora una reperibilità in libreria: confrontandomi con Gazoia, ci è sembrato importante che fossero libri ancora rintracciabili, perché se per esempio una persona legge un capitolo su un libro che non ha letto può essere interessato a cercarlo. Ci sembrava interessante instaurare questo dialogo tra i capitoli di Numeri uno e i romanzi di cui parlo.
Tutto ciò è vero tranne che un romanzo, Quaderno proibito di Alba de Céspedes, che attualmente non è in libreria ma si spera che torni presto, perché si tratta di una scrittrice molto nota del suo tempo, un’autrice di punta di Mondadori che vendeva milioni di copie. Erano molto famose le sue rubriche sui rotocalchi: oltre a essere una grande scrittrice era un personaggio.
Quaderno proibito è un libro che parla della condizione femminile, ma non solo: è la storia di Valeria, una madre di quarant’anni, che lavora e si prende cura della famiglia – una condizione comune per una donna degli anni Cinquanta. Valeria comincia a tenere questo diario, che è proibito sin dall’inizio perché lo compra di domenica, quando le cartolerie e tabaccherie erano aperte ma si potevano vendere soltanto i tabacchi, ma il tabaccaio le dice di prenderlo ma di non farsi vedere. Poi continua ad avere l’istinto di nasconderlo, perché che cosa avrebbe mai da scrivere una donna come lei, una madre di famiglia con le sue regole e i suoi impegni? Ma nel quaderno riversa invece ciò che c’è nel suo animo e quindi non è confessabile: non qualcosa di violento o efferato, ma ciò che è nell’animo di moltissime persone – e non dico di donne, perché il tema fondamentale del libro è se siamo in grado di rinunciare ai legami, agli obblighi familiari e sociali.
Valeria non ci riesce. I sei mesi nei quali tiene il quaderno, durante i quali c’è anche un possibile adulterio che non viene poi consumato, hanno come esito una rinuncia: la rinuncia al quaderno e quindi il rientro nel proprio ruolo sociale. Attraverso la propria rinuncia Valeria vuole obbligare gli altri membri della famiglia a rispettare le stesse regole: lo fa quasi per vendetta.
Un libro del genere è ancora molto attuale, è un tema perpetuo, e sebbene la sua fama fosse dettata dal fatto che parlava della condizione femminile, Quaderno proibito non parla solo di questo – che è un tema comunque importantissimo – ma parla a tutti. Anche per questo si è scelto di inserirlo.
Se vogliamo c’è una seconda eccezione allo spirito del libro. Il prete bello di Goffredo Parise non ha inaugurato una collana, ma ha contribuito a stravolgere la collana in cui è stato pubblicato. Romanzi moderni di Garzanti era già attiva, ma la nuova presa della direzione della casa editrice da parte di Livio Garzanti ne cambia radicalmente lo spirito, tanto da consentirgli di scegliere autori come Pasolini, Volponi, Gadda e appunto Parise.
In Numeri uno c’è sempre una tensione tra il lavoro editoriale – racconti di come sono nate alcune collane – e il punto di vista degli autori. Ma ci sono anche casi in cui gli autori fanno loro stessi parte del mondo editoriale, come Natalia Ginzburg o Cesare Pavese.
In alcuni casi, come De Céspedes, c’è un classico rapporto autore-editore, anche se lei voleva mettere molto il naso nei suoi libri e nei paratesti – ma questo pertiene ai comportamenti degli autori importanti che sentono di poter invadere un po’ il campo dell’editore. Anche nel caso di Cassola il rapporto è quello tra autore e editore, non solo con Bassani ma anche con Einaudi, con cui deve giustificare la scelta di pubblicare Il soldato da Feltrinelli. I ruoli comunque restano sempre definiti.
In altri invece, e soprattutto gli autori Einaudi, Pavese e Ginzburg, sono membri della casa editrice: non solo per scrivere il proprio romanzo sfruttano il tavolo della casa editrice, per cui si lavorava ma che era anche un luogo in cui ci si poteva permettere di rimanere. Una cosa che incidentalmente ho avuto la fortuna di fare anch’io, che ho potuto timbrare il cartellino ma rimanere in ufficio a lavorare a Numeri uno. L’ho scritto anche nel magazine di minimum fax: Numeri uno nasce su tre tavoli: la scrivania di casa, i tavoli della Biblioteca nazionale e la scrivania di Carocci.
Comunque, Paesi tuoi di Cesare Pavese inaugura una collana che inizialmente arriva in libreria col nome di Biblioteca dello struzzo, ma che cambia perché il nome non piaceva ad alcuni: soprattutto a Leone Ginzburg, che dal confino manda una lettera in cui dice che gli faceva pensare a «libri indigeribili, che solo uno struzzo può divorare». Quindi il libro esce e cambia il nome della collana, ma in tutto il capitolo che ho scritto su Pavese si vede come in realtà lui avesse voglia di far emergere la collana più che il suo libro: sia nella raccolta degli autori, sia nello spazio della quarta e nelle recensioni, Pavese lavorava per far sì che la collana avesse il suo slancio. Perciò il Pavese editore prevale sul Pavese scrittore, ma questo fa parte di quella adesione di Pavese a Einaudi, che era veramente parte del suo spirito.
In effetti leggendo il libro si sente davvero questo contrasto fra quelli che sono solo scrittori e queste persone che quasi tengono più al lavoro editoriale che ai propri libri, che hanno consapevolezza. È come se li mettessi un po’ a confronto…
Questa è una cosa molto interessante. Adesso che mi ci fai pensare, Buzzati è un giornalista, e infatti fa fare le bozze al suo più caro amico perché lui è in Africa, lascia il suo romanzo alle mani di qualcun altro. Invece per personaggi come la Ginzburg o Pavese, il lavoro è fianco a fianco, editoriale e di scrittura.
I capitoli di Numeri uno collocano i libri nella collana e nel momento storico e culturale in cui escono, ma riportano anche tutta una serie di lettere, messaggi, di pettegolezzi che non sono solo piuttosto divertenti, ma che in fondo formano una sorta di storia orale dell’editoria. È il modo in cui pensavi di raccontarli o è qualcosa che è successo in fase di scrittura?
Nei carteggi si trovano tante cose: in una singola lettera ci sono dalle stoccate alle battute di spirito, a seconda della confidenza in cui l’autore è con il destinatario. Trovi magari un paragrafo personale su quanto è stato bello vedersi al mare l’estate precedente, su come stanno le bambine, una battuta, e poi il vero e proprio lavoro. Capita soprattutto con i carteggi di autori che non si sentono tutti i giorni. Quindi questa commistione di pettegolezzo, di cameratismo o goliardia paralleli al lavoro editoriale è venuta in un certo senso automatica.
Questo avviene soprattutto nelle lettere dei consulenti editoriali: se pensi alle lettere interne a Einaudi, della Ginzburg o di Vittorini con Pavese, viene molto fuori questa sovrapposizione, ma in realtà è ovvio. È un mondo abbastanza piccolo, com’è ancora oggi, e forse allora anche di più: si conoscevano tutti – erano persone normali che volevano anche farsi due risate.
Infatti, da questi carteggi emergono davvero le persone dietro gli autori, ed è una cosa che per chi magari ha letto i loro libri ma scopre per la prima volta la loro voce nella vita di tutti i giorni può essere davvero interessante.
Sì. Per esempio, la Morante a un certo punto va a Torino per correggere le bozze di Menzogna e sortilegio perché ci tiene moltissimo, al punto che le viene la febbre per l’impegno emotivo riversato. Poi la sera si ferma a chiacchierare nei caffè con Pavese, la Ginzburg o altri del gruppo di Einaudi, un po’ nel modo in cui oggi andremmo a fare l’aperitivo.
È tutto molto umano. Nel tempo mi sono andato convincendo che prima dei personaggi ci sono le persone. Anche le stesse scelte che i personaggi fanno sono più date dalle persone che sono che dalle figure che si trovano a essere: la persona prevale sul personaggio storico.
Perché hai scelto di trattare questo periodo specifico?
Numeri uno non è un libro su delle collane, ma sui libri che le hanno inaugurate. Nessuno si aspetti quindi di trovare la storia di una collana, quanti libri ha pubblicato, i grandi successi… Delle collane si parla in modo collaterale.
Una volta scelto il tema bisogna verificare quanto materiale c’è, se è raggiungibile… Dagli anni Trenta ai Settanta si poteva mettere insieme molto materiale, quindi l’idea iniziale era un libro che coprisse gli anni dalla nascita dell’editore protagonista fino a un passo prima delle grandi concentrazioni industriali, quindi con gli anni Ottanta.
Ho cominciato a lavorare sui capitoli centrali perché avevo già del materiale, avevo più facilità su quel periodo, e parlando con l’editore si è cominciato a pensare di escludere il periodo prima della guerra per tenere il libro più unito. Dopo di ciò è arrivato il coronavirus a influire sul lavoro: la chiusura delle biblioteche e la difficoltà di accesso ai documenti mi ha obbligato a ridurre.
Detto ciò, guardandolo oggi forse è meglio avere un libro più compatto che fosse una fotografia di questi vent’anni molto importanti, dallo scoppio della guerra fino alla vigilia del boom economico. In qualche modo il libro c’era, o almeno così sembrava nel momento in cui abbiamo fatto questa scelta. È un po’ frutto del caso, poi ti rendi dopo conto che avresti potuto pensarci prima.
Quando cominci una ricerca, può capitare di trovare cose che non ti aspetti, o di cambiare direzione. Mi racconti il tuo lavoro di ricerca?
In realtà non sai davvero cosa stai raccontando finché non hai finito il capitolo. All’inizio ti puoi fare un’idea ma poi va trovato il materiale per raccontare la storia in modo organico, e la scopri leggendo le lettere, altri saggi sul periodo, o gli atti di convegno, molto importanti perché in queste occasioni partecipa anche chi ha lavorato con l’autore – in questi casi però bisogna sempre cercare di interpretare la fonte, e capire cioè quanto una testimonianza è agiografica, quanto è frutto delle emozioni e dei sentimenti che prova nei confronti dell’autore.
Una volta cominciato non sai dove ti porterà la strada: non sai com’è andata e cosa andrai a raccontare, però questo non cambia la sostanza dei documenti su cui lavori. Non ci sono praticamente più viventi, perciò ciò che puoi fare è leggere i giornali, le interviste, per capire come si è parlato di un autore, e anche lì puoi avere delle sorprese. Ma di fatto non sai niente finché non cominci.
Le fonti poi sono sempre le stesse: solo nel caso di Buzzati ho avuto anche la possibilità di vedere del materiale promozionale, come i materiali informativi per i librai, che è una bella fonte perché è divertente vedere come i libri venivano raccontati negli anni Trenta: non sorprende ma è completamente diverso rispetto a ciò che si fa oggi.
Prima di salutarci, chiacchieriamo ancora per un po’, e anche io insieme a lui mi sento più vicina a coloro che prima di noi si sono confrontati tra una battuta e l’altra sui libri e sulla scrittura.
(Gabriele Sabatini, Numeri uno, minimum fax, 2020, 216 pp., euro 14, articolo di Daria De Pascale)