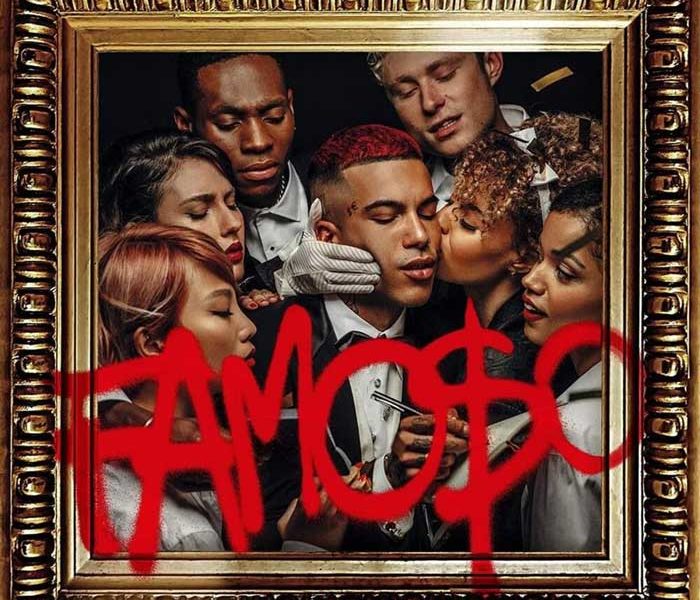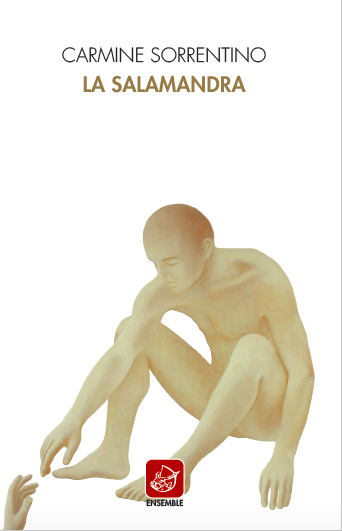Permettetemi di partire con una premessa di natura strettamente personale; poi – come disse qualcuno – mi sposto e vi faccio vedere il film. Trovarmi a scrivere di Tondelli mi ha messo in ansia. Mi ha messo in ansia perché ogni tanto c’è chi, in occasione di qualche ripubblicazione, o anniversario, ci ripensa e scrive che non parliamo abbastanza di Tondelli, ma col ditino alzato, quasi a dire «che poi Tondelli era bravo, ma…» e bisogna avere tutti un’opinione tagliente e circostanziata su Tondelli, bisogna quasi giustificarsi, distinguere il Tondelli di Altri libertini da quello di Camere separate, per non parlare di Rimini!. Come se non fosse possibile dire semplicemente che ci piace, che lo abbiamo sentito vicino, o lontano, e perché.
Forse è questa la cosa più straordinaria di Tondelli, che ho riletto, anzi ho letto davvero, come fosse la prima volta, nel mio trentesimo anno grazie alla guida del bel volume critico di Olga Campofreda, Dalla generazione all’individuo. Giovinezza, identità, impegno nell’opera di Pier Vittorio Tondelli, uscito a ottobre con Mimesis.
Tondelli è divisivo perché è sempre stato diviso. La sua biografia maledetta, la morte a trentasei anni per complicazioni dovute all’Aids e non dichiarate esplicitamente (sul certificato di morte, ricordava Giacomo Papi nel 2016 sul “Post”, citando a sua volta Giovanni Dall’Orto, c’era scritto «polmonite bilaterale»), il fatto che fosse gay e militante ma anche cattolico, che parlasse dalla nicchia ma al pubblico dei best seller.
A quasi trent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 16 dicembre 1991, si continua a discutere degli eredi che (non) ha avuto.
Divenuto prestissimo autore di culto, emblema della controcultura e della contestazione giovanile grazie al suo esordio Altri libertini (Feltrinelli, 1980), che a pochi mesi dalla stampa venne sequestrato per oscenità dal procuratore della Repubblica dell’Aquila, su Tondelli pesa ed è pesato senza dubbio un certo tipo di lettura e di critica postuma, che Campofreda cerca di rimettere in discussione.
E lo fa partendo dall’analisi di alcuni inediti ritrovati negli archivi del Centro di Documentazione istituito nella biblioteca di Correggio, città natale dell’autore, che vengono riprodotti in appendice al volume: i testi delle performance Jungen Werther / Esecuzione e Appunti per un intervento teatrale sulla condizione giovanile, ascrivibili agli anni 1978-79, quando Tondelli si avvicinò all’attività del gruppo di teatro di strada Simposio DifferAnte.
Proprio perché la giovinezza è il filo rosso della produzione artistica di Tondelli, per proporre un nuovo approccio della critica è corretto provare a ricostruire i modi della rappresentazione che l’autore ha via via sviluppato, considerando anche le sue esperienze come editor (l’impegno di raccolta e curatela di giovani autori esordienti del progetto Under 25).
Il limite che Olga Campofreda riconosce alla critica fino a qui risiede nel fatto che l’autore sia sempre stato eccessivamente ricondotto al proprio tempo: «La scrittura di Tondelli ne esce fuori come mera rappresentazione di un determinato tempo storico, dove la riflessione esistenziale e artistica non appartiene all’autore ma risulta frutto dell’interpretazione del discorso a lui esterno. Il continuo riferimento alle influenze, da Celati agli autori della Beat Generation, presente in ciascuno di questi contributi critici, non si evolve in un’analisi dell’originalità del pensiero tondelliano rispetto alle sue fonti. Il problema allora si colloca non nel mancato interesse nei confronti di questo autore da parte della critica, ma nel modo in cui fino a questo momento le opere di Tondelli sono state interrogate. È proprio su questo limite che è necessario intervenire al fine di restituire una certa autonomia e valore all’opera tondelliana».
Campofreda cerca di mettere a sistema tutto quanto è già stato detto dalla critica e suddivide il suo studio in quattro macrocapitoli, nei quali analizza, con estrema cura e una lodevole chiarezza e sistematicità, i diversi momenti dell’esperienza dello scrittore correggese. A partire dalla “mitologia della giovinezza” di Tondelli, la sua ossessione per la rappresentazione di personaggi giovani, e la quasi completa assenza di adulti, che emerge già nelle prime prove di scrittura, gli inediti degli anni 1978-79. In quegli anni Pier Vittorio era studente al DAMS di Bologna e impegnato nella tesi di laurea in teoria del romanzo.
La giovinezza degli esordi letterari è ispirata, prima che da Kerouac e dalla Beat Generation, dagli eroi romantici di Foscolo e Goethe (Jungen Werther). Ma l’idea di suicidio come unica alternativa di non conformazione, in difesa dell’identità dell’individuo, viene presto sostituita dal mito del viaggio on the road, dalla possibilità di libera costruzione dell’identità del singolo. Quel concetto del cercare il proprio odore che supererà il “classico” romanzo di formazione di tradizione otto-novecentesca, in cui il ragazzo si fa uomo entrando a far parte della società borghese, e lo porterà invece, come si vede in Altri libertini e Pao Pao, alla rappresentazione della giovinezza come status di opposizione costante ai concetti di integrazione e omologazione.
I giovani libertini, pur non facendo politica in maniera diretta, esprimono un loro dissenso di tipo culturale. Ma mentre per i protagonisti di romanzi appena precedenti, l’operaio di Nanni Balestrini in Vogliamo tutto!, Rocco e Antonia di Porci con le ali, la lotta sindacale o la liberazione sessuale sono strumenti per arrivare a una qualche forma di maturità che implica (anche) un compromesso, i personaggi di Tondelli rifiutano in blocco la società borghese.
Intorno al 1985, però, al trentesimo anno di età e in concomitanza con il grande successo di Rimini, questo mito inizia a incrinarsi: Tondelli va verso la scrittura più autobiografica e frammentaria di Camere separate e inizia a riflettere su una modalità che possa esprimere la maturazione di un personaggio senza renderlo un conformato.
È la scrittura la chiave di volta, il modo in cui una storia viene narrata: l’incontro con la spiritualità orientale, per la quale d’altronde aveva sempre avuto una fascinazione, risolve l’impasse narrativa grazie al concetto di satori, un momento di rivelazione tramite il quale le differenze vanno a far parte di un Tutto in equilibrio.
L’ultimo capitolo analizza infine il Tondelli curatore: la riflessione dello scrittore sulla giovinezza va avanti tramite l’impegno nel progetto Under 25, in cui si mette alla prova come editor e talent scout con tre raccolte, Giovani Blues, Belli & Perversi e Papergang, uscite per Transeuropa rispettivamente nel 1986, 1987 e 1989. Se da un lato l’intento è quello di dare una possibilità a giovani esordienti di trovare la propria voce, un impegno di tipo culturale e non solo legato all’attualità o a un’operazione furba dal punto di vista editoriale, dall’altro però cristallizza di fatto una sorta di canone del tondellismo che avrà alterne fortune editoriali e che qualcuno non gli ha ancora perdonato.
Dalla generazione all’individuo centra l’obiettivo che l’autrice si era prefissa. Non si tratta di un lavoro su Tondelli, ma attraverso l’autore e tutto quello che ha saputo raccontare di noi, dell’Italia, dei significati che la giovinezza e i suoi simboli possono assumere nella vita di ciascuno.
Se è vero, come dice citando la studiosa Francois Wahl l’altro autore simbolo dei suoi anni, Enrico Palandri, in Pier Tondelli e la generazione (Laterza, 2005), che «lo stile è il suo personaggio migliore, una voce quasi sempre parlata, che diviene a sua volta letteratura», allora il merito maggiore di Olga Campofreda è aver rimesso al centro la fonte, seppur mutevole, l’individuo da cui questa voce è provenuta.
(Olga Campofreda, Dalla generazione all’individuo. Giovinezza, identità, impegno nell’opera di Pier Vittorio Tondelli, Mimesis, 2020. Articolo di Giulia Marziali)
Leggi gli altri articoli di Saggistica