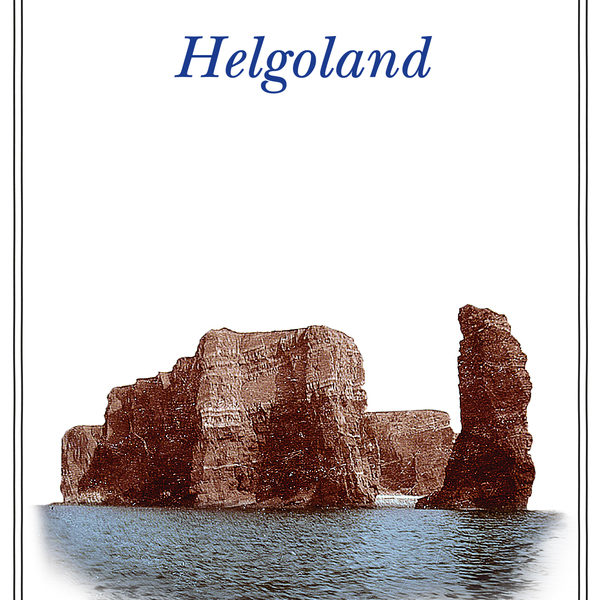«Ci conosciamo davvero papà?» È intorno a questa domanda che si impernia il nuovo romanzo di Anna Giurickovic Dato, Il grande me (Fazi Editore, 2020). È una storia che si iscrive di diritto nel genere dell’autofiction con escursioni nel memoir. Racconta la vicenda di Simone, un uomo poco più che sessantenne, ormai agli ultimi giorni di vita a causa di un tumore al pancreas. Per quegli ultimi momenti che gli restano da vivere, viene raggiunto dai figli a Milano. Mario, Carla e Laura infatti abitano a Roma, hanno vissuto a lungo lontano da lui: dal giorno della separazione di Simone dalla madre dei tre.
Il romanzo è narrato in prima persona da Carla, la secondogenita, ed è attraverso di lei che seguiamo l’evolversi della vicenda, è lei a porsi l’interrogativo citato all’inizio.
Carla sa poco e niente di suo padre, se ne rende conto in quegli ultimi drammatici giorni. Lo vede dimagrire, consumarsi e tenta un disperato recupero identitario e di memoria. Appena riesce fa raccontare a Simone alcuni istanti di vita di cui lei non sa, o sa poco. Ed è nel ricordo di lui bambino, che scopriamo un cortocircuito tra Carla, suo padre e sua nonna. È un amore a cascata e di ritorno. Come Carla ama suo padre, così lui ama sua madre e viceversa. Rimane indelebile questo rapporto fino alla fine, quando Simone si preoccupa – nel delirio finale della malattia – che sua madre, seppur ormai morta, non si preoccupi di quel che gli sta succedendo. È interessante questo caleidoscopio frammentato di amori filiali incondizionati, che esulano appunto da una reale conoscenza reciproca in profondità dei caratteri. È un passaggio di testimone che Carla si impegna a ricevere.
Da qui prende piede «il grande me» che diventa il titolo del romanzo. Infatti è questo passaggio di consegne di padre in figlia, e prima di madre in figlio, a determinare la grandezza di qualsiasi storia familiare; la fiaccola della memoria che prosegue e persegue la vita di ciascuno. Non solo. Il titolo per forza di cose riecheggia a Il grande Gatsby, e qualcosa di Gatsby in Simone c’è. Il suo essere affascinante, la sua teatralità, un certo egotismo, uno sbrilluccichio di un passato non troppo remoto e un segreto che vorrebbe confessare.
Il segreto diventa il motore per spostare, anzi alternare strutturalmente il romanzo da autofiction a memoir. Scavare nel passato del padre permette a Carla (e all’autrice) di indagare e fargli raccontare gli anni della giovinezza, quelli del matrimonio e poi della vita milanese successiva al divorzio. Qui rintracciamo un punto debole del romanzo, l’indagine infatti è sospesa, non è approfondita, alcuni passaggi interessanti della Catania anni Settanta o della Milano anni Novanta, quando Simone viene eletto al Senato in una lista di centrosinistra, restano in superficie così da mancare una più forte caratterizzazione dell’evoluzione di quel padre, monolite indistruttibile che invece nel presente si sta disfacendo.
«Assisto, ogni giorno, a una mutazione rapida e disorganica dove il certo trasloca nell’incerto, un riarrangiamento cromosomico di tutto ciò che c’è in lui di immateriale risponde, come per ribellione, alla disgregazione della sua materia», scrive l’autrice a pagina 84. È la caduta dal certo all’incerto che paralizza Carla, nonostante lei tenti di accudire suo padre, di rendersi utile, ma poi si accorge che niente può salvarlo, che l’ineluttabilità della malattia e della morte devono spingerla a un diverso atteggiamento – di accettazione. L’accettazione passa anche attraverso una breve ma intensa ribellione di una sera, quando suo padre si addormenta e lei cerca di riappropriarsi di sé, della sua femminilità e esce, tirata a festa, e va a trovare un amico del padre. Per fare bene cosa non sa, magari proprio appropriarsi del passato sconosciuto.
Lingua e stile di Anna Giurickovic Dato sono ben calibrate, adatte alla narrazione, un misto di periodi lunghi, che riflettono gli interrogativi e i timori della protagonista, alternati a dialoghi serrati tra figli e padre. La caratterizzazione dei personaggi passa molto bene attraverso le loro voci dialogate, visto che in narrazione indiretta essi passano attraverso gli occhi di Carla, e il lettore rischierebbe di non avere un punto di vista neutro. Così cresce il dolore della sempre più vicina perdita combinato alla presa di coscienza. Anche Simone alla fine, dopo avere tentato di aggrapparsi a inesplicabili speranze e a quel senso istintivo di sopravvivenza che ci caratterizza, sembra accettare la morte, nell’ultimo toccante dialogo che ha con la figlia.
Il grande me è un romanzo ben delineato e compatto, in cui però la realtà dei fatti talvolta sovrasta la verità autoriale, forse questo è un suo difetto, come in parte si accennava prima. Strutturalmente si sarebbe potuto osare di più senza perdere aderenza, alcuni momenti restano semplici assaggi narrativi; uno su tutti il divorzio dei genitori di Carla, lasciato a poche battute in fondo a pagina 112, eppure l’attacco del capitolo 16, in cui la protagonista svela un ricordo della famiglia unita in viaggio in macchina, in cui la felicità risuonerà come «una parola a cui non diamo nessuna importanza […], non sappiamo ancora che non tornerà», avrebbe meritato più spazio a scapito anche di frantumare la rigida struttura temporale.
Resta in ogni caso un romanzo che merita di essere letto, che merita di posarsi parola per parola, nel tentativo di dare una risposta al quesito iniziale, e che caratterizza chiunque, non solo la protagonista: «Ma noi ci conosciamo davvero?».