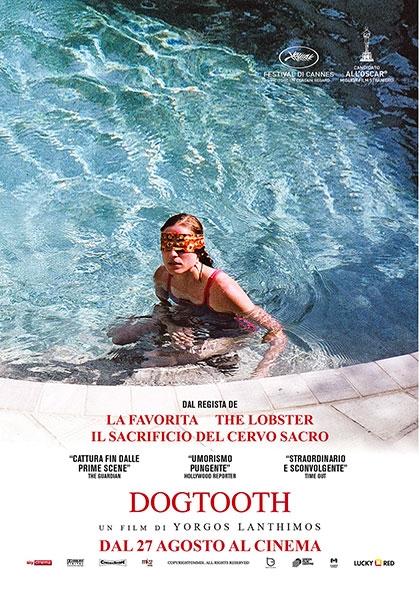«Al verme che per primo ha corroso le fredde carni del mio cadavere dedico come caro ricordo queste Memorie Postume» recita la dedica dell’autore di questo romanzo (Machado de Assis, Memorie Postume di Brás Cubas, Fazi, 2020). Un libro ironico, divertente ma tutt’altro che leggero, pur non richiedendo al lettore alcuna fatica. Pubblicato nel 1880, è un grande classico di una letteratura e di un autore ingiustamente poco noti.
L’espediente originale di scrivere le proprie memorie post mortem offre una doppia funzione: essere l’io narrante e allo stesso tempo mantenere quella distanza da sé e dagli avvenimenti narrati da risultare distaccato e giudice scanzonato. Le poco più di trecento pagine ariose si suddividono in centosessanta capitoli a volte pugnaci, altre volte riflessivi o amarognoli, o persino sardonici, ma mai incattiviti, e raccontano la vita di un esponente dell’alta borghesia brasiliana di fine Ottocento, destinato a una brillante carriera per doti naturali e grazie a impegnativi studi in Europa, a un buon matrimonio grazie alla frequentazione dell’élite, a diventare persino ministro grazie all’ambiente che lo circonda. Eppure Brás Cubas non approderà a nulla per carattere, indolenza e scelta. Anche le sue storie d’amore si risolvono nel nulla, perché si innamora della persona sbagliata o perché non è in grado di assumere le sue responsabilità, di decidersi. Tuttavia non è una persona amareggiata né mal disposta, le sue risorse, la sua preparazione e cultura gli fanno attraversare la vita a passi levigati e gli donano serenità e saggezza. In particolare lo sostiene la filosofia dell’umanitismo, cui dedica pagine importanti che collegano anche a un’altra opera fondamentale del meticcio Machado de Assis, Quincas Borba.
Molto apprezzato da Saramago, Woody Allen, Susan Sontag e Dave Eggers, questo romanzo può essere accostato ad altri grandi classici in altre lingue. Difatti, analogie sono state sollevate con Tristram Shandy di Laurence Sterne, per fare un esempio, e viene in mente, anche con una certa insistenza, La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Si può anche affermare senza timore di smentita che esso anticipa alcuni temi che saranno affrontati solo decenni dopo in altre aeree letterarie.
È sempre approssimativo l’approccio a un’opera di una letteratura poco conosciuta, al lettore mancano parecchi elementi per inquadrarla bene, con il rischio di poterla apprezzare meno, e soprattutto di non comprenderla bene. Può essere d’aiuto il traduttore, solitamente un esperto di quella letteratura, dell’autore, ed è anche il lettore più attento dell’opera. Perché, come dice Claudio Magris, «è difficile imbrogliare quel sosia che è il traduttore». Daniele Petruccioli, il traduttore delle Memorie Postume di Brás Cubas, traduce da molti anni e con ottimi risultati dall’inglese, dal francese e dal portoghese, è anche docente universitario di Teoria della traduzione e di Traduzione editoriale, ed è autore di importanti saggi. Gli abbiamo chiesto lumi su questo romanzo e sulla letteratura brasiliana, e dopo la lettura delle sue risposte esaustive, chiarificatrici e molto interessanti, con ogni probabilità il lettore avrà un rapporto più maturo e molto più stretto con Machado de Assis e con la letteratura brasiliana.
Durante la pandemia ho ascoltato su la tua traduzione di un brano di Os sertões, il romanzo di Euclides da Cunha, in un video che avevi girato per il Dopolavoro Stadera. Mi ha molto incuriosita e ho raccolto qualche informazione sul romanzo e sull’autore, e al contempo mi sono resa conto di non sapere praticamente nulla della letteratura di un paese immenso come il Brasile. Sfortunatamente l’edizione italiana di Os sertões si fa ancora attendere, ma poco dopo ho scoperto che usciva invece un altro classico brasiliano sempre tradotto da te, che si presentava altrettanto interessante. Memorie Postume di Brás Cubas di Machado de Assis è stato per me una grande scoperta, credevo ingenuamente che la letteratura brasiliana indispensabile si esaurisse con il Grande Sertão di João Guimarães Rosa, e con i romanzi di Jorge Amado. Puoi raccontarci in che modo o perché ti sei avvicinato alla letteratura brasiliana?
Da adolescente, mi sono interessato alla letteratura brasiliana come tutti, leggendo i grandissimi autori pubblicati dalle grandi case editrici – Jorge Amado, Clarice Lispector, Guimarães Rosa… – ma senza nemmeno rendermi conto che erano brasiliani: li leggevo come leggevo gli altri grandi sudamericani, Borges, García Márquez, Vargas Llosa, Isabel Allende… Soltanto all’università, quando ho deciso di studiare portoghese e tedesco (perché il francese e l’inglese li parlavo già bene e non volevo “barare”, né, soprattutto, studiare cose che sapevo già), mi sono avvicinato in modo più sistematico alle letterature di lingua portoghese. Non solo Brasile, ma appunto anche Portogallo, Africa, Asia. E ho scoperto, come sempre avviene quando si va a guardare le cose un po’ più da vicino, una miniera d’oro e di pietre preziose. Inoltre, il Brasile mi affascinava a livello linguistico perché il portoghese che si parla lì è una variante con una storia particolare ma ricchissima, oltre al fatto di rappresentare il numero di parlanti più grande del mondo. Infine, leggendo questi romanzi non solo in originale ma anche in traduzione, ho scoperto una storia di traduzioni variegata, complessa, sperimentale, modernissima già dagli anni Settanta, con traduzioni storiche come quelle di Edoardo Bizzarri di Grande Sertão per Feltrinelli o di Giuliana Segre Giorgi di Macunaíma del modernista Mário de Andrade per Adelphi. Questo mi ha entusiasmato tanto da spingermi a fare carte false pur di laurearmi – in tempi in cui una laurea in traduzione era ancora guardata con un certo sospetto – proprio su di esse. Ma la loro fortuna era talmente povera in Italia che la mia correlatrice (una comparatista, sia detto a sua discolpa) in sede di discussione mi rimproverò di non aver citato le traduzioni di Ungaretti, cosa che la commissione giudicò non tanto scandalosa da togliermi la lode ma abbastanza grave da non concedermi la dignità di pubblicazione. Non ebbi il cuore, o la presenza di spirito, in quella sede, di spiegare che Ungaretti aveva tradotto Oswald de Andrade, un quasi omonimo di uno dei miei oggetti di studio ma pur sempre un altro autore, e non lo avevo quindi citato a buon diritto… Da allora, dopo avere intrapreso la mia carriera come traduttore, il Brasile è stato – per una serie di casi un po’ paradossali, ma la vita è così – molto più presente nella mia vita del Portogallo stesso. Ho avuto modo di andarci, per motivi di studio e non solo, più spesso di quanto mi sarei aspettato, imparando a conoscerne meglio la letteratura e soprattutto gli scrittori, soprattutto giovani. Così, quando dopo i normali inizi più eclettici ho deciso di specializzare la mia attività di scout editoriale, è stato quasi naturale andare a leggere e a cercare le novità di laggiù. Attraverso questa parte del mio lavoro ho avviato e consolidato rapporti – oltre che con gli scrittori – con traduttori, editor, agenzie letterarie, e piano piano mi sono ritrovato al centro di una piccola rete che mi permette di essere abbastanza al corrente (per quanto possibile in un Paese che assomiglia più che altro a un continente) sulle novità editoriali brasiliane e le tendenze letterarie di quello sconfinato territorio dell’anima che nel frattempo è diventato, per me, il Brasile.

Potresti aiutarci a capire qualcosa dell’evoluzione linguistica, credo si trattasse addirittura di una sorta di rivoluzione, che ha generato il portoghese brasiliano? Se non sbaglio ha a che fare proprio con il romanzo di Euclides da Cunha. In questo contesto linguistico Machado de Assis dove si colloca?
In realtà non proprio una rivoluzione. O quanto meno non unica nel suo genere. Si tratta della normale evoluzione di una lingua veicolare quando attraversa un oceano. La particolarità sta più nelle ripercussioni che un simile distanziamento ha avuto nei rapporti politico-culturali tra il Brasile e l’ex madrepatria coloniale portoghese, tema di cui mi sono occupato per la rivista tradurre. Quanto a Euclides Da Cunha, il suo, invece, è proprio un caso particolarissimo: non essendo un romanziere né in fondo un saggista, ma fondamentalmente un ingegnere prestato al giornalismo, il suo capolavoro Os sertões, nonostante moltissime pagine dallo stile maestoso (di una maestà alla Mahler, oserei dire), ha un taglio tutto sommato molto giornalistico e fattuale, addirittura tecnico, per certi versi alla Melville se vogliamo, o comunque molto affine al giornalismo storico anglosassone e soprattutto americano. Proprio per questo ha finito per avere, secondo me (ma la questione critica resta molto aperta), un’influenza enorme sulla prosa novecentesca brasiliana, forse ancor più di Machado. Ciò non toglie che Machado de Assis, per ragioni storiche, personali e di talento oltreché di mole dell’opera, resti direi incontestabilmente il punto più alto della letteratura brasiliana ottocentesca, riconosciuto unanimemente tale anche in patria. E se Euclides è forse un modello più seguito, pur senza nulla togliere alla sua particolare grandezza, ritengo che la ragione sia nel fatto che il suo stile è più facile rispetto a quello di Machado. Non tanto da leggere (Machado è di una naturalezza, di una facilità stupefacenti) quanto da rifare. L’immediatezza di Machado, infatti, la sua cultura sconfinata, la sua capacità di leggere tra le righe della storia contemporanea in modo sottilissimo e soprattutto la sua ironia, la sua incredibile capacità di essere un vero sornione metaletterario, per così dire, non è così facilmente imitabile. Non sorprende che praticamente nessuno ci abbia ancora provato.
Sarebbe possibile saperne di più di Machado de Assis e della sua fortuna italiana? Dalle pagine di questo suo romanzo straordinario emerge un letterato fortemente impregnato di cultura europea, cita persino il nome di Klopstock.
Machado de Assis, formatosi da autodidatta perché troppo povero per studiare (proveniva da una famiglia meticcia di origini portoghesi, poco più che operaia), era culturalmente un onnivoro vorace. Non solo dal punto di vista letterario ma anche storico, politico, sociale, di costume. La sua cultura sull’Europa, benché sia senz’altro al di sopra della media anche rispetto a un europeo, non deve sorprendere, considerando il senso di inferiorità storico (per quanto senz’altro forzosamente inculcato) delle ex colonie nei confronti dell’ex metropoli. Era naturale, per l’uomo colto, sapere tutto quanto possibile sull’Europa. Quello che è già modernissimo in lui è piuttosto la capacità di destrutturare queste sue conoscenze con un’ironia coltissima e sottile. E soprattutto il fatto che non le mettesse mai al di sopra dei fatti culturali, sociali e letterari brasiliani, di cui pure la sua opera è costellata senza nessun senso di inferiorità. Da questo punto di vista, mi sarebbe piaciuto poter inserire qualche nota in più (proprio perché Machado è più colto del lettore italiano contemporaneo – e forse di qualsiasi lettore) ma alla fine con l’editore ci siamo accordati di spiegare solo le caratteristiche tipicamente brasiliane del testo, lasciando quelle europee alla buona volontà di chi legge. Un po’ mi dispiace, perché certe ironie davvero non si colgono senza conoscere le dispute politiche in Francia all’epoca di Luigi Filippo, ma va bene così. Oggi abbiamo tutti un cellulare in tasca, è tutto più facile.
Quanto alla fortuna italiana di Machado, come ha spiegato bene Roberto Mulinacci, è relativamente ampia ma molto discontinua. A parte le traduzioni degli anni Venti e Trenta, soprattutto di Giuseppe Alpi, il primo tentativo di una traduzione non diciamo sistematica ma almeno dei capolavori cosiddetti “realistici” del suo cosiddetto secondo periodo (Memórias póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba – che rappresentano comunque una parte infinitesimale del grande corpus machadiano, ancora in gran parte non tradotto da noi) è di Laura Marchiori, che traduce la trilogia per Rizzoli. Ma anche qui, dal suo primo Memorie dall’aldilà (Brás Cubas: 1953) a Quincas Borba (1967) passano ben quattordici anni. Questi tre romanzi sono stati poi variamente tradotti negli anni, soprattutto da case editrici come Fazi e Lindau ma anche da case editrici più piccole, che spesso nel frattempo hanno chiuso, o ancora di stampo accademico e quindi di scarsa o nulla distribuzione. Esistono poi, tra gli anni Ottanta e Novanta con qualche punta nei primi del Duemila, le traduzioni di Rita Desti, Amina di Munno e Liliana Segre Giorgi non solo di questi e altri romanzi e novelle come Memoriale di Aires o L’alienista ma anche diverse raccolte di racconti, che sono bellissimi, per case editrici più grandi come l’UTET o Einaudi. Ma sono tutte iniziative isolate. Manca non dico un’opera omnia, ma almeno un progetto editoriale delle opere più importanti curate da uno stesso traduttore, o almeno da un gruppo affiatato che lavori insieme partendo da una visione comune. Speriamo che questo mio Brás Cubas, che segue il Don Casmurro di Gianluca Manzi e Léa Nachbin uscito nel ’97 per lo stesso editore, possa segnare l’inizio di un rinnovato interesse che preluda a un’operazione di questo genere.
Una richiesta di consigli di lettura: quali sono le opere indispensabili e disponibili in italiano per un lettore intento a farsi una buona conoscenza della letteratura brasiliana?
La letteratura brasiliana nasce nel Seicento con il grande prosatore gesuita (nato a Lisbona ma morto a Salvador de Bahia) Antônio Vieira e finisce… no, scusa, ovviamente non è ancora finita… allora diciamo che ricomincia con gli scrittori delle favelas e le scrittrici nere. È anche vero che se si vuole andare in libreria qui in Italia si trova pochissimo. Comunque, senza velleità esaustive che non mi competono e andando per macroperiodi, comincerei – visto che è stato da poco ritradotto da Virgilio Zanolla per Nulla die – con Iracema del grande autore romantico nonché amico e patrono di Machado (che scrisse benissimo proprio di questo romanzo) José de Alencar. Poi Machado de Assis, naturalmente, cominciando dalle Memorie postume per continuare, volendo, con gli altri due libri della trilogia ancora reperibili, ma senza lasciarsi scappare i racconti (dovrebbero essere ancora in catalogo almeno quelli nella traduzione di Amina di Munno per Einaudi: La cartomante e altri racconti). Secondo me imprescindibile, come una roccia calcarea tra i graniti, Os sertões di Euclides da Cunha, del 1902, che era stato tradotto da Cornelio Bisello per la Sperling&Kupfer nel 1953 con il titolo Brasile ignoto. L’assedio di Canudos, ma è ormai fuori catalogo da lunga pezza e chi vuol leggerlo senza recarsi in biblioteca dovrà aspettare l’uscita della mia traduzione per Adelphi. Passando al modernismo e attenendosi all’essenziale (del resto, ancor meno dell’essenziale è stato tradotto), resta imprescindibile Macunaíma di Mário de Andrade. Salto i famosi (Guimarães Rosa, Lispector – recentemente ritradotta da Roberto Francavilla per Adelphi e Feltrinelli –, Amado, anche Chico Buarque), comunque fondamentali; sono costretto a saltare la cosiddetta literatura marginal (scrittori da e sulle favelas) perché il poco che è stato tradotto secondo me non è abbastanza valido né rappresentativo; salto i poeti (ma uno sguardo almeno a Mário Quintana e soprattutto a Carlos Drummond de Andrade – di cui qualcosina è ancora in catalogo – lo darei) e arriviamo ai contemporanei. Faccio alcuni nomi da sud a nord: Moacyr Scliar, tradotto da Guia Boni per Voland (imprescindibili secondo me almeno I leopardi di Kafka e La donna che scrisse la Bibbia, ma sono tutti bellissimi), Carol Bensimon (Biliardo sott’acqua è uscito da poco per Tunué nella mia traduzione) e soprattutto Daniel Galera (di cui Sur ha pubblicato di recente Barba intrisa di sangue nella traduzione di Patrizia di Malta) che è forse il più promettente di tutti ma secondo me deve ancora scrivere il suo grande romanzo. A Rio e San Paolo c’è molto altro, ma il meglio non è stato tradotto (peccato). Forse il più grande di tutti oggi è però il mineiro Luiz Ruffato, tradotto da Roberto Francavilla per La Nuova Frontiera – purtroppo però non è stato ancora tradotto il suo capolavoro Inferno provisório, una geniale pentalogia di uno sperimentalismo linguistico pirotecnico. Infine un classico moderno: Il pane del patriarca (Lavoura arcaica), capolavoro del 1975 di Raduan Nassar, tradotto da Amina di Munno per Sur. È poco. È vago. È disperso. Bisogna cercare di più, seguire di più, tradurre di più. Il Brasile letterario è la caverna dei Quaranta Ladroni, il tesoro di Smaug, l’harem di Harun al-Rashid: chi ci entra non esce più dalla gioia.
La tua traduzione di Memorie Postume di Brás Cubas appaga magnificamente il doppio bisogno che il lettore avverte quando legge un romanzo scritto in epoca lontana: il gusto del testo d’antan e il volerlo sentire vicino. Qual è il segreto?
Intanto grazie per il complimento. Ma non ho molto merito. Me lo sono fatto dire da Machado… Lui usa uno stile altissimo con grandi inserti colloquiali, a volte quasi popolari. La sua prosa è intrisa di ironia, giudica e svela se stessa a ogni passo, si commenta, si prende in giro. Per giocare al suo gioco ho scelto una sintassi abbastanza elaborata cercando di spolverarla di parole e locuzioni modernissime (non tanto quanto alla loro apparizione nel nostro lessico – sono tutti termini già vivi nell’Ottocento, salvo pochissime eccezioni – quanto nell’uso: sono parole e locuzioni ben vive e in salute ancora nel Duemila). Nelle ritraduzioni, secondo me, è un errore farsi guidare da un apriorismo rammodernante o anticante, oppure – per usare una altra coppia oppositiva oggi alla moda – straniante o addomesticante (stare cioè più attenti a far sentire al lettore “lo straniero” o, viceversa, a farlo sentire linguisticamente “a casa” – come peraltro se “straniero” e “a casa” fossero concetti facili da definire e su cui siamo tutti d’accordo). Per tradurre non c’è un segreto univoco. Ogni libro ha il suo, o meglio una serie di caratteristiche che lo contraddistinguono. Basta saper ascoltare.
Un sentito ringraziamento a Daniele Petruccioli per questa intervista che si è trasformata in lezione, una fonte di idee e informazioni che torneranno molto utili anche nel tempo.