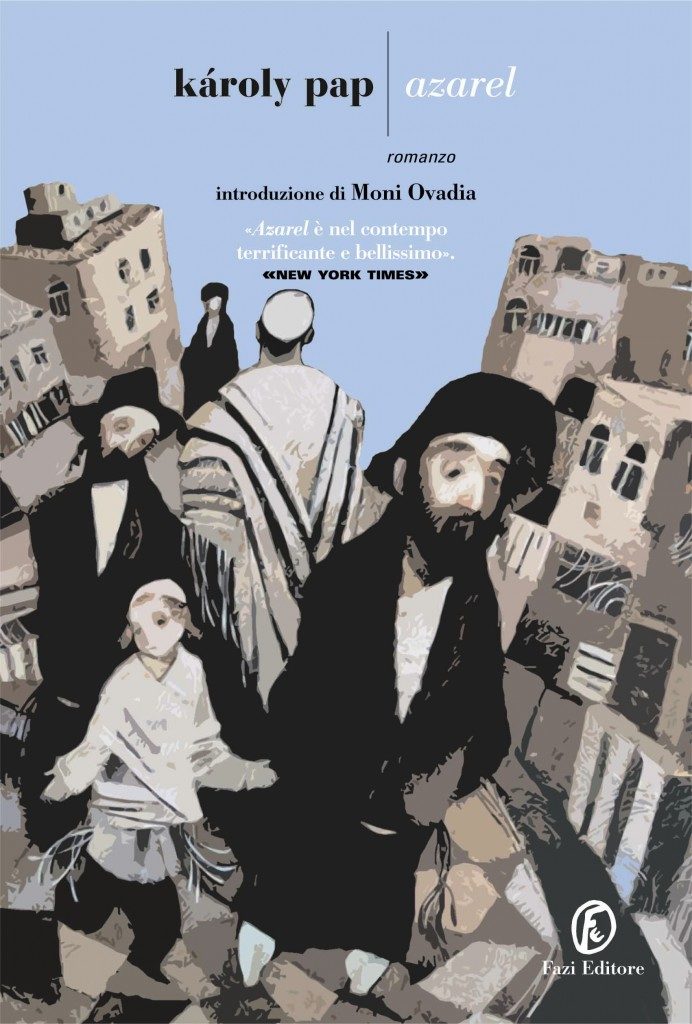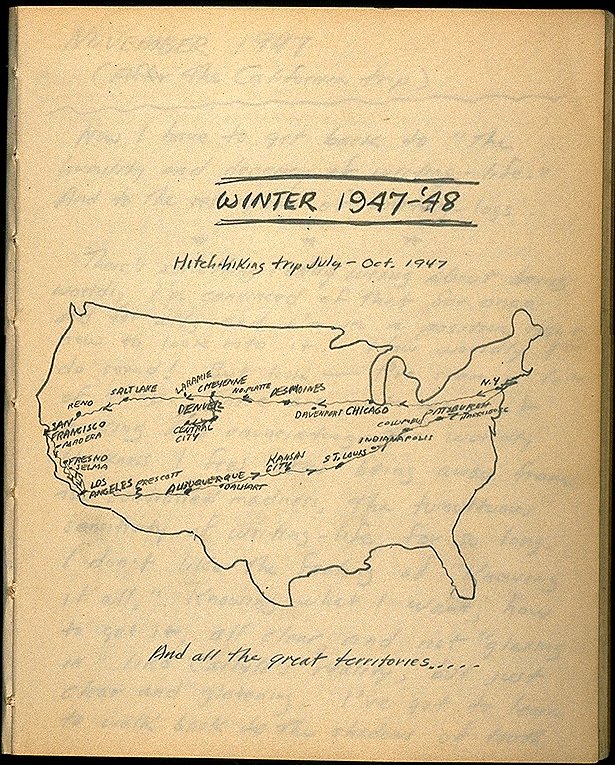La prima cosa da fare è partire dal concetto di privilegio.
«Provate a pensare a qualcosa che vi rende più fortunati degli altri. Non lo vedete? Ecco, questo è il punto per cui per molti uomini è così difficile vedere il proprio privilegio e accorgersi della disparità di genere. Mettersi nei panni degli altri, quando si sta tanto comodi nei propri, non è facile per nessuno».
Con questo assunto si conclude Le ragazze stanno bene (Harper Collins Italia, 2020), libro di Giulia Cuter e Giulia Perona, già ideatrici e curatrici del podcast e della newsletter Senza Rossetto, progetto che racconta le donne senza stereotipi e oltre ogni convenzione. La riflessione sul significato di privilegio costituisce in realtà il punto di partenza per avvicinarsi e iniziare a comprendere i temi del libro in cui un unico io narrante – che include non solo le autrici ma le loro nonne, le amiche, le scrittrici lette – combina insieme esperienze personali, dati statistici, citazioni ed episodi reali per arrivare a operare un confronto lucido e realistico sulla situazione delle donne da ieri a oggi.
Le autrici hanno suddiviso il lavoro in capitoli tematici dedicati a diversi momenti o fatti significativi, a volte simbolici, nella vita di una donna e, per ognuno di essi, ne raccontano il senso, il cambiamento della rappresentazione attraverso gli anni, i passi avanti compiuti e le piccole vittorie, la strada ancora da percorrere. E come cambia la percezione del medesimo momento da parte di ciascuna donna.
Interrogandosi sul rapporto con l’eredità delle donne che le hanno precedute e con le conseguenze delle loro battaglie, Giulia e Giulia percorrono le fondamentali e inevitabili tappe del femminile – dalle mestruazioni alla maternità, dal corpo alle relazioni, dal lavoro al matrimonio – fornendo un quadro di verità, a volte sorridente, a volte sconcertante, in cui è impossibile non ritrovarsi almeno una volta, riuscendo in tal modo a trasformare ogni fatto personale in comune denominatore universale.
Come sosteneva Chimamanda Ngozi Adichie in Cara Ijeawele. Quindici consigli per crescere una bambina femminista (Einaudi, 2017), una stereotipata suddivisione dei ruoli di genere è «una grande sciocchezza» perché la rigidità precostituita non è di alcun aiuto all’educazione dei bambini e allo sviluppo dei futuri adulti. Nel capitolo sull’Educazione, ci si chiede: chi ha deciso che il colore rosa appartiene alle femmine e l’azzurro ai maschi? Tutti i bambini amano le automobili e le armi giocattolo mentre le bambine sono destinate alle bambole?
Sono ruoli imposti e radicati dal ripetersi negli anni dei medesimi stereotipi, dati per scontato in quanto parte di una passiva quotidianità, ma sono ruoli che possono essere ancora scardinati o messi in discussione e in quest’ottica l’importanza dell’educazione riveste un compito imprescindibile. Soprattutto perché un’impostazione educativa differente è possibile, come dimostrano alcuni degli esempi citati: in Svezia, dove si promuove una cultura neutrale, mirata a crescere i bambini indipendentemente dal loro sesso; nei Paesi Bassi, dove l’educazione multidisciplinare alla sessualità comincia a scuola all’età di quattro anni.
Per parlare di Maternità si parte invece da un excursus sulla disciplina dell’aborto in Italia e soprattutto sulle battaglie che lo hanno reso legale, si parla di contraccettivi e di perdita della verginità, di violenza ostetrica e di depressione post partum. Grazie al racconto di legislazioni lontane, di percorsi di ribellioni e diritti, di storie vissute in prima persona, si riesce a dimostrare che maternità non vuol dire una cosa sola ma che gli aspetti che la compongono sono molteplici e vanno dal consenso al desiderio alla scelta di non vivere questa esperienza.
Le ragazze stanno bene attraversa così ogni tappa della vita, ne affronta le intemperie, non si lascia scoraggiare dai precedenti, ha fiducia nel futuro. Il tutto tenendosi saldo a un unico coerente sguardo, quello femminista.
«C’è una parola in particolare che ci ha fatto paura per molto tempo: femminismo. A lungo l’abbiamo snobbata, evitata, sussurrata per il timore di sembrare troppo radicali o estreme, ma col tempo ci siamo rese conto che il femminismo è ciò di cui abbiamo bisogno per vincere le sfide che dobbiamo ancora combattere. Femminista è chiunque creda nella parità sociale, politica ed economica tra i sessi, e chiunque sia convinto che il sesso biologico non sia un fattore rilevante nella determinazione dei diritti di un individuo. Possiamo e dobbiamo esserlo tutti, donne e uomini, senza distinzione di età, etnia o orientamento sessuale».
(Giulia Cuter e Giulia Perona, Le ragazze stanno bene, Harper Collins Italia, 288 pp., euro 16, articolo di Francesca Ceci)