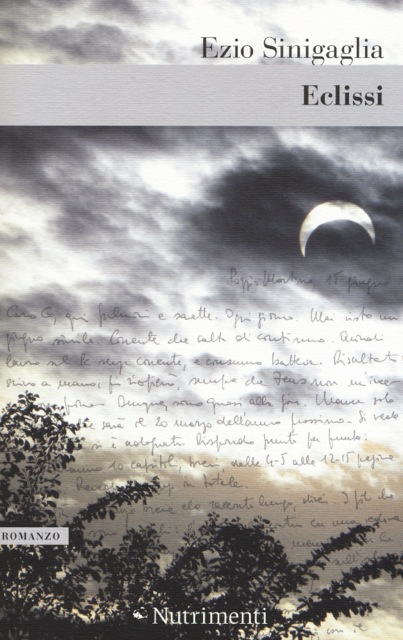«Se l’Aspirante è giovane, digli che è troppo giovane, se è vecchio troppo vecchio, se grasso troppo grasso… ma se attende davanti alla porta per tre giorni senza mangiare, senza una coperta né essere incoraggiato, fallo entrare per cominciare l’allenamento».
D’accordo, abbiamo scherzato: nonostante Vanni Santoni possa essere considerato per la sua vena postmoderna e iconoclasta il Tyler Durden dello scouting letterario italiano, il minisaggio La scrittura non si insegna (Minimum Fax, 2020) non assomiglia a un Fight Club né al terroristico progetto Mayhem, anche se l’onestà del suo approccio va dritto come un treno e si segnala come ottimo viatico per chi desidera avvicinarsi all’arte della scrittura. Come si fa, dunque, a buttar giù un romanzo come si deve? Mettendosi a dieta, Santoni dixit.
Non è una trovata da sciamano americano del creative writing (seppur il nostro abbia già nel nome il destino del guru), perché il menu che propone l’autore di I fratelli Michelangelo assomiglia semmai a una grande abbuffata di discreti mattoni (pardon, propedeutiche letture): dalla Recherche proustiana a 2666 di Bolaño, passando per Infinite Jest di David Foster Wallace fino ai tre volumi di Abbacinante di Cartarescu e via di questo passo, per un totale (del tutto provvisorio) che supera le diecimila pagine. Infatti, è solo l’antipasto: il listone completo annovera trenta titoli imprescindibili per chi voglia solo osare mettersi a scrivere, eppure, non è il meglio della letteratura mondiale, come lo stesso scrittore toscano riconosce.
Quindi: via Kafka e dentro Philip Roth, più Austerlitz e meno Gatsby, poiché l’eccellenza stilistica non servirà all’Aspirante quanto i romanzi-mondo, imperfetti contenitori del Tutto, necessari ad alleviare i dolori del giovane lettore con «un paio di schiaffi sul culo… onde aprire i polmoni». Invero, il gioco delle liste è mutevole: La scrittura non si insegna ne propone subito un’altra poche pagine dopo. In fin dei conti, come ogni Dieta che si rispetti, basta che funzioni: l’importante è non correre a casaccio, ma a tappe forzate verso librerie e biblioteche.
E dopo la Dieta? Viene la Disciplina, la quale ha un solo dogma, anzi tre: scrivere, scrivere, scrivere, però tutti i giorni, senza eccezioni (a meno di cataclismi). Mai prendere la scrittura come il calcetto del giovedì sera: deve diventare per l’Aspirante un’attività a cui dedicare una parte precisa delle proprie giornate (tutte, insiste Santoni), anzi, una delle occupazioni principali della propria vita, da cui partire per costruire il resto, proteggendola dagli attacchi del quotidiano (e di fidanzate/i, social e impiccioni vari).
Bene, e dopo? Viene da sé: Santoni prosegue con altri consigli, forte dell’esperienza di direttore editoriale di Tunué, fucina di giovani esordienti di talento, nonché come docente di scuole di scrittura (non è un controsenso, piuttosto il segnale che la teoria è stata sperimentata sul campo); tuttavia, le raccomandazioni risulteranno meno decisive della “doppia D” di cui sopra, perché incentrate soprattutto su ciò che bisogna evitare in fase di composizione, revisione, confronto e pubblicazione.
L’assioma di La scrittura non si insegna non viene tradito: l’apprendistato non riguarda ciò che si scrive, poiché «la vastità infinita delle possibilità di un testo narrativo implica che infinite cose si possano scrivere in infiniti modi». Meglio, propone Santoni, concentrarsi su chi scrive: il potenziale autore deve trasformarsi prima in vero scrittore. Troppo banale? Il buonsenso lo è, chiosa Santoni. Funziona per tutti? Forse no, ma quelli per cui funziona molto probabilmente se ne accorgeranno.
(Vanni Santoni, La scrittura non si insegna, minimum fax, 2020, 95 pp., euro 13, articolo di Domenico Ippolito)