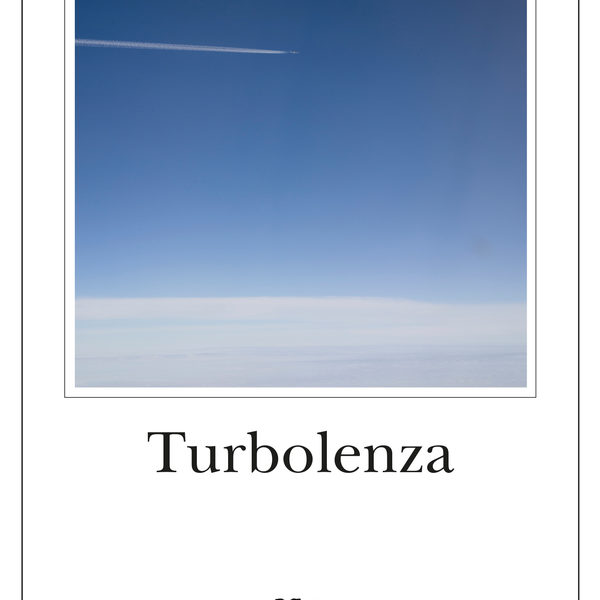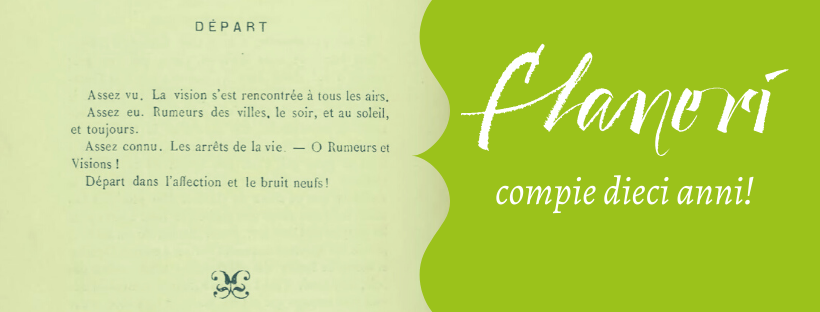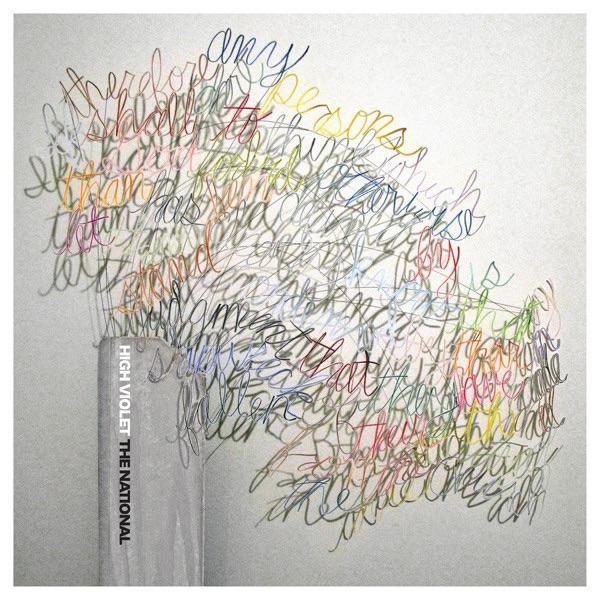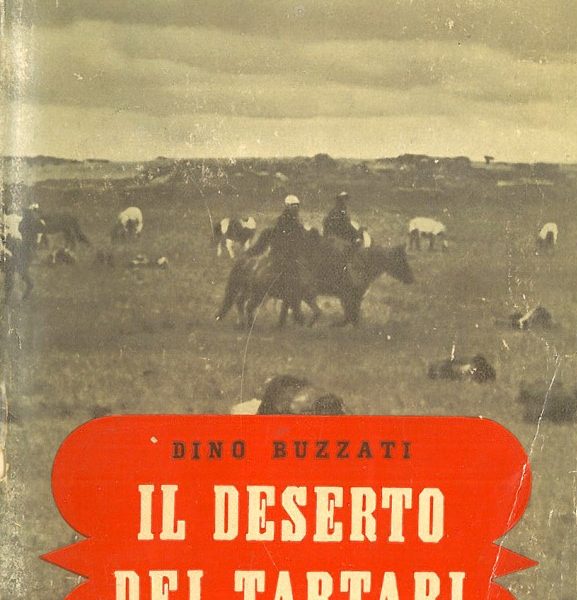Esistono libri in cui la trama è solo una scusa per entrare nel vivo di ciò che si vuol davvero dire. È il caso di Nessuno rivede Itaca di Hans Tuzzi (Bollati Boringhieri, 2020): Tommaso, un musicista borghese fiorentino, incapace di avere relazioni durature con le donne (si è sposato, però, una volta, e dal matrimonio è nata una figlia, amata e ormai lontana), riceve dopo il suo cinquantesimo compleanno una busta da Massimo, scrittore gay coltissimo, amico di famiglia e suo mentore, morto poco tempo prima. All’interno ci sono cartoline, lettere, ricordi di vario tipo e una chiavetta USB contenente un suo romanzo inedito. Titolo: Nessuno rivede Itaca, eponimo o omonimo del romanzo di Tuzzi.
Comincia così un lungo confronto tra i due protagonisti; una complessa riflessione formata da un mosaico di ricordi diffratti, che scorrono ininterrotti. Tuzzi non racconta; gioca magistralmente con le parole, punteggia, distilla: evoca momenti personali e stralci della storia italiana; accosta aneddoti ironici e taglienti ad alte considerazioni, che arricchisce di dettagli ma non ama sciogliere: quasi un invito a esprimere la nostra opinione. Oppure – suggerisce un’altra voce dentro di me – a precipitare nell’abisso che è in noi (come direbbe Edipo re di Pasolini), a scavare nella curiositas, cercando con piacere tutte le citazioni e i riferimenti presenti nel libro; a leggere con godimento tutti i ricercati accostamenti di parole; a perdersi dentro gli inganni, che partono dal titolo: chi rivede Itaca? L’impressione è infatti quella di essere di fronte a una tragedia avvolta da un divertissement ammonitore: non fa di te un uomo di cultura il sapere le cose, ma la gioia che provi nel cercarle, affiancarle, stravolgerle. In questo senso è quasi un libro settecentesco, da opera buffa.
Ma c’è dell’altro e, se si vuole, si viene trascinati in un vortice hegeliano (o forse schellingiano) in cui a pensieri sulla cultura, l’arte, la musica, la vita, si susseguono senza tregua i ritratti dei luoghi e delle persone, delle città, delle guerre; e riflessioni sull’Europa contemporanea, mai realmente nata, e quindi, forse, incapace di morire.
Se non volutamente la trama, sono i personaggi le colonne del libro. Ed è su di loro – forse più su uno che sull’altro – che vorrei concentrarmi. Protagonista assoluto è Massimo, intellettuale archetipico, classe 1936, a metà strada tra un dandy e un flâneur; condivide con Malraux gli eccessi di vita, il fragile confine tra verità e menzogna, e il desiderio feroce di indagare il mondo. Non a caso, è allo scrittore francese che Massimo affida una delle prime citazioni che si ritrovano nel libro: «“Quando ritorni dall’Asia e trovi tutti i tuoi compagni della Nouvelle Revue Française che scrivono romanzi sull’omosessualità e a essa attribuiscono un’immensa importanza, sei tentato di dire che esistono anche altre cose”. Ecco [prosegue Massimo] per me sono sempre esistite, prima, altre cose. Ma questo non mi ha impedito di essere serenamente frocio, e assiduamente praticante».
In lui, sembrano trovarsi tracce di Pasolini: li unisce, probabilmente, l’attrazione per gli amori difficili; l’avversione per la metafora e, per dirla con Arbasino, «l’idea che una cosa in sé significhi solo sé stessa (per G. Stein: una rosa è una rosa… per Pasolini: un pompino è un pompino)». Ma non ci si inganni, a dividerli accorrono due cose essenziali: la mancanza di ironia dello scrittore romano d’adozione e l’impegno degli intellettuali in politica: «I poeti alla larga dalla cosa pubblica», sostiene, attraverso Platone, Massimo.
Estraneo a qualunque città, il protagonista dice di essere figlio della Venezia oscura e inafferrabile di Thomas Mann e di avere (usando le parole di Fenoglio) «due sangui [che] fanno dentro le vene una battaglia»: un padre mai conosciuto e una madre che «stava al di là dell’acqua, sotto il nero e l’oro dell’aquila imperiale». Si scorge, nitido, un dualismo dagli echi junghiani; una dicotomia costante che si rincorre in tutto il romanzo: due i protagonisti, due gli stili di scrittura, mentre il passato e il presente incombono e il bene e il male sottendono la realtà.
E ancora due sono, infine, le progenitrici mitiche della Grande Fortuna, opera di Dürer che troneggia nella casa avita di Massimo: essa è la dea del destino nata dall’unione della Fortuna romana e della Nemesi greca, e ricorda, con il suo corpo grave e mascolino, la forza che esercita sulle vite degli uomini.
Ma è con Clio che Tuzzi sembra ingaggiare la lotta più ardua: il passato è sempre, quasi ossessivamente, presente, perché se c’è una necessità vitale essa è quella di conservare la memoria dell’individuo, senza mai disgiungere storia individuale e storia collettiva, eventi, epoche. Sono quest’ultime, a susseguirsi impietose. È allora doveroso dar voce attraverso la scrittura «a quanti furono, e neppure una lapide protegge», perché, in fondo, «scrivere è dare udienza ai fantasmi». Ma la memoria, avverte Tuzzi, non è mai del tutto innocente: essa è «soprattutto pietà»; un faticoso esercizio di trascrizione e di occultamento di colpe ctonie, una riscrittura costante, un tentativo di afferrare le cose e i posti dopo la loro scomparsa, come ci ha insegnato Proust.
Allora – sentendo ancora l’eco della Recherche – i luoghi e il tempo abitano in noi, e negli anni rievocati da Massimo, sembra quasi di rivivere la Roma di Moravia e Soldati: i Sessanta, «l’irripetibile decennio nel quale il mondo – o almeno il nostro mondo, di occidentali privilegiati – sembrò davvero un pianeta fresco». Anni nati e cresciuti intorno a luoghi simbolo, come il caffè Rosati, in cui gli artisti trascorrevano ignari un tempo dilatato, sintomo prodromico di un mondo destinato alla fine. Anni in cui tutto era possibile, persino incontrare Nabokov a caccia di farfalle, e in cui «le donne presero a fumare per strada, come un tempo soltanto le donne perdute. Ma per altri costumi la pubblica opinione, qualunque cosa voglia significare, perdurava nell’ostracismo sociale», perché come disse Karl Kraus: «L’erotismo è una corsa a ostacoli. L’ostacolo più seducente e più popolare è la morale».
E c’è naturalmente la Milano dal cielo umido, dal profilo efficiente, con abitanti dei quali Massimo disegna un ritratto preciso e ironico. Inevitabile è la contrapposizione tra l’Italia selvaggia, bella e povera, e quella grigia della Milano ricca, che non smette di nutrirsi dei suoi stessi figli, «classe operaia triste sola e infreddolita». Figli che dal Sud arrivano già disillusi, come nel film simbolo dell’epoca, Rocco e i suoi fratelli, dietro le cui quinte, racconta Massimo, Giovanni Testori rubò per qualche momento Alain Delon a Visconti.
Ma è dell’Italia di oggi il ritratto più impietoso: paese del lavoro svilito e umiliato, della scuola castrata, delle competenze svuotate di conoscenze; dei genitori nati negli anni Sessanta che hanno cresciuto i figli a merendine e cellulari senza mai pretendere da loro uno sforzo cognitivo; paese che ha distrutto il ruolo di sentinella dalla stampa; di certa sinistra che ha contribuito allo spostamento sempre più a destra. Paese in cui nel discorso pubblico «si parla al ventre dei popoli […] e quel ventre partorisce noti mostri che si credevano estinti per sempre».
Con l’altro protagonista, Tommaso (specularmente dongiovanni: circondato da donne e amato dalle donne) la riflessione si proietta sulla musica, sulla contrapposizione tra suono e silenzio, per poi interrogarsi sul potere evocativo della melodia con l’esperienza sinestetica della nota azzurra, descritta da Delacroix nelle pagine del suo diario dopo aver sentito suonare Chopin: il latente emerge attraverso la catartica sensazione di appartenenza e di riconoscimento; come avviene nel jazz, in cui la cosiddetta blue note, riesce a far rivivere la nostalgia: esiste una musica che non crea ma attinge alla nostra memoria, esattamente come accadeva con i campanili di Proust.
Altrettanto evocativa è la digressione che si posa quasi distrattamente sul Don Giovanni di Mozart: opera avversa al silenzio, racconta Tommaso (a dimostrazione che la “leggerezza” mozartiana, criticata da Beethoven, necessita di ricchezza sonora), amatissima da Flaubert, contiene nel finale citazioni e autocitazioni, che si rincorrono, davanti agli occhi complici e compiaciuti dei due protagonisti, Don Giovanni e Leporello. La tavola imbandita, sulle note di Una cosa rara, si trasformerà nel funerale dello stesso Don Giovanni. Il destino e la morte incombono, anticipati, quasi predetti, esattamente come accade ai personaggi di Nessuno rivede Itaca, che a tratti è – ripeto – una moderna opera buffa, in cui la commistione di cose alte e leggere tanto amata da Mozart è anche il segno distintivo di questo libro (enorme è la disinvoltura con cui si passa dalla vita sessuale degli animali a Chopin; dal Chupa Chups come rievocazione del sesso orale al Faust).
L’arte può essere sì salvifica, ma ogni cosa è destinata a finire, a non tornare, a lasciarci soli e spaventati: la malattia che segna le nostre esistenze, e la morte che ci coglie sempre impreparati. Siamo in balìa del destino: «Ogni vita è quello che doveva essere», scrisse Pavese sul suo diario. Lo scrittore piemontese passò gran parte dell’esistenza a rievocare la dolcezza perduta dell’infanzia, senza riuscirci. Morì suicida come David Foster Wallace, di cui Hans Tuzzi ricorda queste parole: «siamo minuscoli e alla mercé di forze immense». Talmente potenti che non riusciamo a vederle neanche.
Sono tali forze invisibili a governare la vita, spiega Tuzzi in una delle molte pagine in stimola il nostro immaginario culturale e visivo: il musicista Tommaso è in tournée in Australia e aprendo il rubinetto nel bagno dell’albergo vede l’acqua defluire in senso antiorario. Allora ricorda una conversazione avuta a 12 anni, a tavola con i genitori, quando il padre gli parlò della forza di Coriolis. Nella sua mente di ragazzino s’era subito formata la figura di un supereroe, non sapendo, invece, che l’unica azione eroica di Gaspard Gustave de Coriolis fu quella di dimostrare una terribile verità: si può immaginare di sì, ma «non si torna mai esattamente là dove si è partiti», con buona pace di Nietzsche e dell’eterno ritorno.
(Hans Tuzzi, Nessuno rivede Itaca, Bollati Boringhieri, 2020, 250 pp., € 15.00 | Articolo di Gabriele Sabatini)