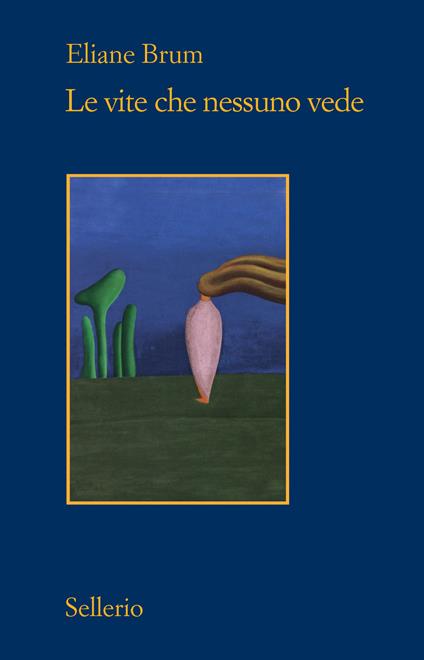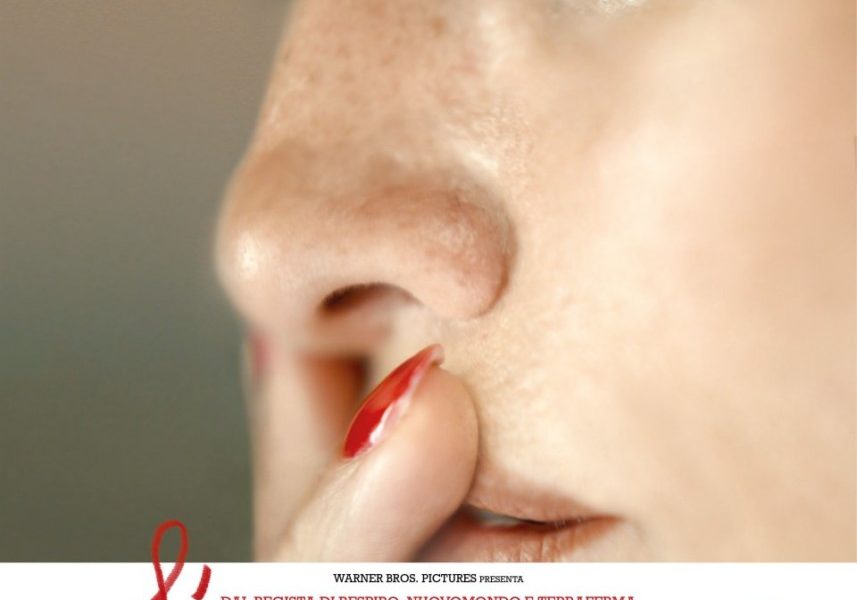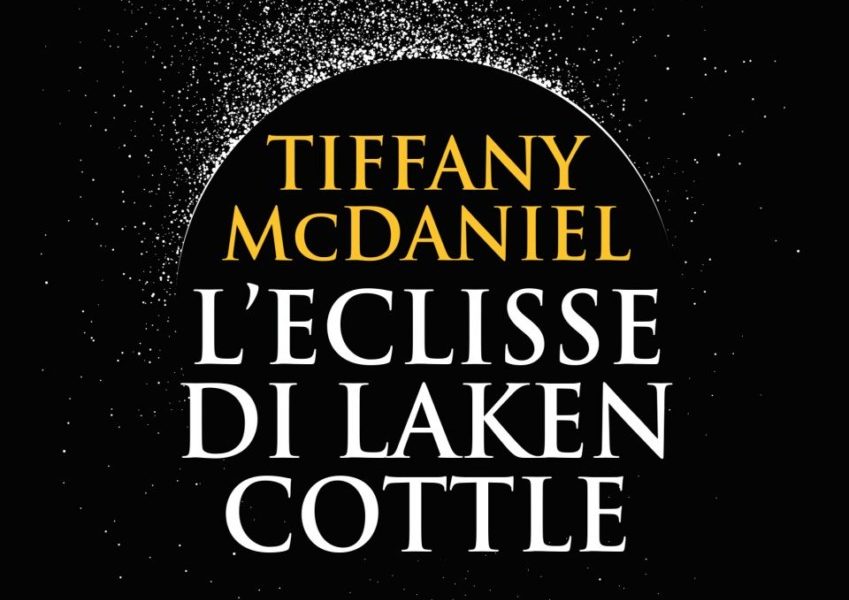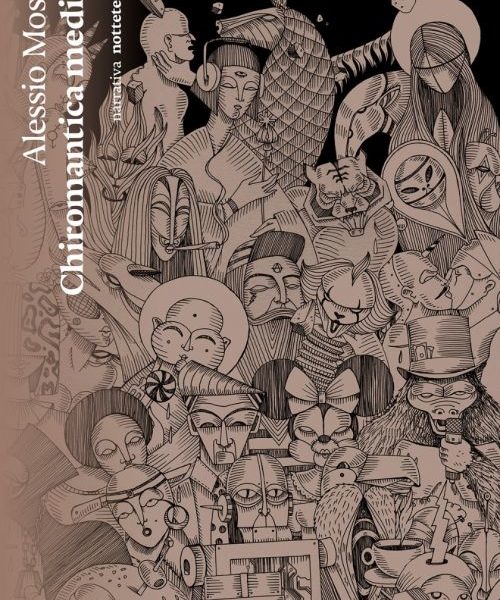«Siamo giunti al punto più buio di questa notte della Repubblica. Le Brigate Rosse hanno deciso di colpire come non mai il cuore dello Stato, lo faranno nella persona di uno dei suoi uomini più rappresentativi: Aldo Moro». Comincia con queste parole la prima di tre puntate di La notte della Repubblica, trasmissione che a fine anni Ottanta Sergio Zavoli aveva ideato e condotto per la Rai. Ed è proprio quel punto più buio, che Andrea Pomella col suo Il dio disarmato (Einaudi, 2022) indaga. A essere precisi, indaga con estrema dovizia un punto: uno solo di quei tragici cinquantacinque giorni nei quali Moro venne prima rapito, poi tenuto prigioniero e infine ucciso; si sofferma infatti tra le 9.02 e le 9.05 di quel giovedì mattina, del 16 marzo 1978. La mattina della strage di via Fani, la mattina del rapimento, la mattina in cui l’incubo che caratterizza l’ora più buia della notte della Repubblica comincia.
Non a caso, il romanzo si apre con uno studente di matematica che pensa allo «schema della tela del ragno [che] riproduce la spirale archimedea», spirale che ricopre al meglio la più ampia superficie, per non lasciare scoperto alcun punto. Peraltro, c’è da notare che La tela del ragno è stato il famoso titolo di un libro di Sergio Flamigni, uno tra i maggiori studiosi dell’affare Moro. Ma al di là della criptocitazione, Pomella con la spirale della tela del ragno ci avverte su come ha impostato il romanzo, la sua struttura, la tessitura con cui ripete e riprende di continuo quei tre minuti in cui tutto accadde. A dire il vero, seppur con le dovute differenze, il congegno messo in atto rimanda al romanzo Apeirogon di Colum McCann, dove non è la spirale bensì il poligono a facce infinite a caratterizzare l’idea narrativa. Eppure alcuni meccanismi sono simili, per esempio certi slittamenti di natura storica o saggistica (come l’inciso su Mario Fani, tanto per dire) o anche degli ingressi autoriali.
Pomella si concentra, dunque, su quei tre minuti e sulla notte precedente a quei tre minuti che deflagrarono sulla Storia d’Italia. Cosa sarà passato per la testa di Moro e dei suoi rapitori le otto ore prima? E agli uomini della scorta? Certo, una parte sapeva quello che sarebbe successo, o perlomeno lo aveva preventivato, un’altra era del tutto all’oscuro, tuttavia è intrigante provare a entrare nella quotidianità, o forse si dovrebbe dire nella normalità dell’attimo prima. «Il compito del narratore è simile a quello di un astronauta in procinto di giungere sulla soglia di una stella morente per osservare ciò che non può essere osservato», scrive Pomella per evidenziare più che giustificare la sua operazione. Ed è quell’osservazione che rende il suo romanzo differente dai pur tantissimi romanzi, saggi, serie, film che in questi quarantaquattro anni si sono succeduti sul caso Moro.
Qualcosa di simile ha fatto solo alcuni mesi fa Alessandro Bertante con il suo Mordi e fuggi: provare a analizzare il prima, in questo caso la nascita delle Brigate Rosse, se vogliamo al crepuscolo di quella giornata della Repubblica, per mantenere l’allegoria zavoliana. Si potrebbe dire che c’è nei narratori italiani nati durante gli Anni di piombo, che quindi non li hanno vissuti ma che anagraficamente c’erano, un desiderio di comprendere qualcosa che ha influito su una generazione – la cosiddetta generazione X – che si è trovata in hangover della famigerata Milano da bere senza averla bevuta, annegata da quell’inarrestabile riflusso degli anni Ottanta, e cresciuta nella strettoia tra la caduta del Muro e Tangentopoli. Il risultato si vede nella nostra politica odierna, ma questo è un altro discorso.
Torniamo al Dio disarmato. Non era semplice l’idea che si prefiggeva Pomella. Scartare i meccanismi del saggio storico, del saggio processuale e incastonare quella vicenda in un romanzo. Doveva entrare, e ci è perfettamente riuscito, nel profondo dell’animo di Moro, di sua moglie Eleonora, dei figli (di Maria Fida più degli altri), perfino del nipote, il piccolo Luca che quella mattina vuole andare alle Capannelle a vedere i pompieri, perché gliel’hanno promesso. Non era facile neanche questo andirivieni temporale, spezzare quella percezione umana per cui, come Pomella stesso scrive a proposito di Oreste Leonardi, «il tempo che lo separa dalla fine, il tempo messo in fila come un’unità inscindibile, un tutto che in questo istante non può ancora immaginare»; e invece riesce bene quella scissione temporale, quello scoprire e ri-scoprire ciò che sappiamo già.
È un romanzo onesto, in cui l’autore non si nasconde, ogni tanto compare e ammette di non poter sapere tutto, seppure finga il contrario. Tuttavia analizza, cerca di comprendere senza schierarsi in modo manicheo, anche se la vicenda spinge fin troppo semplicisticamente chiunque a tirare una linea al centro del campo, per schierare il bene contro il male. Pomella non cede a questa tentazione, tant’è vero che prova altresì a muoversi nei meandri del comando d’assalto delle Br che agisce in quella mattina. È la Storia ad averli sconfitti, Pomella lo sa e lo lascia intendere, eppure prova a capire e interrogarsi. Una delle risposte è nella loro età, «è una guerra tra ragazzi», scrive l’autore, d’altronde solo Moro con i suoi sessantun anni, Leonardi con i cinquantuno e Ricci con i quarantatré sono gli adulti; gli altri, dalla scorta ai brigatisti sono ventenni, salvo Moretti che ha appena superato i trenta.
«È questo in fondo che fa sempre la gioventù», ci ricorda con sagacia Pomella, «subire l’autorità, tentare la rivoluzione, processare i padri e infine estinguersi», per poi ricominciare la spirale, perché il potere da sempre «esercita la più raffinata forma di violenza morale».
Aldo Moro fu una delle figure principali di quella Repubblica uscita dal disastro del fascismo e della Seconda guerra mondiale. Moro ai tempi della Costituente si scontrò con Calamandrei affinché nella nostra Costituzione la persona prevalesse sul cittadino. E l’ebbe vinta. Per Moro la persona veniva prima di ogni cosa, questo era il suo mantra. Pomella ci restituisce appieno la persona, i suoi affetti, i suoi valori, anche le sue paure e dubbi, che andavano al di là della politica, cosa che sbalordì e mise in crisi gli stessi brigatisti durante la prigionia. Si accorsero infatti che quel Moro che per loro era il simbolo politico del male, del Sistema Imperialistico delle Multinazionali (il famigerato SIM dei loro comunicati), nella quotidianità era una persona, un uomo che metteva gli affetti davanti a tutto, che credeva nell’individuo oltre la nebulosa della Ragion di Stato.
E proprio lo Stato pose la sua Ragion davanti alla persona di Moro.
Chissà, verrebbe da domandarsi, se fosse stato rapito un altro esponente cosa avrebbe fatto, come avrebbe agito Aldo Moro alla guida di quello Stato che con lui si mostrò irreprensibile sulla linea della fermezza?
Il dio disarmato è un romanzo che raccoglie attorno a sé tutto questo e molto altro. È metafora del potere e della viltà che lo abita, è allegoria di una notte su cui ancor oggi non si è fatta chiarezza, è osservazione del punto d’origine della nostra attualità.
(Andrea Pomella, Il dio disarmato, Einaudi, 2022, 240 pp., euro 19,50, articolo di Fernando Coratelli)