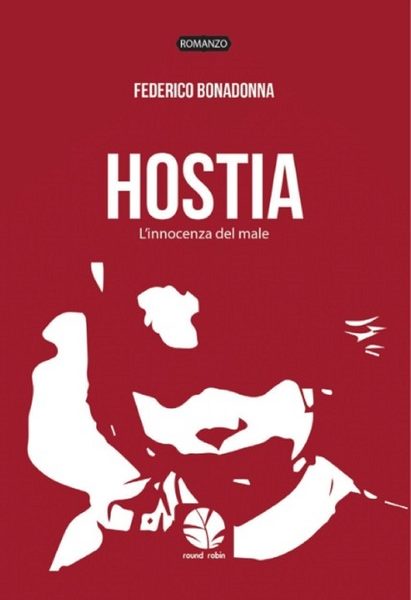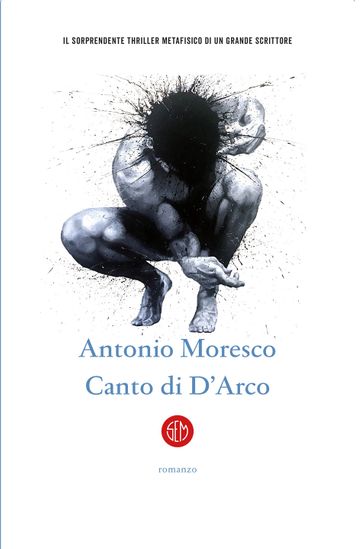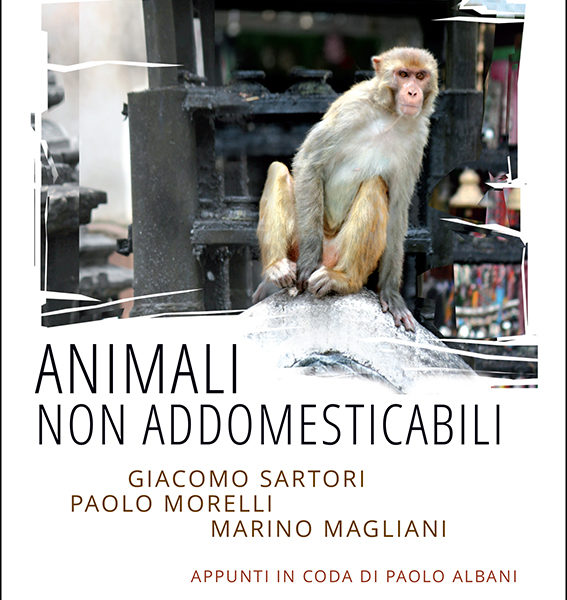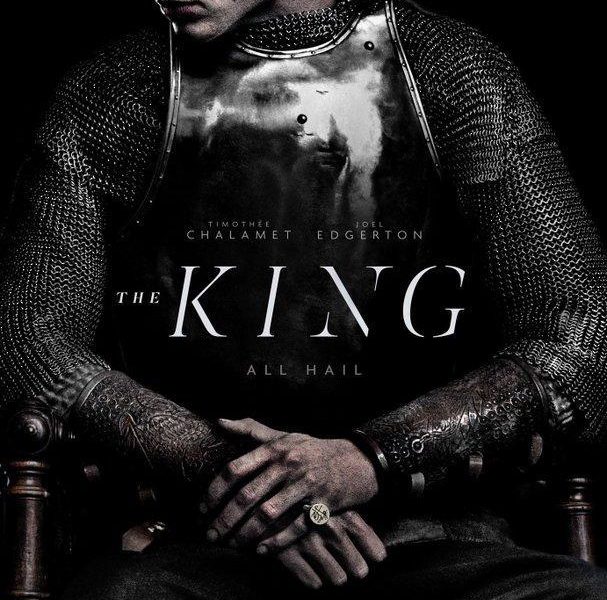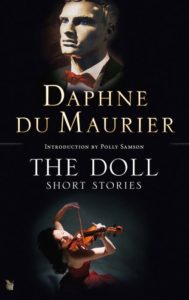Un romanzo, nove racconti e quattro novelle raccolti in quattro libri usciti tra il 1951 e il 1963: è tutto ciò che Salinger scelse di affidare a un editore, opponendosi tanto ai tentativi di riesumare i racconti apparsi su riviste prima dell’esordio, quanto alle proposte degli interessati alla stampa della sua ultima novella, che occupa quasi interamente il numero del 19 giugno 1965 del New Yorker.
Davide Coltri prosegue il suo percorso nella produzione produzione breve di J.D. Salinger. Leggi il primo articolo dedicato a L’Uomo Ghignante.
Un’avvertenza: è probabile che ci siano spoiler, se questa parola ha un significato quando si parla di Salinger.
Seconda Puntata
Zooey
Zooey, apparsa sul New Yorker il 4 maggio del 1957, è una delle otto storie che Salinger dedica alla famiglia Glass: sette fratelli (Seymour, Buddy, Boo Boo, i gemelli Walt e Waker, Zooey e Franny) dall’intelligenza precoce ed eccezionale – sono tutti ex protagonisti di un programma radiofonico per bambini prodigio – figli di due attori di vaudeville (Bessie e Les).
Dopo un preambolo in cui Buddy afferma di essere il narratore, la vicenda inizia tra le mura dell’appartamento dei Glass a Manhattan, dove Bessie e Zooey sono alle prese con l’esaurimento che ha colpito Franny due giorni prima e che Salinger racconta nella storia eponima del 1955. Franny, studentessa e talentuosa attrice in conflitto interiore col mondo accademico e dello spettacolo, sta cercando di mettere in pratica gli insegnamenti di un mistico russo del diciannovesimo secolo, secondo il quale sarebbe possibile pregare Cristo ininterrottamente.
Franny è proprio in crisi, non mangia quasi nulla e la madre, non sapendo più a chi rivolgersi, irrompe nel bagno dove Zooey, mezzo immerso nella vasca, sta leggendo una lettera che il fratello Buddy gli ha spedito quattro anni prima. Si capisce che Zooey è esasperato dalle soluzioni proposte da Bessie; per di più ha già provato a parlare con la sorella, senza ottenere nulla, e appare restio a ritentare. Si intuisce tuttavia che la lettura della missiva di Buddy è un tentativo di trovare il modo di aiutare Franny.
Partendo da questo nucleo, e mantenendo il racconto dei fatti entro coordinate spaziali e temporali ristrettissime (quattro stanze, qualche ora), lo scrittore newyorchese orchestra un andamento a spirale che ingloba sia riflessioni estetiche, morali e spirituali, che interventi dei membri assenti o morti della famiglia Glass – Seymour e Buddy in primis –, e che spazia nel tempo a recuperare eventi dell’infanzia. Al centro di tutto questo, ovviamente, c’è Zooey: è lui che a poco a poco si trasformerà in una persona in grado di prendersi cura della sorella.
Il lettore è immerso in una giornata speciale per la famiglia Glass, durante la quale Zooey, in un lento avvicinamento, sviscera alcuni dei traumi e nodi irrisolti che si porta dentro. C’è il suicidio di Seymour, l’assenza di Buddy, l’inadeguatezza dei genitori di fronte allo stato di Franny, l’istruzione zen impartita dai fratelli maggiori che lo ha trasformato in un fanatico. Zooey è carico di rabbia, che esprime prima sarcasticamente contro la madre durante le due sequenze in bagno, poi contro Franny inchiodata al sofà. Franny, da parte sua, non sopporta più né la vita accademica, con tutte le piccolezze e trivialità di professori che sono interessati a tutt’altro che alla ricerca della saggezza, né quella da attrice, perché indulge ai desideri dell’ego. Da qui il suo ricorso alla preghiera a Gesù.

Il primo incontro/scontro con la sorella è un dialogo in cui Zooey di fatto parla soprattutto a sé stesso, o alla parte di sé stesso che ritrova in Franny, e lo fa con un astio che non lascia scampo e che non ha pietà nemmeno delle lacrime. Sarà una lunga tirata su Gesù Cristo e l’epifania di una scena alla finestra a permettere a Zooey di uscire dall’impasse e diventare il guaritore di Franny e di sé stesso. La scena alla finestra risveglia in Zooey la consapevolezza della bellezza immediata di un mondo purificato dalle intrusioni dell’ego; Gesù Cristo è uno di coloro che sanno quanto la differenza tra le cose è pura mistificazione, perché afferma di essere uomo e Dio allo stesso tempo. Zooey inizia quindi un cammino di lenta ma sicura ascesa: entrerà nella stanza di Buddy e Seymour, vi passerà del tempo a riflettere e a leggere, riesumerà il quadretto familiare descritto in un diario di Seymour. Infine, prenderà il telefono e chiamerà Franny nell’altra stanza, spacciandosi per Buddy.
L’elemento della comunicazione filtrata è cruciale e attraversa tutta la novella (e si ritrova spessissimo nelle storie dei Glass): all’inizio Zooey legge una lettera di Buddy; nel bagno, Bes e Zooey discutono prima attraverso la tendina tirata della vasca e poi guardando i propri doppi nello specchio; durante la telefonata a Franny, Zooey verrà smascherato ma non per questo opterà per proseguire la conversazione di persona e continuerà a parlare nella cornetta. Usando il telefono, accettando le modalità comunicative della propria famiglia, Zooey si riconcilia coi fratelli maggiori: è Seymour ad aver installato la linea, ed è Buddy ad aver lottato perché non venisse rimossa.
Di più, spacciandosi per Buddy, Zooey tenta di incarnare l’assenza di differenze esemplificata da Gesù Cristo. Su questa scorta, una volta smessa la falsa identità, potrà finalmente parlare davvero a Franny (e non più solo a sé stesso) e rivelarle che il brodo di pollo che Bessie le propina per curarla è sacro, e che deve sapere riconoscere il sacro in ogni cosa, anche in quelle che sembrano più inadeguate. In caso contrario, la preghiera a Gesù non è altro che fuga dal mondo, desiderio (desiderio!) dell’ego di accumulare purezza.
Nelle ultimissime battute, Zooey e Franny scoprono di aver ricevuto da Seymour la stessa esortazione, una sorta di imperativo categorico morale ed estetico, secondo il quale qualsiasi cosa dev’essere fatta per la Signora Grassa. All’insaputa l’uno dell’altra, l’hanno immaginata simile: «La facevo sedere su una orribile sedia di vimini. E aveva il cancro anche lei, però, e faceva andare la radio a tutto volume tutto il giorno! Anche la mia!».
Zooey è ora pronto a consegnare alla sorella il tesoro che ha conquistato: la Signora Grassa è Gesù Cristo, e Franny, facendo quello che desidera e che le riesce meglio (recitare, Buddy e Zooey sono andati a vederla di nascosto e sanno quanto sia brava), non fa altro che pregare, secondo l’inclinazione che le è data. «In qualche stadio della tua evoluzione, in una delle tue maledette incarnazioni, se preferisci, tu non hai sentito soltanto un desiderio intenso di fare l’attore o l’attrice, ma di farlo bene. E adesso, ormai, ci sei dentro. Non puoi sottrarti così alle conseguenze dei tuoi desideri». Non importa se Franny reciterà per il pubblico di un teatro di provincia, a Broadway, o alla radio: «Non c’è nessuno là dentro che non sia la Signora Grassa di Seymour. Professor Tupper compreso, sorellina. E tutti i suoi balordi cugini. Non c’è nessuno, in nessun luogo, che non sia la Signora Grassa di Seymour».
Per Salinger, Zooey è l’occasione di inserire in una cornice narrativa una summa delle proprie riflessioni in materia di religione e di estetica, e per raggiungere, nelle ultime pagine, la proposta di una sintesi in cui vita spirituale e vita artistica si presentino come la stessa cosa. Eppure, come scrive candidamente Buddy nella lettera che Zooey legge all’inizio della novella, questa storia resta anzitutto una storia d’amore, «d’un amore multiplo o composito», in cui un fratello affronta gli ostacoli più insidiosi (l’orgoglio, il risentimento, i traumi familiari) per riconciliarsi con la realtà e diventare una persona in grado di prendersi cura della sorella sofferente, di sé stesso e, potenzialmente, del mondo intero.
(“Zooey”, in Franny e Zooey, J.D. Salinger, Einaudi, 1963, pp. 168, euro 10, articolo di Davide Coltri)