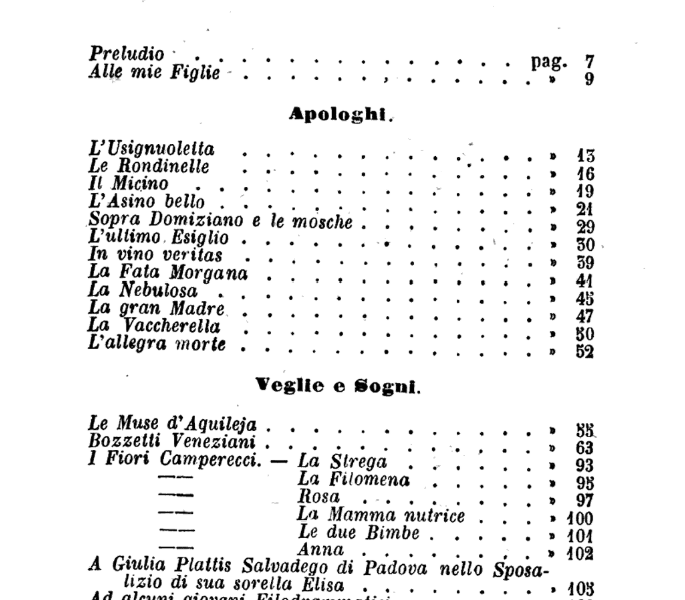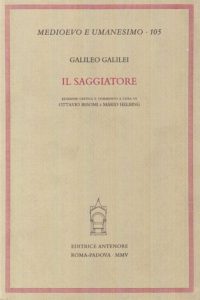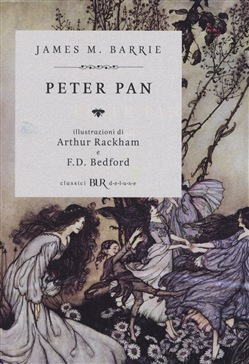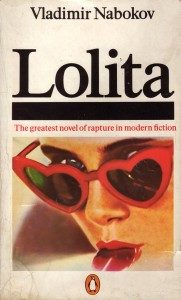Fu solo quando la hostess disse «in caso di una depressurizzazione della cabina, le maschere dell’ossigeno usciranno da appositi scomparti collocati nel soffitto dell’aeromobile; indossate la maschera e respirate normalmente», che Clara alzò lo sguardo su di lei. La donna giocherellava con l’elastico della mascherina, tirandolo al viso e poi lasciandolo andare, mimando un gesto che Clara aveva imparato a conoscere da tre mesi a questa parte.
Era cominciato tutto a novembre.
In preda a un attacco respiratorio, suo padre era stato ricoverato d’urgenza nell’ospedale di Nola, in Campania. Dopo aver vissuto per quasi tutta la sua vita a Roma, da poco si era ritirato in pensione nel paese dove era nato, nei comuni vesuviani, una zona che Clara conosceva appena.
Già da qualche anno lei viveva stabilmente a Berlino.
Era emigrata per ragioni simili a quelle di tanti altri: scontentezza, mancanza di lavoro, desiderio di migliorare le condizioni di vita e uscire da una certa apatia.
Nel 1998, aveva visto Berlino per la prima volta.
Era il viaggio assieme a Paola, la compagna di banco, e Potsdamer Platz non esisteva ancora; era invece un grosso cantiere che si estendeva fin dove arrivava l’occhio, con molte gru e un palco dove salire, per guardare meglio.
Cosa poi? La città che si trasformava.
Con una Olympus analogica scattavano foto al cantiere – il più grande che entrambe avessero mai visto – e la vita sembrava loro simile: un buco aperto con un fiore dentro pronto a sbocciare. Era stato anzi forse per quella promessa di futuro che tacitamente si erano scambiate sul finire delle loro adolescenze, che Clara si era innamorata subito di Berlino. O almeno così le piaceva raccontarsi, ora che Potsdamer Platz sembrava invece una moderna Gotham City e l’amicizia con Paola era finita anni addietro.
I primi mesi a Berlino non erano stati facili. Il tedesco era come un involucro molle e vuoto che non riusciva a riempire di senso, Clara balbettava come una poppante, afflitta dal fatto che i suoi pensieri – solitamente elaborati e complessi – ora si sforzassero di esprimere cose semplici: mi chiamo Clara, ho trentadue anni, vengo da Roma…
Spesso, camminando per le vie del Mitte, si sentiva un sentimento di nostalgia appiccicato addosso. Provava un’emozione dura in gola, al pensare che magari ogni cosa che stava facendo era il frutto di una scelta sbagliata. Ma poi un tram passava sul ponte, allontanandosi verso la torre di Alexanderplatz, e la città le si stringeva di nuovo attorno, in una morsa bellissima e profonda.
In quella quiete, Clara sentiva nuovamente ogni cosa dentro di sé, anche se non riusciva a possedere nulla, e se prima gli era sembrato di vivere nell’attesa di un momento destinato a venire sempre dopo, adesso le pareva invece di esistere solo nel qui e nell’ora, come non ci fosse altro che il presente da abitare.
Sulla Brunnenstraße c’era un vecchio edificio occupato, con le finestre vuote come occhi spalancati e cavi; lungo la parete esterna, l’affresco di un essere grottesco e mostruoso, volteggiante in aria, con la bocca aperta in un fumetto che diceva solo: «Wir bleiben alle», noi rimaniamo. Rimaniamo tutti.
Io vado.
Il giorno in cui Clara era partita da Berlino per raggiungere l’ospedale di Nola, aveva legato la bicicletta a un palo nei pressi di una stazione di polizia e, come si trattasse di un amico, le aveva sussurrato quelle parole.
Contava di ritornare a prendersela presto, lasciare Berlino le pesava moltissimo e da qualche parte, pur senza confessarselo apertamente, riteneva anche che quell’emergenza fosse solo un’ennesima provocazione del padre, un modo per attirare la sua attenzione nel modo distorto che gli apparteneva.
Quando arrivò in ospedale e lo vide in quel letto angusto, gli occhi bianchi come quelli di un ragno, ebbe subito voglia di piangere e di non andarsene più via.
La vide entrare e lui disse: «Sei qui».
«Sì, sono arrivata, sono qui», avrebbe voluto rispondergli lei, «e ho fatto una gran corsa, sai? Sono precipitata giù dal nord freddo e ordinato, dove rimetto l’orologio a ogni autobus che passa, e mi sono persa all’uscita di Pomigliano d’Arco. Per riprendere la strada ci ho impiegato quasi quanto arrivare a Fiumicino. Ho chiesto informazioni dieci volte a dieci persone diverse e ognuna mi ha detto “eh, signori’, e che ci vuole! La vede quella strada lì? Voi basta che la prendete tutta in fondo, arrivate al cavalcavia…”, ma il cavalcavia, sai, sembra un essere tentacolare e sempre uguale a se stesso, da qualunque parte lo si guardi… continuavo a sbagliare. E a perdermi».
Ma Clara non gli disse nulla di tutto questo.
Non gli raccontò neppure della donna che arrostiva carciofi in un angolo della strada, dove non c’era niente altro che lei, qualche sacco della spazzatura e un cartello con su scritto Vendo pedane. Neppure gli disse che l’odore dei carciofi aveva risvegliato in lei una memoria perduta, e neppure che a volte a Berlino, per sentirsi un po’ a casa, scendeva da Prenzlauerberg a Neukölln, il quartiere turco, dove le vetrine erano piene di bomboniere kitsch e poi, poco più là, cibo per canarini, trecce di capelli finti, paccottiglia alla rinfusa e un cane che aspettava davanti a una vecchia macchina da cucito. All’angolo magari preparavano il tè nero e la shisha mentre qualcuno ripeteva zwei euro, zwei euro, la faccia paonazza, imbevuta di Raki, e l’autobus 29 a passare intanto sulla Sonnenallee. Distrattamente, come una città nella città, sfilava Neukölln, restituendo a Clara una finta eco del Mediterraneo, anche se fuori nevicava.
«Non voglio stare qui», le disse suo padre, «questo posto fa schifo. C’è la buccia del mandarino di qualcun altro che marcisce nell’armadietto».
L’ospedale era fatiscente.
Nella stanza in cui lo avevano messo c’erano altre due persone, tra cui un vecchio che si rasava la barba in una bacinella usando la schiuma Proraso.
«Chiullu è arrivato accussì, cianotico», disse la dottoressa a Clara, «si agita e se ne vuole andare. Con certi uomini signori’, lo so, nun ce sta niente ’a fa’. Se vére che c’ha nu carattere…».
Suo padre era un uomo ribelle. Da ragazzo scappava di casa e nascondeva le sigarette nelle narici delle statue a Villa Borghese. Aveva sempre fumato, i sigari per lo più, e lo avrebbe fatto anche adesso – Clara ne era certa – se non fosse stato costretto quale era su un letto di ospedale, con i tubicini dell’ossigeno conficcati nel naso.
Non era un uomo facile, faceva sempre tutto di testa sua.
Autoritario e forte, era anche incapace di amare senza esprimere al contempo una forma di rabbia e di risentimento. Come se si sentisse sempre non capito, soprattutto dalle donne e, una dopo l’altra, aveva anzi trovato il modo di respingere e allontanare da sé tutte quelle della sua vita: sua madre, sua moglie, sua sorella, la sua amante, e infine sua figlia.
Alle ragioni per emigrare a Berlino, infatti, Clara aggiungeva anche quella di separarsi da lui; avevano un rapporto intenso ma conflittuale e litigavano ferocemente da quando Clara aveva dieci anni. Più di una volta, nel corso della sua vita, lei si era sentita vicina a un punto zero, in cui l’unica soluzione possibile le pareva il lasciarlo, come si fa con un uomo che si ama ma che ci fa soffrire: senza voltarsi più indietro. Poi aveva scoperto una terza via: mettere tra lui e lei una distanza, che agisse come un filtro.
E Berlino parve funzionare.
Nella lontananza, quando si sentivano su Skype, c’era infatti sempre meno spazio per gli isterismi e le recriminazioni; passava altro, come ad esempio l’immagine che Clara gli restituiva di un luogo che andava scoprendo.
Una volta gli raccontò del Lichtblick Kino, un cinema grande quanto il soggiorno della loro vecchia casa, dove ogni sabato sera, a mezzanotte, trasmettevano immancabilmente Casablanca.
«Humphrey Bogart ha sempre una faccia coriacea e triste», aveva commentato lui, «a vederlo viene voglia di fumare».
Quando in ospedale l’orario di visite terminò, a nessuno importò che Clara avesse fatto tutte quelle ore di viaggio, cambiato quasi ogni mezzo disponibile, per arrivare fin là. La sua bicicletta era legata ancora a un palo, e da quel palo vedeva scendere un tram dalla piazza di Zionskirche, giù in direzione dell’Invalidenstrasse, dove i ragazzi sferragliano sugli skateboard, lanciandosi a tutta velocità sulle rampe, irriflessivi e forti, senza coscienza alcuna della vulnerabilità umana.
Nell’andarsene, a Clara sembrò che suo padre avesse lo sguardo annebbiato e il cuore le si strinse in una morsa.
«Torno domani, sono qui. Fai il bravo».
Quella sera andò a passare la notte nella casa di Somma Vesuviana.
C’era stata poche volte in vita sua e di tutte aveva pessimi ricordi. Nella memoria, soprattutto, spiccava l’immagine della cantina da basso, con una madonna sotto una cupola di vetro posta a guardiano delle scale, asfissiata e con lo sguardo dolente. Nella camera, che un giorno era stata di sua nonna, era però sparito il Cristo in croce, di cui Clara ricordava le ombre nella notte, le braccia lunghe e magre spalancate nell’oscurità. Adesso suo padre aveva riempito la stanza di libri e di cianfrusaglie, coperte di polvere fino all’inverosimile.
Era diventata la casa di uomo solo.
Nel camino spento, tante copie della Settimana Enigmistica, tutte completate e pronte a bruciare assieme a un cumulo di parole.
Clara non riusciva a dormire.
Alle quattro di notte squillò il telefono e la richiamarono in ospedale.
Mentre un bambino da qualche parte cacciava fuori il suo primo grido alla vita, lei indossò una mascherina e un paio di guanti e vide per la prima volta il padre attaccato a delle macchine.
Le condizioni erano tali da rendere necessario un trasferimento.
Partirono all’indomani, in ambulanza.
Lui non si rese conto di nulla, mentre Clara capì di scendere ancora più giù, ancora più a Sud, verso un ospedale raggiungibile ora solo percorrendo la statale 372, la Telesina, attraverso valli scoscese e povere, guardando la luna apparire e scomparire, dentro e fuori le gallerie, per arrivare poi a un cartello che diceva: Welcome to Ariano Irpino.
Quando Clara aveva pochi anni di vita, in quelle zone la terra tremava.
Là, dove solo Verne si era avventurato con la fantasia, qualcosa si rompeva.
E novanta secondi, durava. Neanche il tempo in chiesa di dire amen e il telegiornale buonasera, che al novantunesimo era tutto finito.
Con le case accartocciate su loro stesse e le grida che si alzavano al cielo, a scacciare la pace, acute e intense, come si levassero da un manicomio.
Poi, nel tempo, ricostruirono quasi tutto, e Ariano Irpino era ora il paese che Clara vedeva, con il corso principale dominato da un albergo illuminato di notte, tale e quale agli edifici di Las Vegas, che emetteva luce, tanta luce, una struttura grottesca ed immorale. Dietro a una curva – sulla sommità di una vetta impervia – l’ospedale, nuovo di zecca.
Anche lì, nella sala d’attesa della terapia intensiva, c’era una madonna.
Era sopra un piedistallo, con l’aureola simile a una coda di pavone.
Era successo tutto molto in fretta e a Clara ci vollero quasi cinque giorni per iniziare ad accettare che si trovava davvero lì, in Irpinia, e che suo padre, lì, stesse combattendo tra la vita e la morte.
Nel volgere di poco tempo tutto era cambiato.
Perfino la Germania era diventata sul momento un luogo evocato solo nelle parole di Giuseppe, un camionista che come Clara aspettava il suo turno per entrare in terapia intensiva a visitare la madre. Raccontava che a Berlino c’era stato più volte, e mentre lo diceva si pizzicava i polpastrelli delle mani, che sembravano fatti di pane.
Passarono nove giorni. Silenziosi, esasperanti, lenti.
I medici divennero le persone più importanti del mondo: ogni parola, oscillazione nel tono della voce o del discorso, sembrava colare dalle loro bocche divine solo perché Clara potesse raccoglierle con un piattino. Ma, un giorno dopo l’altro, il responso era sempre lo stesso.
«La situazione è grave, non possiamo mentirle. Il coma lo tiene sedato, per ora è stabile e dobbiamo sperare che gli organi riprendano a lavorare nel modo giusto. Ma bisogna aspettare. Non c’è niente che lei possa fare».
Vivere e dormire a Ariano Irpino cominciava a diventare dispendioso e Clara doveva anche tornare al suo lavoro.
Dopo quasi due settimane, la convinsero a ripartire per Berlino.
In realtà, lei scalpitava per ritornare alla sua vita e allontanarsi, anche solo per un momento, da tutto il resto. Ma quando fu in aeroporto, e passò tra i metal detector, le sembrò di avere dietro un bagaglio enorme, uno zaino fatto di cose invisibili agli altri, in cui si annidavano alla rinfusa emozioni, paure e speranze. Un bagaglio con un peso specifico che Easyjet le consentiva di far passare, senza accorgersi che, messo sul piano della bilancia, sarebbe pesato molto di più dei chili che la compagnia le consentiva di portare in cabina.
Per i primi dieci giorni a Berlino, a mezzogiorno in punto, Clara chiamò il cellulare di una signora della Croce Rossa: Maria.
Lei andava a trovare suo padre quando Clara era assente, lei gli parlava riferendogli che la figlia lo pensava, gli voleva bene e che sarebbe tornata presto.
Maria dava a Clara anche il bollettino medico, che non evolveva da quando lei se ne era andata.
Clara aveva visto Maria appena tre volte nella vita. Pure, quella donna tarchiata e forte, con le guance sanguigne, era ora come una zia per lei. Maria forse avrebbe fatto una scelta diversa e anzi non si sarebbe neppure trovata nella situazione in cui si trovava Clara adesso: a piagnucolare, dall’altro capo dell’Europa, affidandosi ai responsi di una sconosciuta come a quelli di un oracolo. Maria le diceva di pregare, anche se bisognava comunque essere preparati al peggio e, mente la ascoltava, Clara non poteva fare a meno di pensare a suo padre, bestemmiatore della Chiesa, dei preti, dei santi ma soprattutto di Dio. Ma Clara pregava, per tornare a sentire quelle bestemmie e la voce del padre.
Un giorno andò a perdersi volutamente nel Memoriale per gli ebrei assassinati di Europa.
In quel labirinto composto di stele poste l’una dietro l’altra, mentre i turisti schiamazzavano, i bambini giocavano a nascondino e le mamme gridavano cercandoli, Clara trovò cunicoli abitati solo dal silenzio e da ombre la cui oscurità conferiva un tono melodrammatico alle pietre. Mentre ci appoggiava le mani sopra, toccando, constatando come anche ai colori corrispondesse una sensibilità tattile, rinvenne un sentimento frustrato, un’oppressione, una perdita di significato; un cerchio alla testa del quale non veniva a capo. La bocca le si fece secca. E in quella ristrettezza cupa ebbe paura. Più in là, già in direzione della Porta di Brandeburgo, c’era un giapponese che scattava una foto; una bambina minuta che canticchiando saltava una corda. Corse via per uscire e respirò.
Tornò ad Ariano Irpino tre volte, nei due mesi successivi, ma all’ultima la venne a prendere un ufficiale dei carabinieri alla fermata del pullman per Grottaminarda.
In Italia aveva cominciato a nevicare. Ovunque. Anche al Sud. Le strade erano tutte bloccate e per arrivare Clara ci impiegò diciotto ore.
Era sicura che i bambini guardassero alla neve con gioia mentre lei malediceva quei mucchi già sporchi di fango.
«Faccia attenzione a non scivolare», le disse l’ufficiale, «sta arrivando da Roma?»
«No, da Berlino», rispose lei, «sto arrivando direttamente da Berlino. Vivo lì».
«Ah, è una bella città. Ma fa molto freddo, no?»
«Sì. Eppure quest’anno non abbiamo ancora visto la neve. La sto vedendo tutta qua».
«Non ne vedevamo così tanta anche noi da quasi vent’anni».
«Si vede che aspettava me».
L’ufficiale le offrì un Mon Chéri. Lei lo succhiò e poi sputò la ciliegia per terra.
Per raggiungere l’ospedale la scortarono su una macchina dei vigili urbani.
Le strade di Ariano erano una lastra di ghiaccio. Nelle orecchie, Clara aveva ancora il trillo del telefono e la voce che dall’altro capo le diceva che la situazione si era aggravata.
In modo del tutto straordinario, varcò la porta dell’ospedale, era già notte, oltrepassò la madonnina, si infilò i guanti, la maschera, il camice. Quindi entrò nella sala. Senza curarsi degli infermieri, cominciò a parlare.
E non sapeva più neanche se parlava al padre, alle macchine a cui lui era attaccato, o forse a se stessa. Toccò quel viso a cui avevano tagliato da un pezzo tutta la barba. Sembrava più giovane. Fece uno sforzo e all’orecchio gli sussurrò dei versi di una poesia che aveva imparato: «Si dummeneca è bon tiempo, ce ne iammo a Marechiare: llà mangiammo a llido ’e mare, e parlammo io ’e te, tu ’e me. T’ aggia dì nu sacco ’e cose ca mme passeno p’ ’a mente…»
«Sai», gli disse poi, «sai che c’è stato un momento in cui gli uomini andavano a morire nelle acque del Wannsee? Dove ora io vado con la S-Bahn o in bicicletta, affittando una piccola barca e osservando i bagnanti a riva che paiono personaggi di Maupassant, uomini e donne affogavano. E lo facevano di proposito, per sfuggire al buio o forse alla guerra. Anche il Wannsee conserva giù nel fondo una scarpa. Magari una collanina. In angolo remoto del bosco, che lambisce il lago, tra gli alberi fitti e lunghi dove tu andresti in cerca di funghi, lì invece, sai, ci sono molti sassi. Sassi e pietre, che sembrano crescere pure loro come piante. Sono i sassi dei senza nome, così li chiamano, e il cimitero dei suicidi, come è detto, è in questo spicchio di terra umida e dolce. Una parola appena: Mutti; forse una data; tra l’edera che viene a ricoprire ogni cosa. Un coniglio di legno siede tra le eriche, in lontananza un picchio martella un tronco in cerca di vermi. Lo sapevi?»
Così gli chiese.
Poi ci fu un momento grande e vuoto, senza nulla dentro.
Anche nel Mitte, davanti alla casa in cui Clara abitava a Berlino, c’era un piccolo cimitero.
Lì lei ritornò.
Con le mani scavò una buca nella terra, vicino ad un albero che faceva ombra sulla lapide di una certa Frau Schmederlin. Nella buca piantò una primula e la terra le rimase conficcata sotto le unghie.
Poi si sedette su una panchina, lasciando penzolare le gambe, muovendo lentamente il piede, come una fragile ala; guardando a quella primula gialla.
Una signora, sul viale, portava l’acqua; lei e Clara si guardarono da lontano.
Sullo sfondo stava silente la gru gialla di uno dei tanti cantieri berlinesi.
Clara disse: «Sembra che io abbia preso il vizio di non stare mai ferma e faccio come le gru. Come se una parte di me volesse cedere da qualche parte, e una luce cercasse di accendersi, e mi fosse necessario rompere qualcosa, spaccarla dall’alto in basso, per poi ricostruirla. Mi pare di non arrivare mai al dunque e che il tempo si sia fatto di velluto.
Ma sono ancora qui».
Nora Cavaccini è nata a Roma nel 1979 e dal 2010 vive e lavora a Berlino.
Laureatasi in Letteratura latina con una tesi sul Satyricon di Petronio, ha concluso nel 2011 un dottorato di ricerca in Italianistica sotto la direzione di Romano Luperini, con una tesi sulle novelle di Giovanni Verga. Ha scritto il romanzo Le regole di Anacleto (Manni, 2008). Dal testo L’orologio è rotto (Caratteri Mobili, 2014), è tratto lo spettacolo teatrale Grillen im Kopf (per la regia di Elettra de Salvo) che ha debuttato alla Ballhaus Ost di Berlino nel dicembre 2014, con il patrocinio dell’Istituto italiano di Cultura.
Editing del racconto a cura di Gabriele Sabatini.