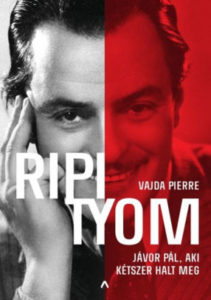Gli scritti di Paolo Zardi sono seminati ovunque e in varie forme: racconti su antologie, su riviste, romanzi, romanzi in ebook, articoli su blog, recensioni, fino ad arrivare ai testi per graphic novel e a reportage di viaggio; sembra che la sua scrittura riesca a prestarsi facilmente a molteplici incarnazioni. Andando a fare un’operazione archeologica sul suo blog, Grafemi, ho scovato molti spunti interessanti di cui abbiamo parlato insieme, approfondendo aspetti della sua scrittura, del suo rapporto con la letteratura e con la comunicazione digitale.
«Vista dall’alto la spiaggia assomigliava alla pianura padana, o a una vecchia carta geografica dove i diversi colori riempivano poligoni tracciati con il righello». Questo incipit ricorda l’occhio di un drone in alta quota che rileva le geometrie della spiaggia. Poco dopo viene tratteggiata una tipica scena da domenica balneare: il racconto va man mano focalizzandosi su dettagli, passando tra alcune «donne carbonizzate» che prendono il sole, una madre che allatta il neonato sotto l’ombrellone, l’odore delle creme solari, fino a mettere a fuoco i pensieri di una donna che sta riflettendo sui cambiamenti della sua vita. Non saprei trovare un solo filo conduttore che tenga assieme i ventisette racconti di La gente non esiste, ma mi sembra che ciò che ricorre spesso è questa attenzione a dettagliare con attenzione e delicatezza stati d’animo e riflessioni dei vari protagonisti, spesso anche attraverso piccoli particolari dell’ambiente circostante. Come nascono questi i tuoi personaggi? Come decidi cosa mostrare di loro e di questi dettagli che tanto caratterizzano la tua scrittura?
Nabokov, che è sicuramente tra i miei scrittori preferiti, una volta aveva detto: «Accarezza il dettaglio, il dettaglio divino». Paul Valéry diceva: «Chi vuole fare grandi cose deve pensare profondamente ai dettagli». Poi: «La verità della storia è nei dettagli», e questo è Paul Auster. Infine Sebald: «Piccoli dettagli che risultano impercettibili decidono tutto!»
Ma perché i dettagli? Philip Roth, in Perché scrivere?, dice che la psicologia, la sociologia, la politica, la storia si occupano di ciò che è universale – le grandi categorie umane, i flussi di popoli, le tragedie – mentre la letteratura osserva il particolare, ciò che è unico e specifico per un singolo essere umano. La storia racconta l’Olocausto e la morte di sei milioni di ebrei innocenti; Spielberg, invece, concentra la sua attenzione sui seicento esseri umani che furono salvati da Schindler, un essere umano pieno di difetti che sceglie una strada inaspettata – quello scarto che può cambiare la vita di una persona. Nel mio caso, il sottotitolo de La gente non esiste potrebbe essere Esiste soltanto il dettaglio.
In Botole troviamo due figli alle prese con una madre anziana che da un preciso angolo del suo giardino sostiene di poter viaggiare nel tempo. In questo caso il lettore si imbatte nell’irruzione di un elemento fantascientifico, in altri racconti, come per esempio Il ventunesimo secolo, in un’ambientazione che è post apocalittica. Cosa ti interessa di questi elementi imparentati alla “narrativa di genere” o ad altri generi letterari?
Per un lettore, la classificazione in generi dei libri è una comodità alla quale è difficile rinunciare. Io stesso, quando ero un lettore un po’ meno esperto, mi muovevo dentro ai confini delimitati da questa specie di etichetta che si appone ai romanzi: i thriller, la fantascienza, i noir, i gialli e i rosa. Il grande maestro del cinema Stanley Kubrick, però, ha mostrato, nel suo campo, come l’appartenenza a un genere (Shining è un horror, 2001: Odissea nello spazio è un film di fantascienza, Orizzonti di gloria e Full Metal Jacket sono film di guerra e Barry Lyndon un film in costume) non sia incompatibile con un’aspirazione artistica più ampia. Nel caso specifico di questi racconti, uso la fantascienza per rilassare alcuni dei vincoli che il realismo a tutti i costi impone, per affrontare temi che nel mondo in cui viviamo sono confusi tra mille altre cose. La fantascienza, o la distopia, come oggi viene più comunemente chiamata, assomiglia a un prisma ottico che riceve, su un lato, la luce bianca, che è l’insieme di tutto quello in cui siamo immersi ogni giorno, e la scinde nelle sue componenti fondamentali, proiettandole su uno schermo un pochino più lontano. Il risultato è che, spostando più avanti le lancette dell’orologio, possiamo isolare, per così dire, una componente del nostro tempo, una tendenza appena accennata, e portarla alle sue estreme conseguenze; con la fantascienza, ad esempio, possiamo inventare un mondo nel quale si sono affermati i populismi che agitano questo 2019 e capire come sarebbe la vita in quelle condizioni.
Ma la fantascienza non è l’unico genere che mi interessa: il romanzo Tutto male finché dura esplora il mondo della commedia, con le sue coincidenze e le sue situazioni geometricamente organizzate, mentre ne L’invenzione degli animali ho usato tutto quello che sapevo del thriller, un genere che ho frequentato, da lettore, tra il 1995 e il 1997, mescolandolo, ancora una volta, con la fantascienza. Mi tentano il rosa, il romanzo storico, il soprannaturale mescolato all’horror. Un po’ alla volta vorrei arrivare a provarli tutti.
Ne Il figlio della signora Bastiani il protagonista riceve una mail intitolata Cerco il mio amore. Pur essendo consapevole che dietro questo tipo di corrispondenza si sarebbe certamente nascosta una truffa, risponde e intraprende uno scambio che lo porta a un vero e proprio stato di innamoramento. Le pagine proseguono descrivendo l’atmosfera di questa intimità digitale che si crea tra una mail e l’altra. Intendevi dare un certo peso alla dimensione della corrispondenza digitale quando hai scritto il racconto? O questi elementi tipici del nostro tempo entrano spontaneamente nelle tue storie?
La storia è vagamente autobiografica, nel senso che queste lettere arrivano più o meno a tutti e finiscono regolarmente nello spam. In un caso, però, avevo voluto rispondere per capire come potesse proseguire una conversazione di quel tipo, basata sostanzialmente su un tentativo di truffare un allocco; e mi ero sorpreso nel ricevere indietro una risposta che aveva un senso – che rispondeva, puntualmente, a quello che avevo scritto io: non quindi un bot, ma una persona in carne e ossa che tentava, con i mezzi che aveva a disposizione, di far nascere un sentimento vero, per poi poter raggiungere il suo scopo. Quindi, come succede per tutti i racconti, mi sono chiesto come sarebbe stato se avessi proseguito, e avessi ceduto alla forza suadente della voce di una persona che dice di volerti bene. In Her, il film di Spike Jonze, il personaggio principale, Theodore Twombly, si innamora del pensiero prodotto da un software che gira sul suo telefono, e la cosa curiosa è che noi, da spettatori, non riusciamo a meravigliarci più di tanto, per questo; quando Theodore parla di questa relazione con la ex moglie, e questa si mostra indignata, ci schieriamo, in modo del tutto spontaneo, dalla parte di lui.
Il punto è che la corrispondenza digitale, i social, i tweet, i messaggi privati, sono letti e prodotti da esseri umani il cui substrato biologico è lo stesso dell’homo sapiens che vagata tra le foreste dell’Europa in cerca di mammuth da cacciare, e che comunicava con i suoi compagni di caccia con gesti e grugniti. Siamo naturalmente portati a credere alle parole, tanto che quando leggiamo un buon libro, o guardiamo un film, arriviamo a commuoverci per la sorte di persone che non esistono, o a innamorarci di loro. Per arrivare a un rapporto razionale con la comunicazione digitale serviranno ancora una o due generazioni.
Il tuo blog, Grafemi, è un ricettacolo di racconti, articoli, recensioni, osservazioni, reportage, rubriche e più semplicemente ricordi. Cosa ti ha spinto ad aprirlo e come immaginavi dovesse declinarsi quello spazio in rapporto alla tua scrittura? Rispetto alla pratica della scrittura dei racconti e dei romanzi, cosa cambia nel blog?
Il blog, questo contenitore di riflessioni, racconti e spunti, è ciò che mi ha portato verso la scrittura: il 5 gennaio del 2006, per motivi che non sapevo, avevo aperto un blog (che allora sapevo a mala pena cosa fosse) su una piattaforma che nel giro di qualche anno ha miseramente chiuso. Fino ad allora avevo scritto pochissimo (e avevo già 35 anni): qualche racconto, e molte mail di lavoro. Il blog ha cambiato tutto, perché per la prima volta mi sono trovato ad avere la possibilità di condividere quello che scrivevo: per quanto piccolo fosse quel pubblico (che tra l’altro scriveva a sua volta: altri blogger di quella piattaforma sono arrivate poi alla pubblicazione su carta), c’era comunque un’interazione. Nei corsi di scrittura che tengo da qualche anno il principio è più o meno lo stesso: fornire stimoli per uscire dalla propria cameretta dove si scrive per se stessi, alzare la testa e parlare al mondo.
Grafemi è stato aperto due anni dopo, con l’intenzione di riservarlo ai miei interessi letterari. Con il tempo è diventato il mio giardino dietro casa, lo spazio per gli esperimenti, quello per ospitare autori che mi piacciono o per dire la mia sugli argomenti che più mi stanno a cuore.
I tempi narrativi del racconto sono diversi da quelli del romanzo, come quelli dei testi ideati per essere online rispetto a quelli destinati al cartaceo. Può essere che questa tua dimestichezza con questa forma letteraria vada a servizio degli spazi della rete?
Ogni racconto che scrivo esce anche su Grafemi. La rete è il luogo ideale per pubblicare un singolo racconto, anche se spesso finisce per confondersi con mille altre proposte. Però non ho mai scritto pensando alla fruibilità di un testo in rete: credo, cioè, che la lunghezza dei racconti sia funzionale alla rete, ma in modo del tutto casuale.
Parliamo invece di Luoghi virtuali, una sorta di rubrica del blog nella quale svolgi un lavoro da detective; la tua curiosità ti ha portato a navigare nei recessi dell’internet, girovagando su Google Maps alla ricerca di posti che hai visto in video. Troviamo i luoghi del marciapiede della celebre Bitter Sweet Symphony dei Verve, il palazzo in cui è stato inciso il celebre singolo di David Bowie Heroes, il piccolo paesino inglese in cui è nato Thom Yorke. Cosa ti interessa di questa storta di reportage e degli spazi che vai cercando?
Fin da bambino, sognavo, prima o poi, di diventare un detective alla Sherlock Holmes: risalire, da pochi indizi, al colpevole. La strada che ho seguito mi ha spinto in altre direzioni, ma sotto è rimasta quella voglia di ricavare una storia da poche tracce; e approfittando dell’enorme quantità di dati presenti in rete, mi diverto a pormi dei problemi da investigatore, per vedere se riesco a risolverli. È un gioco che mi dà soddisfazioni fanciullesche, perché mette insieme diverse mie passioni: quella per le mappe, quella per l’incrocio di informazioni, quella per le persone che vivono in quegli spazi. Un giorno mi sono imbattuto per caso nel blog di un informatico, un certo Matthew M. Osborn, e con le informazioni che aveva lui stesso condiviso ho ricostruito parte della sua vita, proprio nel momento in cui passava dallo stato di single a quello di uomo super innamorato di una certa Holly (ora sono andato a sbirciare il suo sito per capire come sono andate le cose: vedo che è sposato proprio con Holly, e che hanno due figli, e che le parole che più di ogni altra lo definiscono sono father e husband: mi pare che le cose siano andate come lui si augurava). So che questo è un lato un po’ folle del mio carattere, ma sospetto che sia una delle tante conseguenze di essere scrittore e ingegnere.
I tuoi scritti sono seminati ovunque e in varie forme: racconti su antologie, su riviste, romanzi, romanzi in ebook, articoli su blog, recensioni, fino ad arrivare ai testi per graphic novel e a reportage di viaggio; sembra che la tua scrittura riesca a prestarsi facilmente a queste molteplici incarnazioni. Trovi che ci siano differenze sostanziali nelle modalità di lavoro nello spostarsi in queste situazioni diverse? Ce ne sono alcune che ti hanno particolarmente entusiasmato?
Sono convinto che la scrittura sia una e indivisibile, e che il suo ambito di applicazione, la lunghezza di ciò che si produce, il genere o l’ambientazione o lo scopo finale siano elementi accidentali, contingenti – o, vista in altro modo, la maniera con la quale una narrazione si fa, in questo caso, carta.
È però indubbio che ogni contesto ha le sue regole, e che le competenze che servono, ad esempio, per scrivere una recensione non siano le stesse necessarie per portare a termine un romanzo. Il motivo per cui accetto così spesso di impegnarmi in progetti che fino ad allora non avevo mai sfiorato è che credo che le sfide abbiamo sempre qualcosa da insegnare; e anzi, uno dei criteri che uso per valutare una proposta è proprio il grado di novità. E una volta che ho detto sì, mi sforzo di capire cosa caratterizza quel particolare tipo di progetto; cerco dei punti di riferimento che mi aiutino a trovare il giusto modo per arrivare fino in fondo. Al momento, l’avventura che più mi ha impegnato, e che se tornassi indietro farei in modo diverso, è quella della graphic novel, dove non ho saputo tenere in giusto conto i vincoli che una storia “disegnata” impone: sono fiero del risultato finale, ma ora so che potrei fare molto meglio.
In Neolingua uno dei personaggi ad un certo punto afferma che «la neolingua che il potere economico sta imponendo è Facebook». Secondo te, c’è qualcosa che è mutato a livello di linguaggio con l’arrivo dei social network? E nello specifico del tuo rapporto con la scrittura? È cambiato nel corso degli anni il tuo rapporto con la rete?
Il mio rapporto con la rete è in costante evoluzione, e oscilla tra un rifiuto ideologico e una precisa consapevolezza che questo sia il mondo di oggi, e che la sua negazione significherebbe, di fatto, l’isolamento. In che modo incide sulla scrittura? C’è un bel saggio uscito da poco per effequ che si intitola Scansatevi dalla luce. Il concetto principale di questo libro è che i social lottano tra di loro per accaparrarsi il bene più prezioso, e cioè l’attenzione della gente; per questo motivo studiano e poi implementano sistemi sempre più efficaci per tenerci incollati davanti allo schermo – non c’è un intento malvagio dietro questo: semplicemente, il loro business è vendere il nostro tempo, e una nostra propensione al consumo opportunamente incentivata, agli inserzionisti. La mia scrittura, dunque, deve difendersi dalle distrazioni rappresentate dai social, dalle sue sirene, dai suoi richiami. La gratificazione dei like, o la semplice interazione con altre persone, spesso sconosciute, lavorano su parti della nostra psiche molto vulnerabili. Io cerco di adottare alcune strategie che talvolta sono patetiche, come spegnere il cellulare e mettere il computer in modalità aereo nella speranza di riuscire a scrivere per almeno un’ora senza distrazioni.
Allo stesso tempo, però, proprio questo mondo social finisce per rappresentare una fonte quasi inesauribile di ispirazione. Ciò che conta è rimanere scrittori anche quando si finisce dentro a Facebook: il che significa osservare le cose con ironia e un certo distacco, come farebbe un mirmecologo osservando la sezione di un formicaio, senza dimenticare mai che pure io sono una di quelle formiche.
Ultima domanda: è uscito da poco il tuo nuovo libro nella collana Altrove di Chiarelettere, collana relativamente giovane curata da Michele Vaccari che si occupa di raccogliere visioni dal futuro. Ci puoi dire di cosa parla L’invenzione degli animali?
È un romanzo fantascientifico, o, come direbbero gli americani più propriamente, di sci-fi, cioè di fiction scientifica. Un gruppetto di ragazzi molto brillanti e appena laureati viene assunto dalla più grande azienda del mondo per creare il futuro; ma alcuni eventi imprevisti costringeranno Lucia Franti, che è il personaggio principale, a rivedere alcune sue convinzioni, e a spingerla a intraprendere una battaglia solitaria e disperata. Come vedi, quindi, ancora fantascienza e ancora distopia, infilate dentro a un thriller abbastanza serrato. È un libro che desideravo scrivere da tempo, e dove tento di tenere insieme il mio amore per le storie e la mia passione per la scienza.