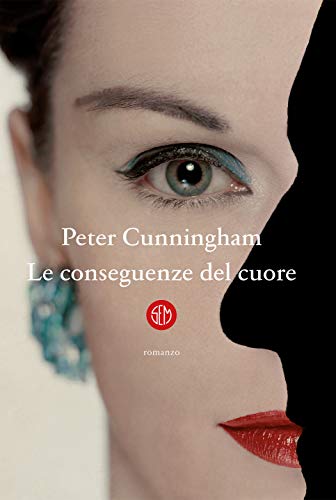È un libro intelligente e, insieme, appassionato Sopra e sotto la polvere di Alessandro Chiappanuvoli (Effequ, 2019). Un libro dal tratto pungente ma leggero, scorrevole, stilisticamente esatto. Un libro in cui è evidente anche il piglio da giornalista e sociologo dell’autore, già chiaro nei lavori precedenti, come Lacrime di poveri Christi – Terzigno: cronache dal fondo del Vesuvio (Arkhè) o in alcuni dei suoi pezzi su Internazionale, Il Manifesto, Il Messaggero o sui blog Nazione Indiana e Doppiozero.
Dunque uno scrittore che ci sa fare (o uno “scrivente”, come si definisce lui stesso) e un sociologo preparato che, per giunta, conosce i meccanismi e i risvolti delle inchieste giornalistiche. La formazione complessa e completa dell’autore si riflette nel libro, che analizza il sisma del 2009 dell’Aquila correndo su un doppio binario: da un lato la narrativa e i racconti che ci immergono in quelle strade, in quelle piazze, in quelle storie – singole e collettive – e in quelle anime che hanno vissuto il terremoto e se lo portano dentro; dall’altro la saggistica e gli approfondimenti che si legano alle tematiche sollevate dai racconti, scendendo però nello specifico, fornendo dati e analisi dei fenomeni.
Una prospettiva interessante, che fa luce sui pieni e sui vuoti del sisma, sul dentro e fuori, sul sopra e sotto la polvere appunto, su quel che si vede e quello che si vede – e si è visto – meno.
Ed è così che dal momento del silenzio, del disorientamento, del rispetto del dolore più lacerante, si passa a un’esigenza viscerale di parola, di testimonianza. La voce che Chiappanuvoli dà ai protagonisti delle sue storie, che sono cittadini, amici, amanti, operai, vigili del fuoco, stranieri e studenti che si muovono dentro una sceneggiatura fatta di palazzi che implodono e di tende che hanno come sfondo la bellezza dei monti d’Abruzzo, è una voce ferma e sicura, nonostante intorno tutto sia tremante, incerto, pauroso.
Così come è ferma e decisa la sua, di voce, che non ha paura di dire come stanno le cose, non ha timore di raccontare ciò che ha visto e vissuto, né di fornirci carte e numeri su cui farsi qualche domanda.
Ma tutto ciò che viene fuori da questo libro non è denuncia. L’esigenza di raccontare è invece, soprattutto, opportunità: di reazione, di riflessione, di cambiamento, di rinnovamento, di prevenzione, di ricostruzione del tessuto sociale e psicologico.
Un libro necessario, ho pensato quando l’ho aperto. Un libro necessario, ho pensato quando l’ho chiuso. E per di più, un libro necessario che si fa leggere facilmente grazie a una scrittura raffinata, limata, accurata, ben scelta ma mai ostentata, forzata o artificiale. Bella, semplicemente bella. Sulle tematiche, che sono tante e sono importanti e sono scottanti e pure pressoché infinite, perché ognuna si porta dietro innumerevoli spunti di riflessione, non dirò nulla: ci avviciniamo ai temi chiave attraverso le domande, così da non svelare troppo e non rovinare l’impatto col libro. Buona lettura!
IL TITOLO – la polvere
Cominciamo dall’inizio, cominciamo dalla polvere. Da buona abruzzese come te ho pensato subito a Fante e alla polvere del suo Ask the Dust, oltre ad aver potuto capire –purtroppo – nitidamente e istintivamente, quel “sopra e sotto la polvere”. Ci racconti come nasce questo titolo?
Sebbene dietro la polvere della West Coast e la polvere lasciata dal terremoto ci siano, credo, sogni infranti molto simili di modernità, e di grandezza aggiungerei, il riferimento a Fante non c’è. Sopra e sotto la polvere richiama soltanto la distruzione, l’abbandono del terremoto e le dinamiche umane e sociali che stanno in superficie e che vi sottendono. Il titolo nasce di concerto con Francesco Quatraro, il mio editore, e principalmente perché il titolo originale, “Delirium Tremens”, era a suo dire troppo criptico – e al momento di prendere una decisione mi sono trovato d’accordo. La polvere permette invece un rimando chiaro, diretto.
IL LIBRO – il doppio binario
Racconti e approfondimenti, narrativa e saggistica: abbiamo parlato della bipartizione del tuo libro, di questo doppio binario che emoziona e, insieme, informa. È una bella sfida questa, che potrebbe addirittura riuscire nel miracolo di avvicinare il lettore all’aspetto più profondamente conoscitivo di un fenomeno.
Il doppio binario nasce su proposta dell’editore. Dopo aver letto i racconti, Francesco mi chiese se avessi potuto integrarli con dei saggi per inserire così il libro della loro collana Saggi Pop. Era una sfida un po’ rischiosa non avendo mai scritto saggi sul terremoto, ma data la mia formazione e il lavoro di reportage svolto tra il 2016 e 2017 per Internazionale accettai. In fondo, già la parte narrativa nasceva con l’intento di svelare i meccanismi sociali, psicologici, politici, economici che sottostanno all’emergenza sismica per come siamo abituati a vederla, in forma spettacolarizzata e semplificata attraverso simboli creati ad hoc dai media, insomma; aggiungere dei brevi saggi che mi permettessero di esplicitare l’intento originario dei racconti era dunque un’occasione e l’ho voluta cogliere.
Non so se mi sento legato più alla forma saggistica o a quella narrativa. Credo di essere più portato per la narrativa, ma per me scrivere è sempre un modo di conoscere, me stesso o il mondo che ci circonda. La forma, io credo, deve rispondere all’esigenza divulgativa e non essere uno strumento con il quale dimostrare il proprio valore, la propria bravura. È con questo approccio che ho affrontato le due anime del libro, per trasmettere sotto più punti di vista possibili le dinamiche connesse al terremoto, per divulgare ancora una volta saperi che spesso dimentichiamo con troppa facilità. La prima forma di prevenzione per il terremoto, come per ogni altra catastrofe, è la conoscenza.
IL TERREMOTO – la comunità e la crisi della presenza
Entriamo nel vivo. Tu ci parli di terremoto da una doppia prospettiva: siamo di fronte a un fenomeno geologico e culturale. Dopo un terremoto, infatti, non sono solo gli edifici a essere distrutti. Sono letteralmente distrutte le persone, i rapporti tra le persone, l’intera comunità. Il tessuto psicologico del singolo si disgrega, ritrovandosi inevitabilmente compromesso, e ristrutturarlo, tesserlo di nuovo, si rivela non facile. Citi De Martino e la sua “crisi della presenza” e parli di una ritualità, in un certo senso, legata all’emergenza. La stessa disgregazione avviene a livello sociale, sebbene in questo senso credo possa essere più immediato e naturale riscoprirsi comunità e agire per rafforzare l’identità di un territorio. Come è cambiata, dunque, la comunità aquilana, a livello sociale e psicologico, dopo il sisma del 2009?
Come l’ultimo De Martino, io credo che l’essere umano sia costantemente esposto alla crisi e alla “crisi della presenza”, soltanto, aggiungerei, tende a dimenticarlo, a ignorare la sua natura precaria affidandosi completamente a strutture culturali, a credenze di vario genere. Sembra quasi che essere calati a pieno nel momento sia socialmente impossibile. L’Aquila in tal senso incarna questa teoria. Era una città in declino politico ed economico prima del terremoto ed è una città senz’anima, senza idee circa il proprio futuro, oggi. Di mutato in questi dieci anni c’è, appunto, la comunità, che davanti alla distruzione, alla possibile perdita di se stessa, del proprio “campanile” per dirla con De Martino, si è come risvegliata. Sono rinati un attaccamento e un amore per il territorio prima quasi impensabili. Attaccamento e amore che però, io credo, non hanno ancora trovato la giusta dimensione sociale, collettiva, perché non hanno, purtroppo, ancora trovato alcun radicamento nelle classi politiche e dirigenti. La comunità aquilana è cambiata nei singoli ed è grazie alla loro opera se la città oggi respira un’aria di rinnovamento, una frizzante aria culturale e imprenditoriale. Oggi abbiamo più artisti, più imprenditori, più persone che coltivano la propria passione, e il frutto del loro lavoro si sta ripercuotendo sulla comunità tutta. In qualche modo, magari non del tutto consciamente, siamo più vicini, più aderenti alla nostra “presenza”.
IL TERREMOTO – la memoria e la prevenzione
Siamo nel decennale del sisma del 2009, simbolicamente un anno di un certo peso. Abbiamo assolutamente bisogno di ricordare, di fare memoria del passato. Ma cosa funziona e cosa non funziona di questo discorso sulla memoria? Perché continuiamo a fare gli stessi errori (nella Storia in genere e nella storia dei terremoti in Italia, nello specifico, visti i successivi disastri)? Quanto possiamo e dobbiamo legare la memoria alla prevenzione? A una prevenzione gestita in maniera efficace…
La memoria storica e soprattutto la memoria del territorio in Italia sembrano avere vita breve. Ma se per i tempi storici in qualche modo è lecito, sta nelle regole del gioco politico raccontare parzialmente, amplificare o mistificare i fatti, e penso ai rinascenti estremismi odierni che impongono tutta la forza d’azione degli anticorpi democratici, il discorso sulla memoria del territorio non permette, o non dovrebbe permettere, interpretazioni di parte, non permette errate interpretazioni. Il rapporto tra memoria e prevenzione è necessario, imprescindibile. La prevenzione non è fatta soltanto di normative, investimenti, regolamenti, suddivisioni di responsabilità, è fatta di conoscenza, di tradizione, di esperienza. È per questo che non sono d’accordo su un tipo di ricostruzione come quella aquilana che tende a ristrutturare completamente gli edifici (parlo di quelli vincolati o storici) nascondendo del tutto le ferite del sisma. Se a questo si aggiunge che dopo dieci anni non abbiamo ancora una piazza che ricordi le vittime, mi pare proprio che a L’Aquila non si stia lavorando per salvaguardare la memoria ma per obliarla, per cancellare il prima possibile il passaggio della catastrofe; e credo sia un atto grave.
IL TERREMOTO – la gestione dell’emergenza
Ci parli nel libro di preoccupante disorganizzazione tra i vari Corpi dello Stato giunti a L’Aquila dopo la grande scossa del 6 aprile 2009. Lo stesso hai potuto constatare anche ad Amatrice, nel 2016: eri presente in prima persona per dare una mano alle operazioni di soccorso. Ci dici: «Gli unici che avevano ben salda in mano la situazione erano i Vigili del fuoco». Dunque la gestione delle emergenze probabilmente non funziona proprio come dovrebbe…
Questo è un ambito molto delicato. Va ribadito che chiunque sia presente in un caso di emergenza è conscio del rischio che corre e dunque il suo impegno è lodevole sempre. Sul merito della disorganizzazione delle prime ore penso di aver soltanto rilevato un aspetto di cui, per fortuna, anche i legislatori si sono resi conto negli ultimi anni. Con il nuovo decreto legislativo del 2 gennaio 2018 in tema di protezione civile, infatti, è stato stabilito che la responsabilità delle operazioni di salvataggio nella prima emergenza ricada solo sui Vigili del fuoco: un’unica mente, e la più preparata, che organizzerà l’azione congiunta di tutti gli altri Corpi dello Stato. È, in teoria, un grande passo in avanti. In teoria, perché siamo in Italia, e per vedere se questo nuovo assetto porterà i suoi frutti non resta che attendere, ahimè, la prossima calamità e incrociare le dita.
L’AQUILA – L’Aquila e i media
La parte saggistica del tuo libro è anche in qualche modo inchiesta giornalistica. Abbiamo ricordato che collabori con diverse testate e conosci i meccanismi del giornalismo. Dal sisma dell’Aquila è stato creato un caso mediatico rumorosissimo, una tragedia diventata scoop: facciamo due chiacchiere, partendo dal sisma del 2009 e se vuoi arrivando ad oggi, sull’importanza e sulla qualità dell’informazione e del giornalismo.
Non credo di aumentare le offerte di lavoro rispondendo francamente alla tua domanda. Ma il problema è serio e ogni riflessione critica, anche la mia, può essere utile. Il giornalismo mi pare, e sono cosciente di avere un’opinione molto dura, abbia perso progressivamente il suo ruolo di servizio, di controllo, smarrendosi dietro atteggiamenti e pratiche più simili all’intrattenimento. Non voglio criticare tutto e tutti ovviamente, ci sono giornalisti bravi, preparati e che sanno formarsi e informarsi a dovere sul campo; in questi dieci anni ne abbiamo conosciuti molti sia tra le file dell’informazione mainstream che di quella indipendente. Il punto principale è, appunto, questa specie di rincorsa allo scoop, alla notizia à la page, condensata quasi sempre dietro un oggetto simbolico che possa catalizzare il fruitore dell’informazione: il campanile simbolo, il superstite simbolo, la casa crollata simbolo, la casa ricostruita simbolo e via dicendo. Questa eccessiva simbolizzazione provoca un’eccessiva semplificazione dei fenomeni, delle catastrofi; sono offerti gli effetti subitanei, emotivi, le cause e le responsabilità vengono discusse quando i corpi delle vittime sono ancora seppelliti sotto le macerie. Pare non esserci più spazio e non più tempo per la riflessione, per la comprensione: l’informazione si è come messa a inseguire i social network declassandosi quasi, perdendo la sua vera anima, il suo ruolo principale, di servizio per il cittadino e di controllo nei confronti del potere. Non credo di dire cose nuove, ma nell’ambito specifico delle catastrofi l’effetto semplificatorio dell’informazione crea danni ancora maggiori. L’Aquila si pensa ricostruita, così pure l’Emilia, la costruzione in Centro Italia sembra essere iniziata, ma purtroppo se si va a osservare con i propri occhi la situazione è drammaticamente diversa. E in questi territori, come in tutti gli altri più piccoli colpiti da altri eventi calamitosi, è la costante attenzione dei media e quindi lo sguardo dell’opinione pubblica a fare la differenza, a stimolare l’intervento politico affinché metta in opera soluzioni vere e concrete. È questo il ruolo di servizio e di controllo che purtroppo mi sembra stia venendo sempre più a mancare.
L’AQUILA – L’Aquila e i vari linguaggi narrativi
Ho visto Habitat di Emiliano Dante e mi è piaciuto molto, l’ho trovato perfetto nel linguaggio e nella sua funzione: il grande schermo è un altro mezzo utilissimo per raccontare, per documentare alcune realtà. Cambia il ritmo della narrazione, dilatato nei libri e assolutamente veloce e dinamico nei film, ma non cambia la fortissima esigenza di raccontare. Diversi linguaggi narrativi, dunque, intorno al terremoto e sulla città. Ci consigli qualcosa di interessante da leggere (oltre al tuo libro, chiaramente), da vedere, da ascoltare? Insomma un prodotto di qualità che possa avvicinarci all’Aquila e farcela vedere magari da un’altra prospettiva.
Sicuramente dimenticherò qualcosa e me ne scuso con gli autori. Penso però alle due opere di Enrico Macioci, Terremoto e La dissoluzione familiare, libri che hanno un grande valore narrativo e testimoniale. Ad Appennino, il film successivo di Emiliano Dante sul terremoto del Centro Italia. Al documentario Comando e controllo di Alberto Puliafito, girato nell’estate del 2009. Allo spettacolo teatrale itinerante Dècade, città possibili, ideato per il decennale dal Circolo Bergman in collaborazione con Arti e Spettacolo dell’Aquila. Alle raccolte di poesie di Anna Maria Giancarli, E cambia passo il tempo, poesie sull’Aquila, o di Fabio Orecchini, poeta non aquilano, Per Os. Ma penso anche alle opere di divulgazione scientifica, saggi e libri, di Giovanni Gugg, Silvia Pitzalis, Manuele Bonaccorsi, Antonello Ciccozzi, Fabio Carnelli, Pietro Saitta, Gianluca Ligi, Lina Calandra, Rita Salvatore e tanti altri. Un bagaglio immenso e utilissimo di sapere scientifico quasi sempre accessibile anche al lettore medio. Insomma, c’è un enorme produzione artistica e scientifica di tutto rispetto sul terremoto da cui si può partire per rendere, finalmente, i fenomeni tellurici conoscenza domestica, familiare, parte integrante del nostro corredo culturale, come è giusto che sia in un territorio, quello italiano, in costante rischio sismico, e non più relegati invece a casi eccezionali, sporadici ed esposti a un altro rischio, ancor più pericoloso, quello appunto dell’oblio, della perdita di memoria.
L’AQUILA – L’Aquila oggi
Che tipo di città si va delineando oggi? Com’è L’Aquila del 2019, dieci anni dopo il sisma?
L’ho già detto in altre interviste e scritto in altri articoli, provocando peraltro malumori che per mio conto non fanno che confermare la mia opinione: L’Aquila è una città ricostruita senza un’idea guida, L’Aquila è una città senza idee e senza identità. Lo era prima del 2009, lo è oggi dopo dieci anni. E, sia chiaro, indipendentemente dal colore politico che la governa. Qui dominano i piccoli grandi interessi personali e familiari, il tornaconto politico o economico di pochi rispetto al benessere di tutti. È il “familismo amorale” di Banfield: l’agire unicamente per vantaggi materiali di breve termine presupponendo che anche gli altri facciamo lo stesso. È, nella teoria che ha sotteso la ricostruzione, la logica del “dov’era-com’era”, ossia il ritorno “indolore” all’ordine costituito prima del sisma: una specie di Congresso di Vienna, di restaurazione (non a caso) in scala. Questa mentalità continua a imperversare e a condizionare la vita cittadina bloccando quasi ossessivamente una vera idea di sviluppo. Che cosa vogliamo diventi la nostra città? – questa è la domanda che nessun politico o dirigente ha il coraggio, ha voglia di farsi. E credo che ormai siano i cittadini a doversi far carico di tale istanza e a dover imporre alla classe politica una scelta concreta, condivisa e sostenibile. Non c’è molto tempo ancora, è oggi che dobbiamo porre, anzi dobbiamo esigere, che vengano poste le basi per la città di domani. Per ora, invece, si è solo ricostruita, casa per casa, la stessa città in declino che c’era prima del terremoto.
MANCANZA
Nell’explicit ci parli in un certo senso di una funzione positiva del caos, di sensazioni adrenaliniche cha sanno dare una spinta al rinnovamento. Ci dici persino che ti manca il terremoto. Spiegaci meglio questo aspetto interessantissimo.
Più che nelle risposte precedenti qui devo cercare di essere breve e quanto mai cauto. Al netto delle perdite umane, al netto dei danni materiali, sia questo ben chiaro, credo, anzi, dovrei dire che ho la speranza che il terremoto possa essere un momento di profonda riflessione, personale e sociale. Il terremoto dovrebbe essere considerato come un momento di rottura, al pari di una malattia, di una degenza grave che mette a rischio la propria vita, di una crisi di relazione amorosa importante, della perdita di un figlio, di una compagna o compagno, di un padre o una madre, come uno di quei momenti, insomma, che impongono una riconsiderazione della propria vita, delle proprie credenze, delle proprie abitudini: una sorta di palingenesi, di resurrezione, che conduce al superamento della crisi e al miglioramento, se possibile, rispetto alla condizione precedente. Un’occasione, detto altrimenti, per ripensare noi stessi, le nostre città e paesi, il nostro stile di vita, le nostre decisioni politiche ed economiche, e, possibilmente, per correggere gli errori fatti, per non incorrere di nuovo negli stessi errori del passato, per prevenirne di nuovi. Un’occasione per crescere, ripeto, al netto delle dure conseguenze. E credo che una vera rinascita sia davvero possibile solo se si apre davanti ai nostri occhi il baratro della fine.
Sulla questione poi della mancanza del terremoto, la mia impressione è ancora più intima. Avvertire le scosse di terremoto, sentirle nel profondo, nel centro del petto, è come sentire all’improvviso scorrerti dentro la forza della vita. Ma non è solo adrenalina, è più un’inaspettata e subitanea sensazione d’esserci, di essere vivi, di essere nel mondo qui e adesso. È, così chiudiamo il cerchio, un’istintiva risposta alla “crisi della presenza”, uno scrollio repentino che per qualche attimo, se sia ha la forza e la fortuna di coglierlo, ci libera dal continuo e lento accumulo di polvere che è, inutile negarlo, la nostra esistenza, la nostra quotidianità. È una specie di risveglio che però poi va coltivato, cosicché quell’energia si trasmetta a ogni nostro gesto, a ogni nostra attività, tramutandosi in passione, in vitalità, in entusiasmo. E spero umilmente che così dicendo io non ferisca nessuno.
(Alessandro Chiappanuvoli, Sopra e sotto la polvere, Effequ, 2019, pp. 336, euro 15, intervista di Antonella Finucci)