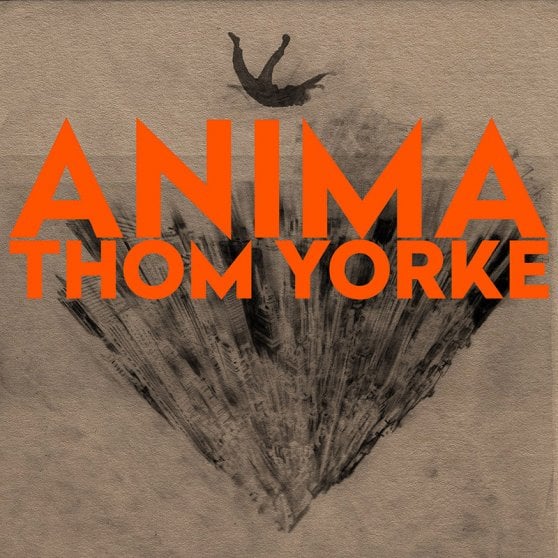Tolstoj definisce il popolo come qualcosa di indomabile, selvaggio. Imporgli un freno da far rispettare è impossibile. È pura entità libera da costrizione: il suo confine tra marginalità e degrado è labile ai limiti dell’invisibile. Le sole regole che sembrano, per lui, valere sono quelle della strada e del vivere della necessità contingenti, per non imbattersi in quel disagio che fa a botte con un conformismo che sa di buono, che crea il “modello da seguire”, diverso e lontano da quello “sozzo” degli ultimi, dei diseredati, di quei borgatari che hanno come unica fonte di piacere e soddisfazione la “grana”.
È innegabile, però, che questo essere così magmatico intenso e crudo, renda il “popolo” affascinate. Metro di una “valutazione” sociale che per molti è rimasuglio di un’epoca che non c’è più, per altri unico modo per capire la sua evoluzione temporale, necessaria per decifrare l’ “intorno a noi”.
Un leggere che può essere fatto non solo con “il bene” espresso dal popolo, ma anche e soprattutto, può essere codificato attraverso quei canoni violenti capaci di lacerare l’animo dell’uomo e che a tutt’oggi non hanno ruga, demenza o segno del tempo.
Questo è il primo pensiero che nasce, nel leggere e rileggere un’opera che alla sua prima uscita fu bandita, censurata processata perché troppo scabrosa, scurrile e inopportuna ma soprattutto non del tutto “reale” rispetto a un mondo che da molti era intravisto dietro un vetro zigrinato, opaco per le molte paure: Ragazzi di vita (Garzanti) di Pier Paolo Pasolini.
Pubblicato nel 1955, inizialmente concepito come romanzo di apertura di una trilogia più ampia (per altro mai completata) che avrebbe dovuto essere così composta: Ragazzi di vita, Una vita violenta e Il rio della grana (mai pubblicato), è, per chi abita in Friuli, e specialmente a Pordenone (che dista pochi chilometri da Casarsa della Delizia) forca caudina scolastica a cui non si può sfuggire.
La prima lettura ai tempi della scuola. Inevitabilmente didattica, di dovere. Passata veloce, con il desiderio di riporre nel più breve tempo possibile il testo negli scaffali più alti e nascosti della libreria di casa, al fine di magicamente farlo scomparire.
Gli anni trascorrono dimenticandolo, fino a quando quell’invisibilità torna visiva e riappare con i segni del suo tempo: la copertina sgualcita, le pagine ingiallite e che si staccano per la rilegatura incerta. Si apre il risvolto. Se ne legge la quarta di copertina, e inconsapevolmente si rimane ipnotizzati, dalla forza di parole, dei fatti e di storie immutati nella loro narratività che sconcerta, nella riflessione.
Catapultati nel “suo” mondo di adolescenti, ragazzi appunto, che della vita conoscono poco o nulla ma con una voglia di riscatto “da fine guerra”. Nelle narici percepiamo netto il pizzicore della polvere, sotto i piedi la grossezza dei sassi di strade abbozzate, di quella periferia romana che più non esiste (ma che forse è solo cambiata), e nel cuore e nelle orecchie le loro storie fatte di disgrazie, furti e violenze di ogni genere. Il caldo è soffocante. È quello di quei luglio di una volta che fa grondare di sudore stando solo fermi. Di lontano ci sembra di intravedere una sagoma. È un ragazzo nel suo completo che ha più buono, con gli scarpini della festa pronto per la comunione e cresima. Ha più le fattezze di un bullo che di un catecumeno. È Riccetto il filo rosso flebile e lineare a cui Pasolini dà il compito (senza mai giudicarlo) di raffrontarsi con il mondo “crudo” lungo tutto il romanzo. Un mondo spesso parallelo, nascosto fatto di ragazzi, uomini, donne situazioni estreme, dove l’atto di generosità verso l’altro è solo apparente, e si trasforma codificandosi in conformismo in bilico tra il borghese e il borgataro.
La sua è una presenza spesso diretta, alle volte indiretta “da spettatore” di altri che lo circondano che lo fa diventare unico “personaggio” nella sua crescita da giovane a uomo, attraverso borseggi, furberie e atti più o meno violenti che lo vedranno vincitore, perdente fino alla definitiva metamorfosi borghese che omologherà uniformandosi ai modelli “perbenisti” del tempo.
Le vicende, viaggiano e si snodano di periferia in periferia, a Roma in un lasso temporale che fa da fine guerra al confine del boom economico: dal Tiburtino al Tuscolano, passando per Tor Pignattara e Monteverde a San Giovanni e Villa Borghese fino a Ponte Mammolo.
Perché solo qui si incontrano le varie facce del “popolo” furbo e accattone, porazzo e diseredato, in equilibrio precario tra droga e omosessualità, gioco d’azzardo, furti e borseggi, precarietà familiari e “di destino”. L’unica occupazione, provvisoria o meno, per sopravvivere è l’“espediente” (lecito o meno) per avere per reperire la “grana” che fa “andar avanti il mondo” e che non contempla fatica, sudore, sacrificio o lavoro.
Riccetto si relazione continuamente con questo popolo sempre diverso e forse sempre uguale. Nel suo osservare, assistere si possono facilmente riconoscere a tratti le sfumature di un Pasolini annichilito, incuriosito e a volte spaesato per una Roma che sta iniziando a conoscere e scoprire, diverso dal suo Friuli: intimista rude crudo e concreto.
Con Riccetto ci sono Agnolo e Marcello (amici d’infanzia di Riccetto), Alduccio (il cugino) e Caciotta, Lenzetta e Amerigo (il giocatore d’azzardo) e Genesio sino ad arrivare a Il Begalone; le loro famiglie fatte di frammenti di pazzia non sempre apparente, di vizio per il gioco e per una sessualità che ha perso i tratti del romantico, e con una voglia di “fregare” l’altro (prima di essere fregati) per poter essere considerato “er più”, “er meio”, “er divino”.
Questi giovani uomini, tutti, si credono invulnerabili e possenti, ma a poco a poco diventano vittime di un’evoluzione sociale avversa che lascia spazio unico e solo all’affermazione violenta. La loro accettazione “sociale” può avvenire esclusivamente attraverso il modello “borghese”: che allontana, avvicinando; che omologa, diversificando una vita che solo apparentemente può, e forse vuole, essere governata .
In un susseguirsi di quadri narrativi, fatti di capitoli quasi auto-conclusivi, le azioni di uno o di un gruppo di personaggi diventano “traino vivo” ancor oggi rintracciabile nei gruppi di strada di oggi dove ogni atto o comportamento è metro di giudizio di pensiero di conseguenza.
Come il semplice atto di Riccetto di salvare una piccola rondine dall’annegamento, prigioniera dei gorghi del Tevere si trasforma trasfigurando l’anima quando lo stesso Riccetto da ragazzo d’azione in fondo buono, diventa uomo spettatore di lontano, e da spettatore assiste all’annegamento dell’amico Genesio .
E tutto questo avviene in quella che è pura coralità di ragazzi ancora acerbi di vita, intravedendo da subito gli estremi di azioni che nello scaturirsi dagli occhi osservatori di Pasolini diventano puri atti che sanno di teatro descrittivi di “dura vita”. Tra bische per il gioco d’azzardo, anfratti dove la prostituzione (maschile o femminile che sia) è moneta di scambio e di guadagno, violenze familiari e ladrocini, ogni personaggio, da attore “di vita” cerca di trovare un “un proprio posto”, una collocazione in quella società borghesemente e capitalisticamente ingessata, fatta di morbidezze solo apparenti, dove la solidarietà verso l’altro è solo un vestito buono da indossare in rare e speciali occasioni, ma sempre e soltanto di lontano dal lerciume zozzo della borgata.
Lo spaesamento dei borgatari e del lettore è innegabile. Pasolini lo accentua, con una scrittura snella e limpida, utilizzando il registro linguistico della lingua dialettale (i personaggi parlano il romanesco) che è grezza, scurrile e spesso decisamente volgare. E lo fa perché vuole essere un cronista del reale e non del vero. Di quello che si vede non di ciò che ipotizziamo reale. La scrittura invita a “leggere, osservare, riflettere” su una società che omologata in un perbenismo “di tutto su tutti” ha fame di riscatto possibile e attuabile sono con la violenza, il furto, l’inganno. La paura perciò ne sarà celata in una temporalità senza tempo che ha tutti i caratteri della fluidità baumaniana: li le omologazioni spengono l’uomo, e non resta che la violenza accattona ed ergendosi sul popolo agitante.
Pasolini in questo è assolutamente e spaventosamente attuale. Profeta, lettore osservatore di quei caratteri della società che non si limitano a essere “tipici” di quel periodo storico, ma che si ripropongono quasi immutati, con caratteri e nomi diversi ma con caratteristiche uguali: il bullismo, la povertà, la violenza verso l’altro e verso la donna, la disoccupazione la voglia di riscatto. Una nettezza realista, già cinematografica, poetica quasi lirica, che ha molti richiami al mondo friulano della madre per atmosfere e valori. Il pomeriggio trascorso nella normalità con al famiglia di Sor Antonio, delle sue figlie del suo focolare, di sua moglie descrivono il modello possibile e alternativo. Perché l’onesta può contaminare anime “perse” come quella di Caciotta e Ricetto denudati dalla loro maschera
E poi arriva lei, a regolare e sistemare debiti “sospesi”: la “Comare secca”. Ed il fio sarà pagato sull’argine dell’Aniene. Da Genesio avvolto e risucchiato in gorgo. Riccetto e noi accanto a lui osserveremo da lontano, distaccati perplessi. E l’arida secchezza dell’animo di Riccetto sarà muta, chiara compiuta. A noi come lettori e uomini non sarà concesso molto perché: «Zittire la fabula morale del popolo è impossibile oltre che improbabile. Attraverso la sua lingua che racconta e descrive il suo vivere e le sue contraddizioni, il popolo può dare nuova luce al vivere dell’uomo».