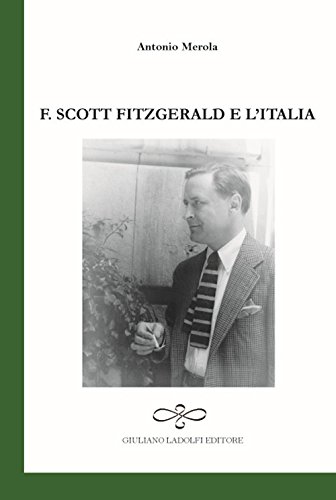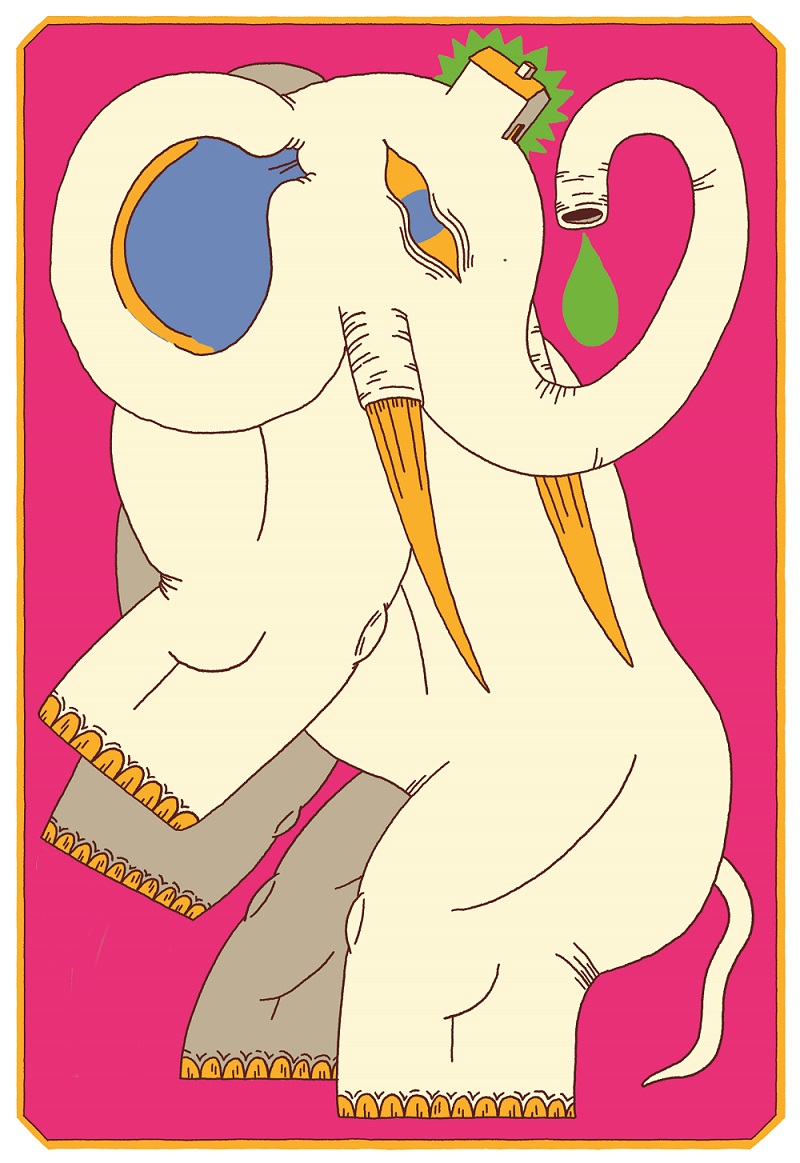Davide Coltri è prima di tutto un operatore umanitario. Dopo aver vissuto molti anni a Beirut e aver prestato opera in paesi come Iraq, Sierra Leone, Turchia e Siria, Davide ha pubblicato con minimum fax (2019) una raccolta di racconti dal titolo Dov’è casa mia – Storie oltre i confini che contiene le storie di alcune persone realmente incontrate dall’autore sulle quali poi la letteratura ha agito, in alcuni casi modificando qualche dettaglio, in altri ipotizzando un finale, ma mai distorcendo la realtà dei fatti. Incontro Davide al Salone del Libro di Torino, è sorridente, affabile; a prima vista le tracce che si porta dietro della sua esperienza sono un’estrema cordialità, dei gesti pazienti e una profonda predisposizione all’ascolto. Ci sediamo al bar esterno, con il tendone a farci da copertura per il meteo di questo maggio impazzito.
Davide, il titolo del libro, Dov’è casa mia, richiama in maniera ambigua sia un’affermazione che una domanda aperta. Alla lettura del libro, d’altra parte, sembra ragionevole supporre però che la risposta ci sia e che possa essere un generico “in nessun luogo”. Quale dritta dai in qualità di autore?
Sicuramente c’è un senso di spaesamento che, prima ancora che toccare i singoli protagonisti, è toccato a me. A un certo punto del mio percorso, quello che poi ha condotto alla crisi personale da cui è nato il libro, mi era realmente impossibile capire in quale luogo potessi sentirmi a casa. Non riuscivo a riconoscere come miei i luoghi di origine qui in Italia, sentivo spesso più vicini posti in cui ero stato in missione, seppure li sapessi distanti, nel tempo e nello spazio. Alcuni dei luoghi in cui ho lavorato – Iraq, Tanzania – mi sono rimasti dentro come una casa vera e propria, perché là si è creato un vero rapporto sia con la gente che con il paesaggio, indipendentemente dalla durata della missione. Il ritorno in Italia, invece, era sempre difficoltoso, un sentirsi alieno, spesso per l’impossibilità di condividere quello che avevo visto. Spiegare il mio lavoro è molto difficile.
Quali sono le difficoltà che hai incontrato nel raccontare le tue esperienze e come hanno influenzato l’ideazione del libro?
Come ti dicevo, il problema è spesso la mancanza di una narrazione che permetta attraverso dei riferimenti comuni di accedere a quello che voglio dire. Mancando le coordinate per collocare le mie esperienze, ho rinunciato più di una volta a parlare perché i racconti incontravano scarsa attenzione o riscuotevano successo solo quando toccavano il “sensazionale”. Quando mi trovavo a raccontare di essere stato sequestrato allora riuscivo a farmi strada nell’ascolto degli altri, ma mancava tutto il resto della mia vita. Tornare significava essere assalito dalla quotidianità “normale” degli amici, la routine del lavoro, i bambini, ma quanto riguardava me diveniva non comunicabile. Ecco, per sentirsi “a casa” mancava il fatto di riconoscersi ed essere riconosciuto dagli altri. È stato questo mutismo che mi ha indotto a scrivere.
Per quale motivo, percepita questa esigenza di ordinamento ed elaborazione dell’esperienza, hai deciso di strutturare una narrazione in prima persona? Non sarebbe stato più oggettivo raccontare le vicende in terza persona dal momento che non sei tu il protagonista dei racconti, ma le persone che hai incontrato?
In un primo momento doveva essere così infatti. Quando sono stati scritti c’era proprio l’esigenza di trattare le vicende che mi avevano sconvolto in modo da dargli una forma e una progressione narrativa, con un certo distacco. E per questo la mia volontà era l’utilizzo della terza persona e la forma racconto. È stato poi un lavoro di editing che ha spostato i testi in prima persona, il che ovviamente mi ha forzato a reimpostare molte idee da capo in un lavoro di riscrittura per me molto faticoso, verso il quale ero molto riluttante agli inizi. Alla fine però mi sono convinto e devo dire che adesso sono anche molto grato a Gazoia [editor di minimum fax, n.d.r.] per il suo lavoro, soprattutto per la coerenza che siamo riusciti a imporre al libro, limitandone – spero – le problematiche. Ho capito poi che la narrazione in prima persona mi permetteva di aderire meglio agli scopi del mio raccontare. Per la vicinanza che ho avuto con le persone che sono poi diventate i protagonisti, per me era infatti più naturale un’immedesimazione completa con loro. Soprattutto perché con queste persone ho condiviso momenti densi, anche di tensione, e nonostante il loro retroterra culturale completamente diverso dal mio mi sono, come dicevo prima, sentito più a casa, più vicino a loro che ad altri in Italia. Le esperienze condivise hanno fatto sì che mi ritrovassi a raccontare le vicende di persone incrociate nella mia vita per un paio di mesi o poco più con la stessa intensità con cui avrei raccontato le vite dei miei più cari amici. È di nuovo una questione di riconoscimento. Mi sono trovato a dover spiegare me stesso davanti a un curdo o a un burundese più che davanti a un mio ex compagno di classe, e questo mi ha fatto iniziare a credere fortemente nell’esistenza di un sostrato comune tra tutti gli umani, che esiste e, nonostante venga continuamente ricoperto dall’accentuazione delle differenze, non ci deve allontanare dal fatto che di base le ambizioni e i modi di vivere che le persone hanno sono molto più simili di quanto si pensi.
Dal tuo libro emerge un’idea binaria di confine. Da un lato si assiste a un inasprimento dei confini e dei limiti che essi impongono, dall’altro, invece, sembra che gli stessi vadano progressivamente in pezzi e che anzi le crisi a cui si assiste durante la lettura siano causate proprio dalla perdita di riferimenti, dalla frantumazione delle barriere. Da un lato quindi il confine si radicalizza, dall’altro si atomizza, ma qual è il vero problema, la sua presenza o la sua assenza?
Il libro vuole avere un’impronta cosmopolita e illuminista. C’è una comunanza di intenti e umanità che è più profonda dei confini intesi sia come geografico-politici che culturali. Questa comunanza non è scontata; è spesso sepolta sotto le stratificazioni, la cultura di origine, l’educazione la religione. Ma c’è un tentativo che è proprio quello umanitario, combaciante col lavoro che faccio, che è andare a vedere al di sotto di tutte queste cose quale sia l’elemento che ci accomuna. Dopo, è vero che il rapporto con il confine più tradizionale è ambivalente. Io da un lato vedo la totale arbitrarietà dei confini, il loro essere artefatti, ma vedo anche che il confine spesso protegge che si volge ad elemento positivo. Varcare un limite per uscire da un paese in guerra significa spesso ottenere la salvezza.
Le rare volte che l’Europa emerge nel libro pare affiorare più come un’idea che come una realtà vera e propria. Mai presente, l’Europa (o l’Occidente) è evocata come una realtà ideale piuttosto che pragmatica, che si presenta sotto forma di richiami culturali più che come vera garanzia di riscatto e realizzazione.
Penso che tu abbia ragione. Spesso mi è capitato di incontrare persone che chiamassero Europa dei luoghi geograficamente lontani, realmente distanti da ciò che è per noi europei l’Europa. Una volta per esempio, parlando con una rifugiata, mi racconta che suo fratello «è in Europa», le chiedo allora dove e mi risponde – in Sud Corea. Al di là del mio evidente stupore ho capito che per lei Europa era ovunque ci fosse semplicemente più libertà e più benessere. È vero quindi che per chi non ne fa parte, Europa è non è un territorio geograficamente definito ma evoca un’idea di stabilità.
I tuoi protagonisti sono sempre giovani e spesso in antitesi con il contesto in cui si trovano. Pensi che sia peculiare delle nuove generazioni vivere un contrasto con i padri nel tentativo di svincolarsi dalla tradizione? E che ruolo ha in questo il contatto con il mondo occidentale, coi suoi modelli economici e culturali?
Per risponderti devo puntualizzare una cosa. Le società africane o mediorientali sono esattamente sfaccettate e varie quanto lo possono essere le culture occidentali; è in questa differenza che l’elaborazione della tradizione da parte dei giovani punta a un distacco rispetto alle concezioni degli anziani. Queste però sono sempre le ultime a dettare legge perché sono quelle che impostano il sistema culturale in cui i miei personaggi e le persone che ho conosciuto si muovono. Il limite quindi non è un’apertura delle culture non occidentali a un globalismo di massa che cattura i giovani distaccandoli dai vecchi, ma è un processo più lineare e intra-culturale. Quello che mi importa, fuori e dentro il libro, è rendere conto sia delle tendenze ovviamente maggioritarie di un certo tipo di cultura sia per contro delle loro sfumature, dell’ampio spettro di esperienze che non vanno ridotte ad una narrazione semplicistica che è quella che poi appiattisce i rilievi e le diversità, che schiaccia sul cliché le culture e tende ad omologarle per darne una versione monolitica. Questo è ovviamente assurdo perché tanto più si va nello specifico quanto più una cultura rivela, come dicevo, le sue infinitesimali particolarità. Io mi chiedo se non sia possibile, piuttosto, alla luce del processo globale di cui parlavi, tentare di indebolire le identità, spostando il peso su ciò che ci determina realmente. Per quanto riguarda il ruolo intrusivo dell’Occidente penso che all’interno di questo processo di fluidificazione dei confini in realtà l’economia occidentale alla fine manifesti un’altra sua faccia negativa. Il capitalismo infatti cerca costantemente di rimarcare i confini, di sottolineare delle differenze, di alimentare ostilità tra le culture. Non trovo casuale che l’Arabia Saudita, ovvero il paese più fortemente identitario tra quelli del Medio Oriente, sia alleato degli Stati Uniti. E il rimarcare il discorso identitario ovviamente crea problemi, primo tra tutti la mancanza di spirito critico; non c’è niente di illuministico nell’approccio capitalista.
Sullo sviluppo di certe culture nel campo dei diritti io credo poi che i percorsi tra i popoli possano essere autonomi. Può benissimo esserci una persona non esposta all’Occidente che desidera per esempio un matrimonio omosessuale e che magari agirà in quella direzione indipendentemente dalla resistenza che incontrerà nella sua tradizione. L’errore dell’Occidente è rivendicare costantemente la paternità e la diffusione di idee che invece, ho visto, possono perfettamente nascere in seno a popoli e geografie lontanissime e culturalmente autonome. Le conquiste dell’uomo possono darsi in diversi punti del mondo, secondo diverse coordinate, senz’altro dovute all’incontro tra diversità, che è chiave della conoscenza, ma non sotto il copyright dell’Occidente.
Negli ultimi anni alcuni romanzi a tema mediorientale-africano hanno avuto notevole successo, penso a Shukri al-Mabkhout edito da e/o o ancora di più ad Exit West di Hamid. In che rapporto sei con questi autori, con la letteratura di viaggio e quali consideri essere i tuoi modelli?
Il problema di libri come Exit West è scadere nella descrizione di un contesto esotico con dei personaggi che sono sostanzialmente occidentali, avulsi dalla situazione e che con essa, però, lottano. Mi è sembrato un libro un po’ inautentico onestamente, ai limiti del fastidioso, che strizzasse l’occhio a un pubblico di certo non esposto a queste storie, portandogli in buona sostanza uno stereotipo. Non c’è cosa peggiore dei libri con questo tema dove i protagonisti sono “sbiancati”, occidentalizzati. Forse è un pessimo risultato che ha come punto di partenza il nobile tentativo di annullare le differenze (e le distanze), ma così non funziona. Ci sono altri libri con pretese anche meno realistiche che però riescono a modo loro a rendere un contesto in maniera più calzante, penso per esempio alla distopia che è Frankenstein a Baghdad di Ahmed Saadawi (e/o). La mia paura più ovvia era quella di commettere lo stesso errore che imputo a Exit West, ma mi sono sforzato di andare in direzione opposta. Per quanto riguarda poi la letteratura di viaggio, devo dire che mi è sempre sembrata eccessivamente esotizzante. Grazie alla mia esperienza personale ho perso rapidamente questa patina esotica e i posti come l’Iraq o il Burundi sono diventati posti “normali”, da valutare senza alcuna fascinazione, ma secondo un rapporto molto pragmatico. Paradossalmente la letteratura su cui mi sono formato è letteratura che parla di reduci, che è un po’ come mi sono sentito, alla luce di queste esperienze; sono stati fondamentali i racconti bellici di Hemingway, Per Esmé: con amore e squallore di Salinger, Omaggio alla Catalogna di Orwell. Poi, tra le esperienze di immedesimazione in un contesto, come quella di Orwell, ricordo mi colpì un racconto di London, L’agente dell’abisso o i romanzi picareschi di Steinbeck. In generale prediligo una letteratura che esperisce più di una che osserva. Per il resto posso dirti che ho scoperto il racconto leggendo Carver, ma la sua influenza si nota poco, solo a livello di stile.
In che termini quest’attenzione al non occidentalizzare i racconti, a non rendere intrusivo il tuo punto di vista, ha impattato sulla costruzione e sulla resa della prospettiva dei tuoi personaggi?
Secondo me è possibile evitare di ridurre i protagonisti dei racconti a vuoti specchi che riflettono quello che siamo, e la risposta sta nell’incontrarsi dentro le diversità. È compito doveroso riportare le differenze, soprattutto per me che le ho vissute, che mi separano da Khalat o da Theogéne, ma allo stesso tempo rendere una dimensione che sia in grado di essere partecipata, sono io – che ho le coordinate per farlo – che immetto il lettore nella loro prospettiva, ponendolo a contatto con ciò che non sa. D’altro canto ho cercato anche di rendere quella complessa sfaccettatura delle culture di cui i miei protagonisti fanno parte e di cui abbiamo parlato, nonostante tentino di svincolarvisi. Quello che ho tentato di fare è rendere la contraddizione di figure come Khalat che pur non volendosi sposare è costretta a farlo proprio per adattarsi al nuovo contesto di fuga, ma per assecondarlo non ha altri modi che erodere le proprie ambizioni e, paradossalmente, rientrare nella tradizione da cui le sue aspirazioni sognavano di distaccarla. Il libro non vuole raccontare la rottura con le radici, ma la complessità contraddittoria che è l’incontro tra le aspirazioni personali, la tradizione e le circostanze. Questo rapporto impone ai protagonisti di produrre il miglior risultato possibile senza però tradire nessuno di questi elementi e qui sta la loro lotta, nel libro come in vita.
(Davide Coltri, Dov’è casa mia, minimum fax, 2019, pp. 181, euro16)