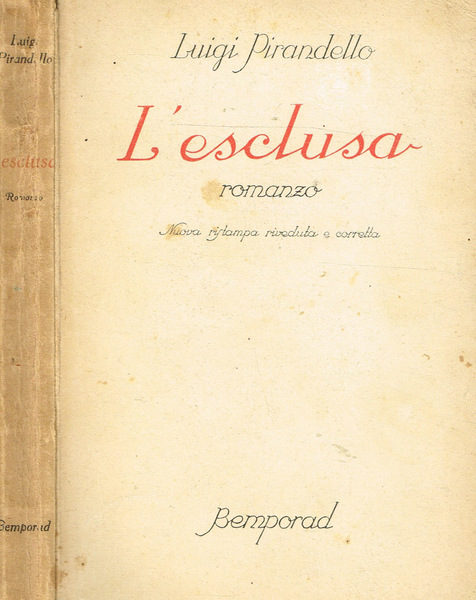Ci sono: un uomo, una donna e un ragazzo, poi ancora il traffico, l’odore di benzina, l’inflazione che puoi quasi annusare nell’aria, gli amici, le auto. Ci sono i vivi e i morti, e una vita da attraversare. Dieci anni più tardi, Harry Angstrom è a capo della Springer Motors, una delle due concessionarie Toyota nell’aria di Brewer. È ricco, finalmente, e le cose questa volta sembrano proprio girare per il verso giusto, in barba all’America, che invece è in sfiducia, pare ingarbugliarsi in se stessa mentre spende soldi che è destinata a perdere. Questo maledetto mondo, pensa Coniglio, sta finendo la benzina, «ma a lui non lo fregano». Magari stavolta il mondo finisce e non fa in tempo a sconfiggerlo ancora.
È interessante notare il progressivo cambiamento di sguardo, da parte di Updike, quando si mettono a confronto gli incipit dei tre volumi: nel primo, il decadimento era tutto di Coniglio, e il mondo intanto sembrava fiorire; nel secondo, il declino di Harry si contrappone all’ascesa statunitense, eppure l’occhio dell’autore sceglie di indugiare soprattutto sulle mancanze di quest’ultima, quasi che il declino del suo personaggio fosse il sintomo, se non la profezia, di uno scontento collettivo prossimo a verificarsi; in Sei ricco, Coniglio (Einaudi Stile Libero, 2014) la situazione è ribaltata: l’America – il mondo intero – fatica e Coniglio si arricchisce. Ci sono state sconfitte e cadute, mentre intanto il mondo ballava sulle note del rock ’n’ roll e guardava se stesso dallo spazio, e adesso è il tempo della rivincita. Sembra essere il tempo della rivincita. Ci sono state, soprattutto, le morti: quelle in scena (la piccola Rebecca, la giovanissima Jill) e quelle fuori dal racconto (Fred, Ma’, Pa’). Bisogna essere grati ai nostri morti, pensa Harry. «La grande verità a proposito dei morti è che lasciano spazio.»
Quando Updike scrisse questo romanzo, agli occhi del mondo – e della sua America – egli era già John Updike, scrittore di talento (erano già usciti Il centauro nel ’63 e Coppie nel ’68), affermato – seppure già un po’ osteggiato – e appunto realizzato. Ma soprattutto Updike era un uomo di mezz’età, proprio come il suo protagonista, e il pensiero della morte e della vecchiaia trova enorme spazio tra queste pagine, come inevitabile. Non ci è dato sapere esattamente quanto dell’uomo Updike sia stato riversato in Harry Angstrom, ma l’impressione è che la foggiatura di questo personaggio sia stato per l’autore quasi catartica e forse in parte consolatoria.
Una delle principali grandezze di questo romanzo sta nel fatto che riesce a essere, allo stesso tempo, il più intimo e il più americano della saga. È molto probabile che sia proprio questo il “grande romanzo americano”, se si considerano quegli elementi che molti autori – nel cinema quanto in letteratura – hanno cercato di mettere assieme per disegnare l’America e il suo sogno, le sue contraddizioni e le sue vanità, le paure, le guerre e le speranze di nascita e rinascita.
È un romanzo innegabilmente (anche) politico. È un romanzo “collettivo” – ma non corale – e insieme talmente personale da sfiorare, in certe parti, la forma di un diario con un’estensione narrativa. La morte è presenza fissa, si annusa nell’aria e si annida nel cuore, si intravede fra le rughe della pelle e si annuncia nella fiacchezza del corpo che decade (a breve si arenerà, come mamma Springer alla fine dell’ultima corsa in macchina) e che attende – non può far altro che attendere: ogni ribellione è un atto individuale d’ingenuità – lo smorzare della luce, la decomposizione, il nulla.
È un romanzo (anche) di fantasmi. Ammoniscono, acuiscono, non smettono di morire. Harry evita gli specchi perché non riflettono più un corpo fulgido, ritrae lo sguardo e pensa «eppure la vita è bella», ed è crudele che questa sia soltanto la conquista dell’età matura, che non si arrivi a questa certezza già da giovani. Adesso lo sa, che la vita è bella, il pensiero non si limita a un sentore o a una speranza, e non si capacita che anche i vecchi possano pensare lo stesso.
Il romanzo è intriso di realtà; non di “semplice” realismo: proprio di realtà. Quant’è opprimente e disordinata, e insieme necessaria e imperdibile, la realtà. Occorre avere una particolare accuratezza, e s’intende talento, per inquadrare il disordine del reale – che è il mondo, che siamo noi – senza risultare disordinati. Updike ce lo aveva – e forse nessuno, in questo senso, ne ha mai avuto di più. Il processo di costruzione della scena sembra essere vissuto – o perlomeno visto – più che immaginato, e le moltissime scene che si susseguono sono poi ricondotte a un tessuto connettivo che si compone dell’anima stessa del protagonista.
La “trama” del romanzo si riduce a pochi passaggi – se non altro, a molti meno rispetto ai due che l’hanno preceduto – trovando forza nel suo intrecciarsi alla storia più ampia, che si regge su un grande punto focale (sostanzialmente, semplicemente: la vita di un uomo). Updike giostra magistralmente il ritmo narrativo – lento, compassato – attraverso un ritmo stilistico che è invece frenetico nella sua eleganza e corre o rallenta insieme ai pensieri e alle suggestioni di Coniglio.
Pur consapevoli di quanto spesso si sia fatto abuso del termine, già dal Novecento in poi, non è errato dire che questo è un romanzo molto proustiano, perché contempla il tempo, lo misura, lo teme, lo subisce e lo attraversa. I salotti dei Guermantes equivalgono alle serate dagli Harrison, il caso Dreyfus alla crisi degli ostaggi statunitensi in Iran, e nel mentre le chiacchiere sono simili, solo ribassate al livello medioborghese. Intanto Harry invecchia consapevolmente e Nelson, suo figlio, si fa uomo. Per la prima volta Updike concede a Nelson l’esclusiva di alcune scene e all’improvviso, quasi senza accorgersene, i pensieri del padre si sospendono in favore di quelli del figlio (che a sua volta sta per diventare padre).
I rapporti umani appaiono straordinariamente sinceri prima che credibili – sinceri perché candidamente imperfetti, ingombranti, sbilanciati, meschini. Gli errori sono imperdonabili, e così gli affetti: non ci si perdona un amore che finisce. Ma c’è troppa vita e poco tempo, e allora anche i rancori si sciolgono (Charlie, che è stato l’amante di sua moglie Janice, è forse l’unico amico di Harry), ma si portano addosso insieme agli anni e agli acciacchi. Non è mica vero, che ciò che non uccide fortifica: ogni colpo subìto ci fa più piccoli.
Updike, prima ancora di Coniglio, è consapevole che il tempo della propria generazione è finito – e a giudicare dai suoi toni, è difficile credere che ne sia stato soddisfatto. Cos’è rimasto del benessere degli anni Sessanta, di quell’entusiasmo galoppante, dei viaggi interstellari e del grande sogno di pace e di speranza? Intendiamoci: il disprezzo crescente di Coniglio è innanzitutto corporeo, un rifiuto all’invecchiamento e al disfacimento della bellezza. Ma, insieme ai corpi, anche le idee sembrano essere invecchiate male – e il peggio è che le prossime non sembrano migliori o più efficienti. Invecchiare non ci rende necessariamente più saggi o più buoni, e Updike, che nel frattempo invecchiava lui stesso, lo sapeva bene. Invecchiare, a volte, ci sporca soltanto – e ci deprime, ci consuma, ci spegne mentre noi vorremmo bruciare ancora. Invecchiare ci peggiora, perché peggiora il corpo – e il corpo è l’unica cosa reale che si vede e che si sente, mentre i pensieri, e così le intenzioni, rimangono oscuri agli altri, e di lì la frustrazione del fraintendimento. Contaminato dal tempo, il corpo di Janice sta perdendo la sensualità di una volta, così l’eccitazione è per Coniglio un’altra ricerca che però non ha la forza – psichica e fisica – di affrontare, e accresce la frustrazione. Il sesso perde quasi completamente la sua funzione ricreativa e si fa solo tentativo di afferrabilità del reale. Invecchiare sembra far capire anche quest’altra cosa: che il sesso c’entra poco con l’amore (e allora le coppie si sciolgono per una notte e lo fanno volentieri, nemmeno per gioco ma per esperienza). Harry ha bramato il corpo giovane non ancora trentenne di Cindy, ma è finito con Thelma che è vecchia e ammalata. In quest’episodio risiede la realtà (ri)costruita da Updike, che racconta la storia di Coniglio esattamente per quello che è: la vita di un uomo che vince e che perde.
Non calca la mano, Updike. Non riempie la storia di tragedia – nessuno muore, la vita questa volta ha vinto – ma la compone di dramma umano, che è involontariamente ironico e bellissimo, crudo e insuperabile. Il mondo sta finendo poco a poco, pensa Coniglio, e i giovani si fanno belli come se la festa fosse appena cominciata. Coniglio sa che sta morendo – come Janice, come tutti – e vorrebbe evitarlo, ma stavolta sa che scappare non si può, e allora gli riesce più facile immaginarsi che il mondo muoia insieme a lui. Nelson scappa, invece, ed è l’altra faccia del mondo, quella che Harry ha respinto ma non ha dimenticato. È stanco di essere giovane, mentre papà e mamma sono stanchi di invecchiare – e allora è la vita, sempre, che ci stanca. E a cosa dobbiamo tutta questa stanchezza? Che cos’ha prodotto?
Harry torna dal viaggio. Ha una casa sua, adesso, tutta per lui e per Janice. Nelson è via ma tornerà. Lui lo sa, non si può scappare per sempre. Pru, sua nuora, ha rischiato di perdere la bambina, ma ce l’ha fatta. Questa volta Dio ha avuto clemenza. È così che funziona, non si muore tutti i giorni. Harry la prende in braccio e sa che quel fagottino lo invecchia terribilmente. Non è più Coniglio, astro nascente della pallacanestro. È Harry Angstrom, marito di Janice Springer, nonno di una bambina. Lo culla fra le braccia, quel futuro che non vedrà. Ecco: la vita produce semplicemente la vita. Ma è già abbastanza, è già moltissimo. Sì, Coniglio, ti sbagliavi. Lo sapevi anche tu, che sbagliavi. Il mondo non finirà con noi – ed è a questo che dobbiamo il compito di lasciarlo più bello di come l’abbiamo trovato.
(John Updike, Sei ricco, Coniglio, trad. di S. Bertola, Einaudi Stile Libero Big, 2014, pp. 600, euro 22)