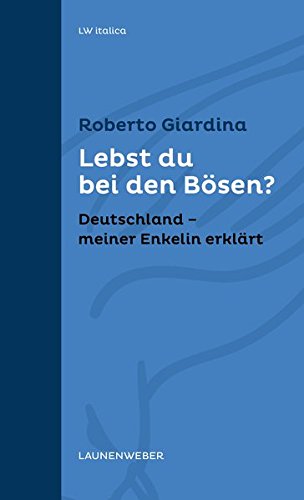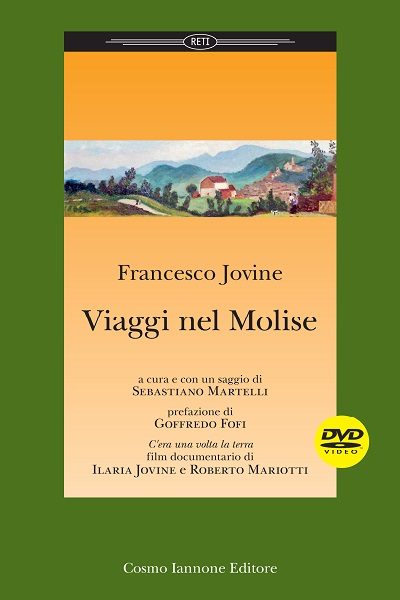«Nel 1985 Lidočka compì cinque anni e la sua vita andò a rotoli. Era la prima volta che si incontravano tanto da vicino, Lidočka e la sua vita, e fu per questo che entrambe fissarono nella mente con un’intensità vertiginosa ogni piccolo, salato, umido dettaglio della loro ultima estate felice». Così recita l’incipit folgorante di Le donne di Lazar’ di Marina Stepnova (Voland, 2018) e la scrittura potente non verrà mai meno nelle più di quattrocento pagine di questo romanzo russo. Attraversa per lungo e per largo il terribile, sanguinario ma anche magnifico ventesimo secolo in cui la Russia prima, e l’Unione Sovietica poi, hanno avuto un ruolo determinante.
Camminiamo nella Storia seguendo le tracce del geniale fisico nucleare di origini ebraiche Lazar’ Lindt nato nel 1900: il suo destino si rispecchia nelle vite di tre donne a lui legate in qualche modo. Tre donne vicine e allo stesso tempo lontane, persino estranee: Marusja, moglie del professore che lo scopre e lo avvia alla carriera di scienziato, una signora trent’anni più grande di Lindt che gli fa da amorevole madre e che lui ama con un amore che va ben al di là di quello filiale; Galina, che sarà costretta a sposarlo giovanissima quando lui è già vecchio; infine Lidočka, la nipote che Lindt non ha mai incontrato. Sono loro le donne del titolo, sono e non sono di Lazar’.
Marusja, la moglie del mentore di Lindt, è la figura cruciale della lunga esistenza di Lazar’. Lei lo accoglie appena diciottenne, fuggito a Mosca dalla provincia probabilmente in seguito a un pogrom, subito dopo la Rivoluzione d’ottobre. Marusja non ha avuto figli e non sperava più di poterne avere, Lindt le regala la maternità che la natura le ha negato e lei lo ricambia con il calore della casa, l’affetto, la bellezza, la cura della sua persona. Marusja è l’icona della donna russa ottocentesca, è sempre prodiga e disponibile, e aiuta donne e bambini privi di mezzi durante la guerra. Lazar’ Lindt cercherà lei in tutte le donne, e per magia Marina Stenova riuscirà a farla rivivere in sua nipote Lidočka.
Galina Petrovna finisce nelle grinfie di Lindt, osannato e onnipotente sessantenne. Con un intrigo la ragazza è catapultata tra le sue braccia da fidanzata di un ragazzo semplice, entrambi senza particolari ambizioni se non quella di realizzare il più banale dei sogni d’amore. Galina è una nuvola rosa, che da un giorno all’altro si trova al centro della nomenklatura, e madre di un bambino che non può amare, perché frutto di una imposizione, di violenza anche se commessa con amore e tenerezza. La ragazza sentimentale diventa un’adulta anaffettiva, dura e calcolatrice, un uccello di paradiso in gabbia. Neppure la nipote di cinque anni, l’orfana di suo figlio, fa breccia nel suo cuore. Non la può abbandonare perché porta il suo stesso cognome, ma se ne prende cura solo con il denaro, che ha in abbondanza.
Perduti i genitori all’età di cinque anni, Lidočka cresce in ambienti elitari disciplinati, colti, ma privi di calore. Può diventare ballerina, ha talento ed è capace di sopportare anche la dura disciplina, ma desidera soltanto affetto, una casa, una famiglia. Tre donne, tre vite, tre periodi storici, un affresco che a tratti ricorda Tolstoj, Nabokov e Ulickaja, ma anche Il dottor Živago di Pasternak.
Le donne di Lazar’ (2011) è il secondo di tre romanzi di Marina Stepnova. Con questo libro si è classificata terza al più prestigioso premio letterario russo – il Bol’šaja kniga – ed è stata finalista fra gli altri ai premi Russkij Booker, Nacional’nyj bestseller e Jasnaja Poljana. Il libro ha ottenuto un ampio consenso di critica, ed è stato tradotto in ventiquattro lingue.
—
Più del recensore, può raccontare e svelare il libro il suo traduttore, perché il traduttore con esso trascorre a volte anche molti mesi e si immerge in quelle profondità che il lettore semplice raramente può o vuole toccare. Ho avuto l’opportunità di porre qualche domanda al traduttore di questo splendido libro, Corrado Piazzetta, e lui ha risposto volentieri, anche a domande che non riguardano strettamente Le donne di Lazar’, ma possono interessare in generale gli amanti della letteratura russa.
Caro Corrado, sapevo della tua passione per la lingua russa, ti conoscevo però soltanto come abilissima voce italiana di Penelope Lively. Il romanzo monumentale della Stepnova metterebbe in difficoltà anche un traduttore molto preparato e di lungo corso, quindi ti faccio i miei complimenti più sinceri. Com’è caduta la scelta di un esordiente, anche se esperto traduttore in un’altra combinazione linguistica, su questo libro che porta in sé tutte le difficoltà che una traduzione editoriale può rappresentare?
Cara Andrea, innanzitutto ti ringrazio molto dei complimenti. Come dici tu, la lingua e la cultura russe sono sempre state una mia grande passione, nata molto tempo fa quando mi imbattei per puro caso in un corso di russo trasmesso da quello che allora si chiamava Terzo canale (la neonata Rai Tre). Sempre in quegli anni è sbocciato anche l’amore per l’altra mia grande passione linguistica, ovvero l’inglese, che come giustamente ricordi è stato per anni la mia principale lingua di lavoro (e ti ringrazio di aver citato Penelope Lively, autrice che ho amato molto). In tutto questo tempo, però, il mio desiderio di lavorare con scrittori russi non si è mai spento (e, a dire il vero, oltre dieci anni fa ho tradotto per Guanda una serie di microracconti di un giovane autore russo poi finito nel dimenticatoio, per non parlare di La mite di Dostoevskij che mi era stata commissionata da una piccolissima casa editrice fallita poco prima che la mia traduzione vedesse la luce). I miei contatti col mondo editoriale, però, erano prevalentemente con case editrici che non lavorano mai o quasi mai col russo, e quindi ho ritenuto che il miglior modo per trovare nuovi canali fosse quello di presentarsi con una proposta inedita. Tutto ciò per dire che quando ho scoperto l’esistenza di Marina Stepnova, e ho visto che i suoi romanzi non erano ancora approdati in Italia, ho pensato che potesse essere un’autrice interessante da proporre. Come primo approccio, ho scelto Ženščiny Lazarja (titolo originale di Le donne di Lazar’) perché dalle poche righe di sinossi mi sembrava una vicenda che mi sarebbe potuta piacere. E così è stato, il libro mi ha convinto fin da subito, sia per la portata della storia, sia per la costruzione dei personaggi, sia per la lingua sontuosa e duttile di cui l’autrice dispone con grande maestria; lo stile della Stepnova mi ha davvero conquistato, la sua ricchezza, la sottile ironia che pervade l’intero racconto, anche nei momenti più tragici. Mi sembrava un’opera capace di incontrare i gusti di un pubblico più ampio del ristretto numero di addetti ai lavori, oltre che una bella sfida dal punto di vista del mio lavoro di traduttore. Queste le ragioni per cui ho deciso di intraprendere il non facile cammino di ricerca del referente giusto: ho dovuto bussare a un po’ di porte e ho incontrato varie difficoltà (i russi, specialmente se contemporanei, hanno vita più ardua in Italia, per varie ragioni – vuoi perché ritenuti, spesso a torto, poco allettanti per i lettori, vuoi perché sono poche le case editrici con editor che conoscono la lingua, e quindi in grado di revisionare adeguatamente le traduzioni), ma alla fine sono approdato a Voland, che all’inizio non avevo preso in considerazione perché non avevo mai avuto modo di collaborarci prima d’allora. Come ben sai, è un editore piccolo, ma molto attento alla qualità e pronto ad accogliere proposte nuove; oltretutto, come suggerisce il nome stesso, da Voland la letteratura russa è la benvenuta, perciò le donne di Lazar’ hanno finalmente potuto trovare la loro casa italiana.
Marina Stepnova utilizza vari registri, fa molti riferimenti culturali e lavora con un lessico particolarmente ricco. Da traduttore, come hai vissuto tutto questo ben di dio?
Come accennavo prima, è stata una bella sfida. La varietà di registri, la generosità con cui la Stepnova attinge al vasto lessico russo, lo stile spesso fiorito, i gergalismi, i numerosi riferimenti a fatti storici o a figure realmente esistite: tutto questo mi ha dato parecchio filo da torcere. Sono infinitamente grato alla rete per la quantità di fonti a cui consente di accedere con pochi clic, risorsa oramai imprescindibile per i traduttori: poter consultare in un attimo dizionari monolingue di ogni tipo, corpus letterari, esempi vivi di fraseologie, di modi di dire; distinguere citazioni letterarie da creazioni originali dell’autrice; verificare l’esattezza dei riferimenti storici (a onore della Stepnova – e, immagino, della sua redazione –, sempre precisi fin nei minimi dettagli). Tutto ciò non solo ha reso un po’ meno arduo il mio lavoro, ma mi ha permesso di migliorare l’accuratezza della traduzione, di ridurre il margine di dubbio e di lasciare meno spazio alle interpretazioni. E sono infinitamente grato alla stessa Stepnova, con cui sono stato in contatto fin da prima di iniziare il lavoro, e che si è sempre dimostrata più che disponibile a venirmi incontro e a rispondere con una rapidità spesso sorprendente alle mie non poche domande. È stata un’esperienza molto bella anche dal punto di vista umano, perché i nostri scambi mi hanno consentito non soltanto di ottenere un risultato di qualità migliore, ma anche di conoscere una bellissima persona, di trasformare un rapporto di lavoro in amicizia. Forse a questo ha contribuito anche la grande passione della Stepnova per l’Italia (lei e il marito hanno una casa in un paesino della Toscana, dove vengono spesso a trascorrere le vacanze, e infatti proprio in occasione di quest’ultime ferie natalizie abbiamo avuto modo di conoscerci finalmente di persona e di organizzare un paio di presentazioni del romanzo) e la sua gioia per il fatto che il Paese da lei tanto amato abbia finalmente deciso di pubblicarla.
Ti sei affezionato a qualcuno dei personaggi del libro, e se sì, a chi e perché?
Tra i personaggi principali, il mio preferito è senza dubbio Galina Petrovna. È un personaggio tragico, una ragazza che viene strappata alla sua vita e ai suoi sogni per ritrovarsi costretta a vivere accanto a un uomo anziano che detesta, rinchiusa in un mondo elitario fatto di privilegi ma di aridità sentimentale, che nemmeno la nascita di un figlio prima, e l’arrivo inaspettato di una nipotina poi, riescono a scalfire. La conosciamo all’inizio del romanzo già donna matura, algida, insensibile, a modo suo spietata, ma nel corso della storia scopriamo gradualmente la sua vicenda e il suo dramma, cosa che dà al personaggio uno spessore tragico, appunto, e ci fa quasi simpatizzare per lei, nonostante la sua alterigia, gli abiti costosi, i gioielli, i profumi, e la coltre di ghiaccio che le soffoca i sentimenti. Tra i personaggi minori, invece, mi sono rimaste nel cuore due coppie: i bambini Isaak ed El’vira/Elečka, che si incontrano da sfollati nella casa di Čaldonov e Marusja durante la Seconda guerra mondiale, e che poi passeranno insieme il resto della vita (fra l’altro, sono gli unici personaggi del libro ispirati a persone reali: i genitori dell’autrice, infatti, si conobbero in circostanze analoghe a quelle di Isaak ed Elečka ed ebbero una vita coniugale altrettanto lunga), e la coppia degli Carёv, i due giovani ricercatori che Lidočka conosce da adulta in quanto abitano nell’appartamento in cui viveva da piccola con i genitori, prima di rimanere orfana e di finire in casa della nonna Galina Petrovna. Di quest’ultimi ho apprezzato particolarmente quel loro incarnare le migliori qualità dell’intelligencija russa, la loro attenzione alla sostanza più che all’apparenza, il loro calore e il loro gioire per le piccole cose quotidiane: tutte qualità che mi hanno fatto riscoprire parte del motivo per cui mi sono innamorato di quel popolo, e che purtroppo trovo sempre meno negli esponenti di quello stesso popolo, con cui talvolta mi capita di avere a che fare in questi ultimi anni.
Un traduttore ha sempre un quadro piuttosto completo della letteratura della lingua dalla quale traduce, quindi è anche una fonte di consigli letterari. Da intenditore, te la sentiresti di indicarci qualcuno fra gli autori e i titoli russi pubblicati in italiano
Quando si parla di autori russi, il riferimento immediato è ai grandi nomi della letteratura classica – e giustamente, aggiungerei: i giganti dell’Ottocento russo, da Puškin a Tolstoj e a Dostoevskij, come pure maestri del Novecento quali Bulgakov o Pasternak o Solženicyn, rimangono figure imprescindibili, e le loro opere dei capisaldi la cui potenza continua ad affascinare ogni generazione (e, a questo proposito, mi permetto di segnalare la nuova traduzione di due fra i capolavori più iconici dell’Ottocento russo, Anna Karenina e Guerra e pace di Tolstoj, ritradotti per Einaudi da due valentissime traduttrici, rispettivamente Claudia Zonghetti ed Emanuela Guercetti, nonché la pubblicazione della versione integrale di Il primo cerchio di Solženicyn, tradotto per Voland dall’ottima Denise Silvestri). Ciò non significa, tuttavia, che la letteratura russa contemporanea non offra nomi e opere di qualità: penso, ad esempio, a Zachar Prilepin, o a Ljudmila Ulickaja, o al premio Nobel Svetlana Aleksievič, o a Vladimir Sorokin. Personalità molto diverse fra loro ma di indubbio valore letterario, e che non sempre da noi riescono ad avere l’attenzione e il riconoscimento che meritano. Spero che il lavoro di noi traduttori e delle case editrici che scelgono di puntare in quella direzione porterà a una sempre maggiore conoscenza dei “nuovi russi” (e uso l’espressione nel suo senso migliore), e spero pure che di questa schiera farà parte anche Marina Stepnova.
Spero che Le donne di Lazar’ sia solo l’inizio di una brillante carriera di traduttore dal russo. Hai già in cantiere qualche novità e qualche titolo che ti piacerebbe tradurre o che ritieni debba comunque essere tradotto in italiano?
Tradurre dal russo, nonostante l’offerta tutt’altro che irrilevante, non è una strada molto agevole, per i motivi di cui si parlava prima. Comunque sì, ho qualcosa di nuovo in ballo, ma le notizie non sono ancora definitive e quindi, per scaramanzia, preferirei non parlarne. In generale, cerco di tenere gli occhi aperti su quello che arriva dalla Russia, in particolare su opere o autori che propongono visioni alternative, o in ogni caso al di fuori dagli schemi più battuti: credo che, in quest’epoca di nuovi conformismi, sia importante mantenere uno sguardo capace di osservare il mondo da punti di vista trasversali, uno sguardo che sappia rendere la realtà nelle sue infinite sfaccettature, magari anche quelle più scomode, quelle che tendono a essere ignorate se non osteggiate dal discorso ufficiale. Recentemente mi sono imbattuto in un’opera alquanto originale, una “autobiografia” di Gesù Cristo a opera di un autore, Oleg Zobern, che unisce erudizione teologica a uno stile dissacrante e ironico, e ci presenta un Cristo profondamente umano, che con i suoi metodi ben poco ortodossi – e talvolta a un passo dalla blasfemia – si avvicina all’essenza del suo messaggio più di quanto non facciano le narrazioni canoniche. Mi ha molto colpito il fatto che un’opera del genere sia stata pubblicata nella Russia di oggi, dove il peso della religione – e soprattutto della Chiesa – è molto più forte che in passato, e perciò mi piacerebbe che questa voce potesse avere un’eco anche al di fuori dai confini patrii. Se non dovesse andare in porto la proposta cui accennavo prima, potrei considerare questa autobiografia sui generis come una possibile proposta da presentare in giro. Staremo a vedere.
Grazie a Corrado Piazzetta per le tante informazioni preziose e non resta che augurare buona lettura, Le donne di Lazar’ non è un capolavoro, di opere perfette o quasi perfette ce ne sono molto poche, ma è sicuramente una lettura di ottimo livello.
(Marina Stepnova, Le donne di Lazar’, trad. di Corrado Piazzetta, Voland, 2018, pp. 448, € 20.00)