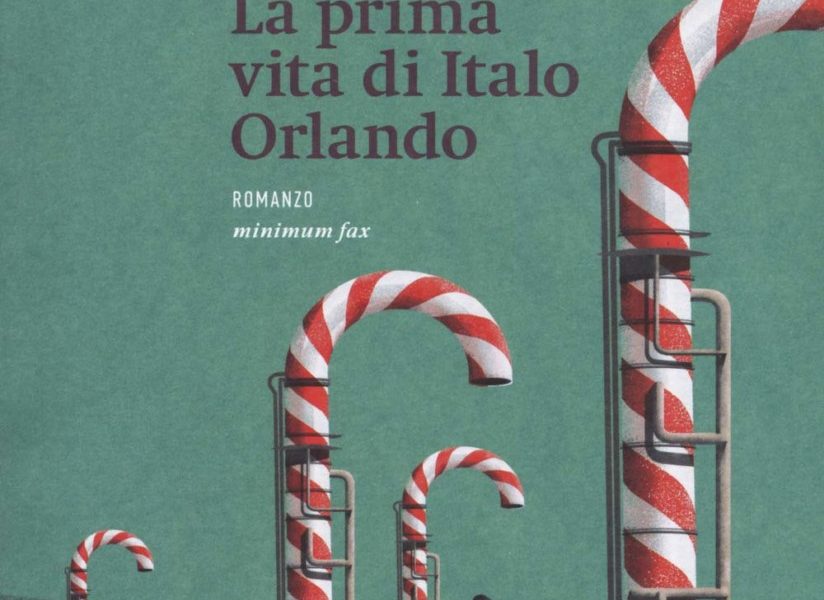Il 6 settembre del 2017 Andrea Pomella esce con un pezzo piuttosto lungo sulla rivista culturale Doppiozero. Il titolo, Storia della mia depressione, è lo stesso del primo capitolo di L’uomo che trema (Einaudi, 2018). Diventato virale dopo la messa in rete, quell’articolo si era ingrandito fino ad assumere le proporzioni di un memoir autobiografico. Storia della mia depressione, però, se a ragione poteva essere il titolo del pezzo su rivista, con più fatica riusciva a racchiudere la sostanza di un libro che era ormai arrivato a trattare una quantità enorme ed eterogenea di temi. L’uomo che trema non racconta la depressione, ma la attraversa per interrogarsi sul senso e sul non senso della vita.
La trama: un uomo di quarant’anni decide di lasciare traccia del suo percorso di autoanalisi in seguito a un brutto episodio di crisi depressiva (trattandosi di un memoir, fatti e persone sono dichiaratamente reali). La compagna lo convince a rivolgersi a uno psichiatra. Tra i vari personaggi che animano la sua quotidianità, ecco dunque comparire un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina, un ansiolitico e un ipnotico simil-benzodiazepinico. Sarà tra le macerie della «guerra chimica» che avviene nel suo organismo che Pomella inserirà, a poco a poco, l’episodio più significativo della sua vita, ossia la separazione senza rimedio dal padre dopo il divorzio dei suoi genitori. «Sono passati quasi quarant’anni dall’ultima volta che ho visto mio padre» è un motivo sufficiente per sospettare che la causa della sua depressione sia da ricercare nei dintorni di quel trauma. Quello che è evidente per alcuni, però, non lo è per altri e il percorso che porterà l’autore a rendersi conto di questo è parte di un viaggio faticoso dentro e fuori di sé.
Lo stile: una serie di parole colpisce durante la lettura dei primi capitoli: “oggettività”, “obiettività”, “logico”, “razionale”. Pomella introduce la sua storia personale con una nettezza e una precisione tipiche del linguaggio scientifico. Le questioni che apre e le conclusioni a cui arriva dopo lunghi giri di argomentazioni sono logicamente inattaccabili e, per questo, parti del discorso di una sofferenza senza dolore emotivo. La depressione induce, infatti, a una disposizione d’animo «bianca», cioè a una condizione di visione dall’alto della propria esperienza che svuota di senso tutte le cose, che esclude il piano connotativo della vita offrendo, chiara, la visione dei contorni del mondo. Per questo “relazioni” è la parola che scardina la sequenza: le richieste di aiuto durante le fasi più intense dei suoi attacchi (la depressione scatena panico, ansia, fobie sociali) si manifestano con un linguaggio che rinuncia ai tecnicismi da manuale di fisiologia e diventa figurato. «Ho il casco», «ho il nano» per dire “ho quello strano cerchio alla testa”, “ho quella sensazione come se avessi un piccolo essere dentro di me che non mi lascia respirare” sono l’altra faccia dei tentativi con cui Pomella gestisce e dà senso alle sfumature della sua depressione, liberandosi dallo sforzo opprimente di argomentare il mondo, più che nominarlo. Questa opposizione tra linguaggio logico/razionale e linguaggio figurato caratterizza tutta la vicenda e assume di volta in volta forme diverse: opposizione tra argomentazione e intuizione, tra realismo e magia, esattezza e imperfezione, solitudine e relazione. È la cifra stilistica di un uomo con due anime, una scissione linguistica che ci comunica questo: sono gli altri che ci salvano, perché è arricchendo il nostro sguardo col loro che il mondo ridiventa opaco, nebbioso, quindi abitabile.
L’uomo che trema non è un libro angosciante, nonostante il tema possa suggerirlo. Tutt’altro. È la storia di un uomo che ha accolto il proprio tremore per intraprendere un percorso di liberazione. Non è un percorso semplice e Pomella fa di tutto per restituirne la fatica delle speranze disattese e dei fallimenti. Noi che leggiamo attraversiamo la sua storia personale in punta di piedi, facciamo il tifo sussurrando frasi di incoraggiamento, riattiviamo, pagina dopo pagina, quel rapporto sacro e virtuoso tra l’autore e il suo pubblico fedele.