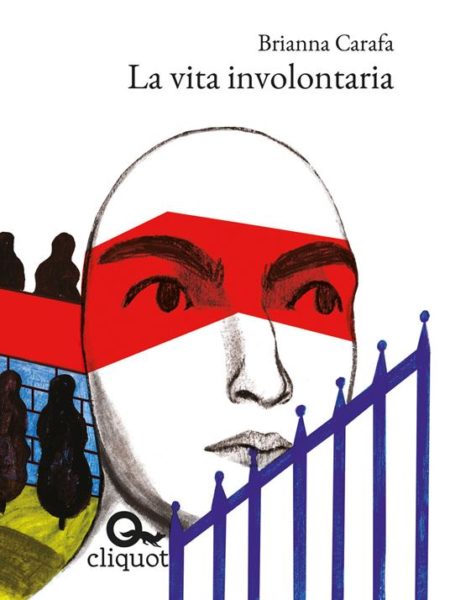Milena Q. Assassina di uomini violenti (Mar dei Sargassi Edizioni, 2022) è una stilettata alla società patriarcale italiana, prima di tutto. Tramite il recupero di un fatto di cronaca nera degli anni Novanta – un’insolita storia di androcidio, ossia l’uccisione sistematica di uomini per ragioni di genere – l’autrice, Elisa Giobbi, racconta un’anomalia di sistema, quella che si verifica quando una donna abusata si ribella.
Siamo nel pavesano. È il 2 agosto del 1998 e nel pomeriggio fa un caldo infernale. Milena Quaglini, quarantuno anni, telefona ai carabinieri di Stradella. «Ho ammazzato mio marito», dice. In casa ci sono anche le sue bambine, che però non hanno visto niente. Mario Fogli, invece, è avvolto in un tappeto sul balcone, senza vita. «Venite a prendermi», dice prima di agganciare. «Sono qui». Così ha inizio la storia di Milena, che Giobbi ci restituisce intervallando il racconto delle memorie della sua protagonista alle perizie e ai documenti ufficiali del caso, recuperati grazie all’aiuto dell’avvocata di Milena, Licia Sardo.
Leggendo questo libro a metà tra la biografia, il reportage e il romanzo, viene in mente una storia che circola in giro, l’aneddoto del professore di filosofia che mostra ai suoi alunni un vaso di vetro. Dopo avervi inserito dei sassi, chiede loro se il vaso sia pieno e quelli dicono di sì. Il professore, allora, ci rovescia sopra dei piselli, sui piselli della sabbia, sulla sabbia del liquido. Sembra esserci sempre spazio. Allo stesso modo la vita di Milena si riempie di dolore. Nata nel 1957 a Mezzanino, in provincia di Pavia, si sente dire in continuazione dal padre è che è «nata storta», frase che prenderà a ripetersi lei stessa ogni volta che le cose si metteranno male nella sua vita. In casa ci sono tre donne, lei, la sorella e la madre. Tutte e tre riempite di «schiaffi, pedate, insulti» dal “padrone di casa”, per giunta costantemente ubriaco, dal quale Milena trova il coraggio di scappare a diciannove anni, consapevole che «un’infanzia infelice è qualcosa che non ti abbandona mai, un rumore di fondo che non si smorza mai». A quel punto, come direbbe Giorgio Caproni, è già stato gettato “il seme del piangere”.
Milena va a vivere tra Como e Lodi, trova lavori saltuari. A un certo punto conosce “l’Enrico”, col quale ha un figlio amatissimo, D. Sono poveri, ma non importa, perché con Enrico arriva un’idea nuova dell’altro sesso, diversa dalla brutalità che la donna ha conosciuto tra le mura domestiche. «Non mi ha mai dato uno schiaffo, lui, soltanto carezze, e non insisteva per fare l’amore se a me non andava. Ma non era debole per questo: un uomo gentile non è mai debole». Tuttavia, quando Enrico muore di un diabete fulminante a pochi anni dal loro matrimonio, Milena cade, precipita rovinosamente nella depressione e nell’alcol, e tutto ciò che troverà da lì in avanti sarà una tragica reiterazione delle violenze della sua infanzia.
L’incontro successivo, infatti, è quello col secondo marito, Mario Fogli, un operaio sulla cinquantina, all’apparenza gentile, che Milena conosce al lavoro. Fogli si rivela presto una copia del padre: picchia, abusa, beve, non vuole che dipinga (passione che accompagna Milena per tutta la vita), soprattutto non vuole che lavori, perché una donna che lavora prima o poi tradisce. Come se non bastasse, quest’essere col quale Milena avrà due figlie detesta D., il figlio avuto con Enrico, tanto da costringerlo ad andarsene di casa. Milena incassa, beve sempre di più per sopportare tutto – il dente rotto, l’udito danneggiato per sempre, le offese –, si lascia trattare come una specie di cosa «buona solo da fottere e bastonare», finché, finalmente, il vaso è colmo. Non ci entra più niente, nemmeno una goccia. Milena allora si sdoppia, si spezza in due, e una delle parti decide che è arrivato il momento di uccidere. Chi uccide, però, non è solo Mario, ma in generale «gli uomini violenti, quelli che picchiano, abusano, umiliano, quelli che usano la loro forza sui più deboli, sulle donne, sui bambini; quelli che ci tolgono la libertà, quelli che vogliono solo fotterci, in tutti i sensi; quelli che credono di aver più diritti solo perché sono nati maschi: il diritto di possederci, di usarci, di abbandonarci, di seguirci, di perseguitarci, di picchiarci se noi femmine non ci comportiamo come vogliono loro, se non ci vestiamo come vogliono loro, se rivolgiamo le nostre attenzioni a qualcun altro, chiunque sia. Ecco, quegli uomini sì, li odio e li ucciderei tutti, perché loro uccidono noi, se li lasciamo, se li tradiamo, se rappresentiamo un ostacolo nella loro vita, e se non lo fanno ci annullano».
Nelle pagine successive emergeranno altri due omicidi, uno precedente e uno successivo all’uccisione di Mario Fogli. Entrambi gli uomini hanno provato a violentarla; uno, Angelo Porrello, che aveva precedenti penali per violenza su minori, secondo quanto dichiarato da Milena c’è riuscito per due volte, prima che lei lo uccidesse.
Milena ormai entra ed esce dal carcere, dalle comunità, dai domiciliari. La sua mente si sfalda un passo alla volta sotto i colpi delle sentenze che le allontanano i figli, degli antidepressivi, della solitudine. Anche in mezzo a questo dolore accecante cerca comunque di difendersi, non si stanca di raccontare le sue ragioni, ma non basta. «Sì, li ho uccisi, sono morti, lì per lì ho avuto la meglio, ma alla fine hanno vinto loro. […] Io ormai sono solo un problema, una vergogna, un’onta per la mia famiglia. Per la società sono solo una scheggia impazzita. Sono sola, come sempre. E da soli non ci si salva». Non si salva, infatti. Il 17 ottobre del 2001, nel carcere femminile di Vigevano dove era in attesa di sentenza per l’assassinio di Angelo Porrello, si toglie la vita. Secondo l’ultima perizia psichiatrica, nonostante le botte e lo stupro, al momento dell’omicidio era in grado di intendere e di volere. Era troppo.
Risulterà forse più evidente, ora, come quella che Elisa Giobbi si è proposta nel momento in cui ha accettato di scrivere la storia di Milena non fosse una sfida semplice. Non c’era da raccontare solo la vita di Milena – cosa che Giobbi riesce a fare magistralmente, restituendo tutta la complessità della mente della sua protagonista, la sua rabbia, la sua sensibilità –, ma un intero sistema che produce e cerca di rendere accettabile una spietata violenza di genere, e c’era da farlo senza mettersi a difendere l’indifendibile, ossia il reato d’omicidio. Di quel sistema, d’altronde, sono vittime sia le donne come la madre di Milena, che chiede alla figlia di voltare la testa mentre il marito fa di lei ciò che vuole, sia uomini come il padre stesso, che utilizza la forza, le botte e il sesso come strumenti di autoaffermazione in una società che lo vuole, appunto, padrone.
All’inizio dicevamo che Milena Q. è una storia di androcidio, ed è vero. Non a caso, al tempo la sua vicenda è stata strumentalizzata per rispondere alle troppe accuse di femminicidio che venivano (e vengono) registrate ogni giorno, il che, per l’appunto, non fa che confermare quanto il male sia sistemico, antico. Basta leggere la sua storia per vedere, anzi per sentire, che se Milena ha ucciso tre uomini, il sistema patriarcale in cui è cresciuta l’ha uccisa decine di volte. La sua “anomalia”, appunto, è stata quella di insorgere. «Nel mondo, almeno in quello che ho conosciuto io, spesso la donna deve essere martire o schiava, l’uomo è padrone e nessuno viene a salvarti. Non ci sto, impazzisco. Tra assassina e vittima io scelgo di uccidere: quella è la mia ribellione».
Alla fine del libro non c’è alcun consiglio, c’è solo una vicenda dura e senza lieto fine; un episodio della storia del nostro paese che forse sarebbe finito nel dimenticatoio senza l’accurato lavoro di ricostruzione di Elisa Giobbi. Giobbi, già autrice di alcuni romanzi, con Milena Q. inaugura L’Anguilla, la collana di narrativa italiana di Mar dei Sargassi Edizioni, neonata casa editrice con sede nel napoletano. L’intento della redazione, che ha alle spalle l’esperienza dell’omonima testata giornalistica nata nel 2016, è proprio quello di dar voce alle storie di confine (sociale, politico, urbano), rendendosi «megafono per le voci e le generazioni che il settore ha tagliato fuori dai salotti intellettuali» e interrogandosi «sull’esperienza dell’essere etichettati dalla cultura dominante sulla base della “differenza” – di genere, di razza, di ceto, di nazionalità, di orientamento sessuale, di religione, di stile di vita».
Non c’è dubbio sul fatto che la vicenda di Milena si inscriva bene in questo proposito, raccontando una storia di violenza di genere da un punto di vista ancora inesplorato e, soprattutto, restituendo la prima persona a Milena, dando voce alle sue ragioni.
(Elisa Giobbi, Milena Q. Assassina di uomini violenti, Mar dei Sargassi Edizioni, 2022, 170 pp., euro 16, 50, articolo di Elena Panzera)