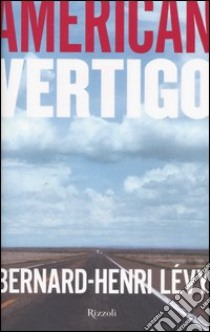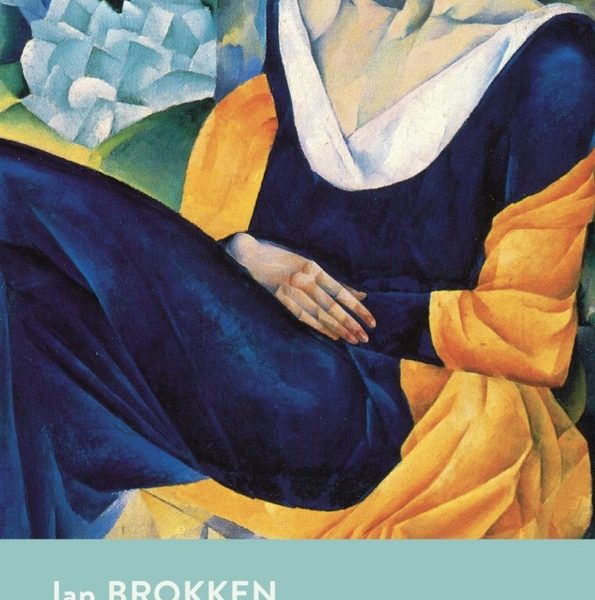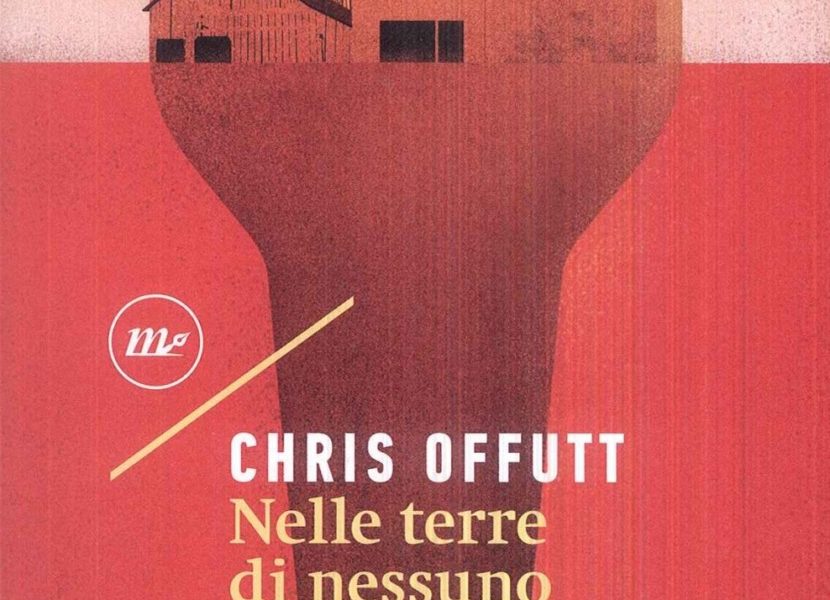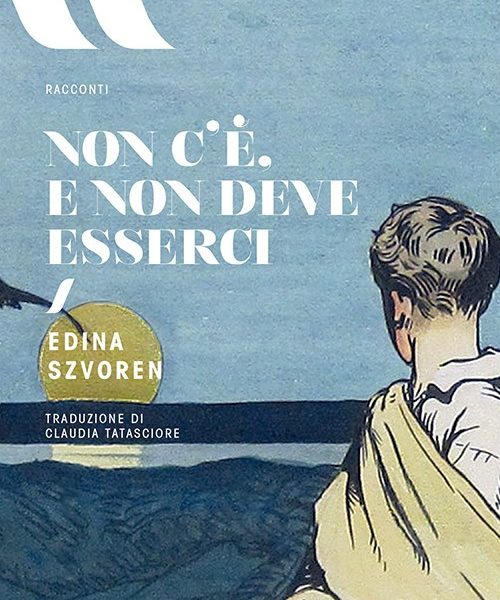C’è qualcosa di emozionante nel ripercorrere la biblioteca di un lettore alla luce del suo essere diventato una delle penne più importanti del nostro Novecento. Tanto più che, a leggere i racconti e i romanzi di Italo Calvino, nulla sembra trasparire del suo scrivere «con molta fatica» – come dirà a Costanzo Costantini in un’intervista del 1982 – perché le sue opere sembrano essere scaturite in maniera spontanea da uno squisito esercizio di lettura.
I libri di Italo Calvino rappresentano un’eccezione tra le biblioteche d’autore da un punto di vista materiale e geografico, dal momento che gli oltre settemila volumi conservati nella sua abitazione romana si presentano ancora come lui li ha lasciati: ordinati in doppie file tra scaffali di legno e di vetro in quasi tutte le stanze della casa e persino sulle scale, secondo un criterio di collocazione in cui era il solo a orientarsi. Una mole di libri che lo scrittore ha costantemente sottoposto a selezione per via dei suoi spostamenti tra le città che ha abitato, ma in cui è difficile distinguere nettamente le letture per diletto, per studio e per mestiere. Una biblioteca che oggi non è aperta al pubblico – a meno che non si trovi il coraggio di citofonare all’interno 6 di piazza Campo Marzio 5, dove il secondo campanello dall’alto a sinistra riporta ancora i nomi Calvino e Singer – ma che si può ricostruire tra le lettere, le interviste, gli scritti in cui l’autore l’ha raccontata.
Per come appare oggi, la biblioteca di Italo Calvino è il frutto dell’accorpamento e della selezione di titoli provenienti dalle sue librerie di Sanremo, Torino e Parigi, approdati a Roma a partire dal 1980. Vi troviamo tracce delle letture dei genitori, Evelina Mameli e Mario Calvino, che comprendono dizionari, testi di botanica, di esoterismo, di magia e rarità scientifiche, nonché romanzi di autori italiani come Deledda, Pirandello, D’Annunzio e Fogazzaro. Lo scaffale di famiglia accoglie anche i libri degli zii materni, Anna e Efisio Mameli, e in particolare la collana Biblioteca Romantica Mondadori, a cui lo zio era abbonato, che sarà per il giovane Italo una fonte preziosa per i suoi primi innamoramenti letterari. Come l’autore ricorderà in uno scritto oggi contenuto nel Meridiano dedicato ai saggi: «Il Gordon Pym di Poe della “Romantica” è stata una delle prime letture impegnative, totali, della mia fanciullezza. Un mio zio era abbonato ai volumi verdi, aveva anzi sottoscritto uno dei primi abbonamenti che davano diritto a ricevere ogni volume con un ex-libris personale; tra i titoli dorati dei dorsi allineati nello scaffale scelsi Gordon Pym e fu un’esperienza tra le più emozionanti della mia vita: emozione fisica, perché certe pagine mi fecero letteralmente paura, ed emozione poetica, come richiamo d’un destino».
È sempre Calvino a indicarci – in due interviste del 1985 con Maria Corti e Sandra Petrignani – il punto di partenza per «tentare la ricostruzione d’una biblioteca “genetica”»: «Ogni elenco credo deva cominciare da Pinocchio che ho sempre considerato un modello di narrazione. […] Se una continuità può essere ravvisata nella mia prima formazione – diciamo tra i sei e i ventitré anni – è quella che va da Pinocchio ad America di Kafka, altro libro decisivo della mia vita, che ho sempre considerato “il romanzo” per eccellenza nella letteratura mondiale del Novecento e forse non solo in quella». Volendo procedere ancora all’indietro, si può risalire alle prime suggestioni visive dei giornalini d’infanzia: «Da bambino leggevo molto il “Corriere dei piccoli” e prima ancora di leggere lo sfogliavo e attraverso le figure mi raccontavo da me stesso delle storie. Facevo variazioni di storie possibili. Credo che quella sia stata una scuola di immaginazione e di logica delle immagini».
La curiosità di Italo trova alimento nella biblioteca scolastica, soprattutto tra i testi di avventura cui sarà legato per tutta la vita, come si legge in Album Calvino: «Il primo vero piacere della lettura d’un vero libro lo provai abbastanza tardi: avevo già dodici o tredici anni, e fu con Kipling, il primo e (soprattutto) il secondo libro della Giungla. […] Da allora in poi avevo qualcosa da cercare nei libri: vedere se si ripeteva quel piacere della lettura provato con Kipling». E se il personaggio alter ego dell’autore nel suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, si chiamerà proprio Kim, non è un caso.
Agli anni di scuola risale l’abitudine di apporre la firma e la data di acquisizione sul frontespizio del libro per indicarne il possesso. Calvino leggeva con la matita in mano, eppure non era solito postillare i suoi libri: si limitava ad annotare sul primo foglio di guardia i numeri delle pagine su cui tornare. Fanno eccezione alcuni testi di studio degli anni Quaranta, in cui le annotazioni sono significative e testimoniano una capacità critica e di analisi già spiccata in un lettore appena ventenne. Sulla sua copia di studio dell’Antologia di Spoon River (un’edizione Einaudi del 1943) Calvino annota così una pagina dedicata a Walter Simmons: «Ecco un vinto. Ma noi non crediamo, come lui in fondo non ci crede, di non aver genio. […] Non bisogna mai credere ai personaggi, in Lee Masters, se si vuol capire l’autore».

Tra i riferimenti dell’adolescenza che diverranno suoi modelli letterari, si incontrano anche molti nomi italiani. Come si legge nelle interviste raccolte in Sono nato in America: «Dovrei indicare qualche libro letto nell’adolescenza e che in seguito abbia fatto sentire il suo influsso sulle cose che ho scritto. Dirò subito: Le confessioni d’un ottuagenario di Ippolito Nievo, l’unico romanzo italiano dell’Ottocento dotato d’un fascino romanzesco paragonabile a quello che si ritrova con tanta abbondanza nelle letterature straniere». Ancora: «I miei primi rovelli letterari – la mia preistoria – si svolsero sotto la boreale stella di Montale, le pagine di Conversazione in Sicilia, mi diedero la prima urgente sollecitazione a scrivere, a Pavese mi legò una sostanziosa, decisiva discepolanza».
Seguendo l’insegnamento di Pavese e Vittorini, Italo Calvino si avvicinerà negli anni Quaranta alla narrativa americana, «che in quell’epoca rappresentava una grossa apertura per l’orizzonte italiano. Per questo, quando ero giovane, la letteratura americana era molto importante e, naturalmente, ho letto tutti i romanzi che allora arrivavano in Italia».
Hemingway, Faulkner, Fitzgerald, ma soprattutto Poe che, già amato da bambino, sarà un modello di scrittura per i suoi racconti: «Oggi, se dovessi dire qual è l’autore che mi ha influenzato di più, non solo in ambito americano, ma in senso assoluto, direi che è Edgar Allan Poe, perché è uno scrittore che, nei limiti del racconto, sa fare di tutto. All’interno del racconto è un autore di possibilità illimitate; e poi mi pare come una figura mitica di eroe della letteratura, di eroe culturale, fondatore di tutti i generi di narrativa che saranno poi sviluppati in seguito. Per questo si possono tracciare delle linee che collegano Poe, per esempio, a Borges, o a Kafka: si possono tracciare delle linee straordinarie che non finiscono mai».
È il 1943. La Resistenza è alle porte, c’è una guerra da vincere, una tesi di laurea in Lettere a cui pensare e una collaborazione con la casa editrice Einaudi da intraprendere. E molti di quegli straordinari intrecci tra le pagine da leggere e quelle da scrivere, nella vita di Italo Calvino si devono ancora dipanare.