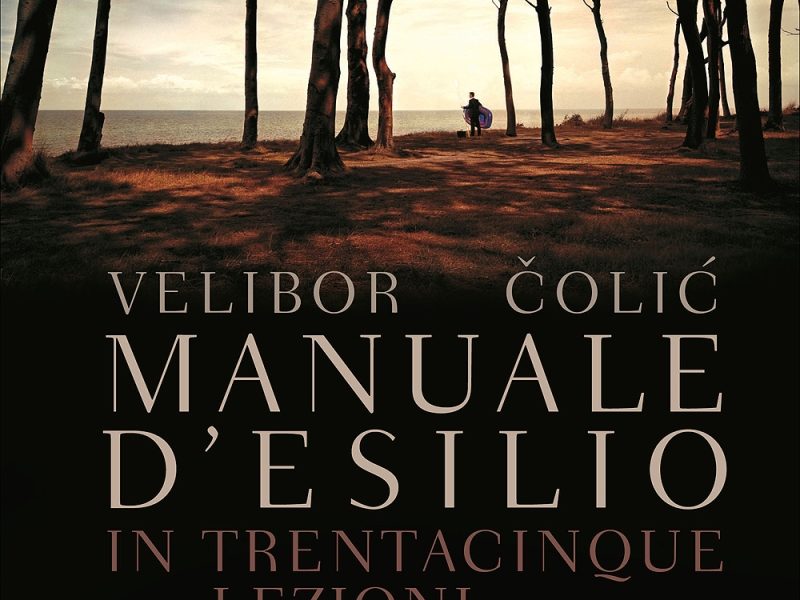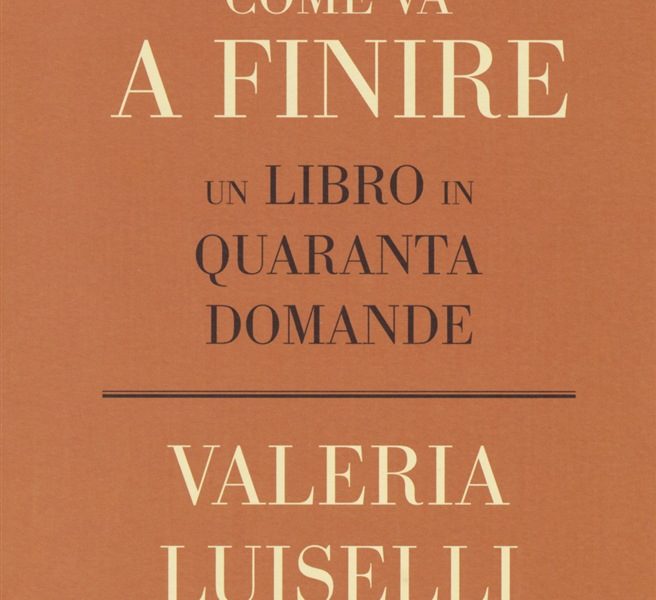Ho cinquantatré anni. Fumo almeno venti sigarette al giorno, non cammino quasi mai, ho una dieta pessima. Non seguo il calcio, non gioco a carte, leggo molto ma non ne parlo con nessuno. Ho un lavoro importante, poco tempo, bevo spesso. Mi addormento alle tre, a volte anche alle quattro di notte e mi sveglio presto. Ho tradito quasi sempre e non l’ho mai detto. Sono un bugiardo, sono un codardo. Mia moglie mi conosce bene, conosce ogni cosa e mi odia. Siamo sposati da ventisette anni.
In tutto questo tempo non abbiamo trovato il coraggio di mettere al mondo un figlio. Un giorno come tanti dei miei, proprio oggi, ho deciso di lasciarla. Non so perché proprio adesso e non ci ho pensato troppo ma è la decisione che ho preso quindi la rispetterò. Arriverò a casa stasera e le dirò che il nostro matrimonio è finito, discuteremo e avrò alcune risposte da dare ma nessuna spiegazione. Forse piangerà e io resterò in silenzio.
«Quando ha sentito per la prima volta il desiderio di abbandonare sua moglie?» mi ha chiesto l’analista.
«Stamattina» ho risposto.
L’analista me l’aveva suggerito B. tempo fa, quando provai a combattere l’insonnia con l’eroina. Feci lo sbaglio di confrontarmi con lui e mi trovai nel mezzo di un dramma sfiorato. B. mi disse che sarebbe stata una tragedia, un fatto devastante. Lo avrebbe detto ai miei genitori ma i miei genitori già a quei tempi mi parlavano raramente. Anche adesso ci sentiamo ogni tanto per conoscere il reciproco stato di salute, parliamo del clima e delle vicende di paese e loro non sanno che non riesco a dormire, non conoscono l’eroina oggi e non la conoscevano allora. Ma B. li avrebbe informati, diceva che lo avrebbe detto a chi mi voleva bene.
«Perché proprio adesso?» mi ha domandato quindi l’analista.
Tutto quello che mi viene in mente è una risposta sciocca, da quell’uomo stupido che temo proprio di essere diventato.
«Mi sono annoiato».
Mancano solo trenta minuti e presto sarò fuori da questo inferno sotto vuoto. Anna sarà a casa, domani è sabato e nessuno di noi due lavora, avremo tempo per discutere e dormire.
«Per oggi abbiamo terminato, le consiglio di parlare con sua moglie e di dormire almeno qualche ora prima di prendere qualsiasi decisione. È l’unica cosa che mi sento di suggerirle adesso. Può tornare da me lunedì pomeriggio e a quel punto discuteremo di ciò che è successo dopo la sua confessione. Non abbiamo abbastanza materiale per il momento».
Mi sento vuoto come la stanza nella quale mi trovo, che per altri sarebbe colma di ispirazione ed energia ma a me sembra una bolla d’aria priva di gravità. Non succede niente, non ci sono rumori, non sento nemmeno il mio respiro.
«La ringrazio molto e ci vediamo lunedì».
Esco di scena senza emettere alcun rumore. Pago alla segretaria i centoventi euro e non chiedo lo sconto che mi spetterebbe, visto che l’analista ha interrotto la seduta con almeno quindici minuti di anticipo. Me ne vado a casa dopo avere acquistato una bottiglia di rosso. Arrivo intorno alle diciotto e trenta. Anna mi raggiungerà tra poco. Siedo in cucina con la bottiglia di Brunello: una volta compravo vini costosi per lei, è il primo pensiero che mi passa per la testa. Penso a quando ci ubriacavamo ed eravamo felici di essere incoscienti. Per questo non abbiamo mai avuto figli, per essere felici per sempre.
Ci siamo conosciuti nei nostri vent’anni. Anna lavorava al bar in paese dove servivano vino e bruschette, nient’altro, nemmeno il caffè. Mi innamorai di lei dopo alcuni giorni che la vedevo dietro al bancone, aveva l’aria serena ma non troppo. Mi trasmetteva pace, ma non troppa. Aveva un bellissimo sedere, ma non troppo. Presto mi resi conto di desiderarla per le cose del quale era in difetto: quella pace incompleta, la serenità imperfetta e il sedere appena accennato. C’era qualcosa in lei che mi faceva sentire vulnerabile, sconfitto, debole e affranto. Mi faceva stare male e bene al tempo stesso, ne ero spaventato e ossessionato, come schiavo di una malattia. Le chiesi di bere con me una sera e finimmo a letto quella notte stessa. Mi sentii sollevato dopo la prima penetrazione, come avessi conquistato l’aria o la luce o qualcosa di vitale.
Non che andarci a letto mi rese più sicuro: nei giorni a seguire continuai a farle visita al bar e mi sembrava di essere sempre più sciocco e inopportuno. Il sesso ci tenne uniti per mesi senza mai costringerci a parlare di altro. Non avevamo nulla da dire sulla vita, su tutto ciò che esiste al di fuori di un bar o di un letto. Anna era molto bella e io molto stronzo. Avevo altre storie ma a lei non interessava, sapeva che mi avrebbe spezzato il cuore se si fosse allontanata da me e questo la faceva sentire speciale. Aveva ragione. L’amore per me fu quasi immediato, nonostante le altre donne e le altre distrazioni. Per me quel letto e quei silenzi significavano speranza, mi nutrivo di ogni sapore di donna e il suo era il più denso e potente. Provavo pena per me stesso ogni volta che la vedevo andare via, mi faceva sentire uno scemo. Lo specchio rifletteva un corpo di muscoli, grasso e testosterone utili a un bel niente quando lei usciva di scena. Come un cane senza padrone, una casa vuota, un dio onnipotente senza nulla da fare. Ma Anna non si pronunciava. Si lasciava amare e tradire, si spogliava e si rivestiva ogni volta come fosse l’ultimo incontro. A volte mancavano i baci e non mi accorsi davvero del suo amore fino al giorno in cui le chiesi di sposarmi. Lavoravo molto, uno di quei lavori sicuri che danno modo alle persone di sentirsi coraggiose malgrado non abbiano mai fatto nulla di esilarante. Dirigente aziendale, diceva il mio biglietto da visita e il mio orgoglio velato. Pensai di potermi permettere una moglie e dei figli e così le chiesi di stare con me per sempre. Le altre donne mi avrebbero stancato, prima o poi. Anna disse che quella era già una relazione vera, che un pezzo di carta e un anello al dito non l’avrebbe resa più mia di quanto già non lo fosse. La convinsi dicendole che avremmo avuto una serie di agevolazioni economiche, che non si trattava di un contratto sentimentale bensì di una mossa strategica per raggirare il sistema. Convinsi anche me stesso che quella vita sarebbe stata la cosa migliore: una scelta consapevole è sempre la scelta migliore, molto meglio di una svolta di fortuna che accade per sbaglio, molto meglio un dramma cosciente che una pace involontaria. Ci sposammo in inverno, poche persone che grazie al cielo portarono un leggero entusiasmo perché noi, per nostra natura, non ne avevamo. Eravamo un uomo e una donna che stringevano i nodi di un patto.
Ma io l’amavo da morire. Lei mi amava da morire. Le dicevo che era un miracolo, che l’universo l’aveva messa al mondo in maniera quasi divina. Non sapevo molto della sua famiglia e questo mi faceva credere che fosse piovuta dal cielo. Occhi vitrei belli da non essere veri, quasi di natura aliena, senza vita come le pupille bianche di una statua marmorea. E mi sentivo un cane. Lei era il mio padrone e io a guardarla uscire ed entrare dalla porta. Le altre donne sì, mi avrebbero stancato prima o poi. Tutti quei corpi bianchi e fradici di sesso bestiale. In fondo ero un cane, questo legittimava il degrado dell’anima e Anna lo sapeva, sapeva tutto. Un giorno, tornato tardi dal lavoro, finita la cena le dissi che sarei dovuto uscire di nuovo per parlare con un cliente importante, un tizio dalla Cina che poteva incontrarmi solo quella sera. Anna, sorridendo, disse che mi avrebbe aspettato a letto e che una volta tornato avremmo fatto l’amore per tutta la notte. Non un invito ma una sordida strategia, lo sapevamo entrambi. A volte funzionava, altre volte non pensavo a nulla e tutto quello che doveva accadere accadeva. Gli odori si mischiavano, le lunghe giornate e il sudore, quel denso sapore di una donna diversa, la cena calda e l’aria bagnata sui sedili della macchina. Siamo andati avanti così per anni. Anna è rimasta bella, silenziosa, affascinante e perfida nel suo tenermi prigioniero dei miei stessi vizi. Io sono diventato un cane vecchio, un corpo logorato. E stasera tutto finisce. È arrivata, sento la porta che sbatte e le chiavi che cadono nel mettitutto. Il cane che sono diventato resta immobile con la testa bassa, la coda tra le gambe e un lamento in gola.
«Cosa ci fai a casa così presto?»
Mi aspettavo la domanda, eppure la risposta non arriva. Anna mi raggiunge alle spalle e accarezzandomi la nuca infila la mano gelida sotto al maglione. Mi giro all’improvviso e guardo i suoi occhi fieri e muti: il giudizio universale ci dorme dentro, tutto il mondo, l’universo, il peccato e la salvezza sono raccolti in quei minuscoli puntini neri che mi osservano dall’alto. Penso al sesso, il suo corpo di giovane donna e quell’odore di madre che mai era sbocciato. Mi alzo dalla sedia e le prendo il viso tra le mani. Da molto tempo non le toccavo il volto, l’amore tra di noi è diventato un gesto muto che non prede forma se non nei pensieri, miseri e sporadici. La sua mano stasera mi tocca la schiena, le mie stasera l’afferrano. Mi ha preceduto, sconvolge il mio piano e mi sento un assassino in preda alle emozioni di umana compassione. Perché mi tocca? Perché stasera? Ho ancora il suo visto tra le mani.
«Anna, devo dirti una cosa».
Continua a fissarmi e perdo l’equilibrio, torno a sedermi trascinandomi addosso i suoi capelli, li stringo così forte da farle male.
«Ho deciso di lasciarti. Non riesco a prendere una decisione diversa da questa, mi conosci, sai che non sono bravo a parlare. Non sono bravo a fare niente. Non ho più nulla da dirti e vorrei solo che tu lo accettassi».
Sono passati più di ventisette anni dalla prima volta in cui l’ho vista. Che il tempo fosse solo un lungo inverno me l’ero immaginato, ma mai come adesso lo sento piovermi addosso con tutte le ore, i minuti, i giorni e le settimane fradice di baci e silenzi, lo sento scavarmi la faccia e torturarmi con devota cattiveria. Il tempo mi ha rubato il tempo. La vita mi ha tolto la vita. Anna ha ancora una smorfia di dolore sulla bocca ma i capelli adesso le sono tornati sulle spalle e li sistema dietro il collo.
«Non ho mai sperato di restarti accanto per tutto questo tempo, non sono sorpresa. Mi chiedo solo perché proprio adesso, siamo vecchi e stanchi di noi. Non vedi che non ci resta nient’altro da fare?»
Di nuovo la sua insolente, affascinante leggerezza. Resto seduto sperando di sciogliermi all’improvviso, o di vederla andare via, come quando eravamo giovani e spariva dietro la porta un attimo dopo avere chiuso le gambe.
«Anna io non ti amo più, e questo è tutto».
Mi vengono in mente B. e l’analista, e tutto ciò che mi aspetta d’ora in poi. Dovrò imparare a non vergognarmi della solitudine ma le altre donne mi faranno sentire ancora più solo. È finita ma Anna continua a fissarmi e adesso mi parla.
«Questa è la vita per te, un buco dove infilarti e godere a occhi chiusi, lo hai sempre fatto. Cosa è cambiato adesso? Resta a occhi chiusi, resta e basta. Ci possiamo odiare lo stesso, non lo sai com’è la solitudine?»
Mi confonde da sempre. Dove si nasconde il suo amore? Negli occhi di pietra macchiati da un minuscolo universo nero. Nel suo ventre intatto che io solo ho violato. Nel suo sonno che assomiglia alla morte, nella noncuranza che mi ha tenuto in vita. Il suo miracolo esiste anche in questo momento, adesso che mi ferisce e mi nutre di rabbia.
«Pensi che io ti ami? Non so nemmeno cosa voglia dire, sei uno sciocco. Mi fa persino schifo la tua faccia ormai, ma non voglio vederti andare via per nessun motivo al mondo. Cosa pensi di fare da qui in avanti, vecchio?»
Gli anni si fanno sempre più piccoli, ogni parola è un trito informe di tutto il nostro passato, e non riesco a riconoscere nulla. Cerco di aggrapparmi a un ricordo che mi renda cosciente di quello che sta accadendo ma non trovo nulla in quella matassa di giorni vomitati a terra. Siamo arrivati qua rapidamente o sono stato io a spingere sull’acceleratore? Siamo arrivati qua fin troppo presto e la solitudine ci spaventa entrambi. Ma perché Anna ha paura? Non ha mai avuto paura di avermi e nemmeno di perdermi.
«Non siamo pronti per la solitudine, Anna… ma non ha importanza».
I capelli che stringevo fino a poco fa si aprono in un ventaglio morbido e terrificante, Anna scuote la testa da una parte all’altra, resta in silenzio e si chiude il viso tra le mani. Vorrei vederla andare via adesso, come ha sempre fatto. Si volta ma immediatamente mi affronta di nuovo, la bottiglia di rosso vola in mezzo alla stanza e l’aria sembra sanguinare. Vedo il fondo verde avvicinarsi dritto in mezzo alla fronte e un colpo, freddo, mi raggiunge nel giro di pochi instanti.
Ora sono a terra, tra il vino e il sangue, la fronte è aperta, riesco a sentire l’aria dentro la ferita e il dolore che inizia a fare effetto. Anna è in piedi davanti a me e mi spaventa, magari mi ucciderà. In fondo me lo merito, e lei si merita una colpa più grande della mia. Comunque resto a terra mentre mi fissa: aspetto la mia fine, una qualsiasi. Il cane che sono diventato giace sul pavimento mentre una lieve pozza di sangue si forma in mezzo alle gambe aperte. Tiro fuori una sigaretta dalla tasca, mi chiedo se sarà l’ultima prima che il giudizio universale cali all’improvviso su di me. Anna non ha ancora fatto un passo. Poi, fissandomi dritto in faccia, alternando lo sguardo tra i miei occhi e lo squarcio in mezzo alla fronte, si avvicina e si accascia al mio fianco. Siamo due nemici solidali nella guerra più lunga del mondo. Un cane e il suo padrone.
Non so per quanto resterà ancora, e lentamente scompare il dolore, così come il disperato bisogno di vederla andare via. Ma resto aggrappato a questa speranza. Mentre mi stringe la mano rossa poggia la testa sulla mia spalla e finalmente sussurra qualcosa.
«Mi dispiace sai, adesso che non abbiamo più nulla da bere».

Illustrazione di NaMà.
“Vita da cane” di Benedetta Bendinelli è tratto dalla raccolta di racconti Odi. Quindici declinazioni di un sentimento, curata da Gabriele Merlini e pubblicata da Effequ.
Benedetta Bendinelli è nata a Lucca nel 1985. Ha pubblicato sulla rivista Streetbook Magazine e sul blog Vai A Quel Paese: Go Face Yourself, progetto dell’Associazione Cultural-Editoriale ThreeFaces che si dedica alla narrativa di viaggio. Nel 2016 è uscito L’uomo che Misura le Ombre per la rubrica Racconti d’Europa del Corriere Fiorentino – Corriere della Sera, mentre nel 2017 ha pubblicato L’Unico Posto al Mondo – The Only Place on Earth all’interno del testo The Ground Tour Project (Universität für angewandte Kunst).
Odi. Quindici declinazioni di un sentimento: Quanti modi ci sono di odiare? Con quanti nomi si chiama l’odio, quanto ci serve, quanto se ne vede e quanto se ne subisce? È ormai chiaro che il sentimento che più di tutti si affaccia nel nostro tempo è proprio questo, l’odio: negli sfoghi sui social, nei muri che si alzano o si vogliono alzare, nel rifiuto dello straniero, nella furia delle tifoserie, nelle difficoltà relazionali che degenerano e in innumerevoli altre forme, più sottili o più evidenti. È quindi il caso di raccontarlo, questo sentimento, e di farlo con la voce di coloro che si sforzano di tracciare al meglio quello che viene detto il contemporaneo. Ecco dunque quindici giovani autori che, ciascuno con percorsi differenti, si stanno affermando nel variopinto spazio narrativo italiano, chiamati a cimentarsi intorno al tema dell’odio, parlando di contrapposizioni, di crisi, di rancori e ancora oltre. Il tutto trattato con gli stili più disparati e più consoni ai singoli, dalla distopia al reportage, dal serioso al dissacratorio, dall’aulico alla farsa, e così via, per completare quindici storie, quindici facce di un sentimento che sembra proprio rappresentarci, ora, all’inizio di questo millennio.