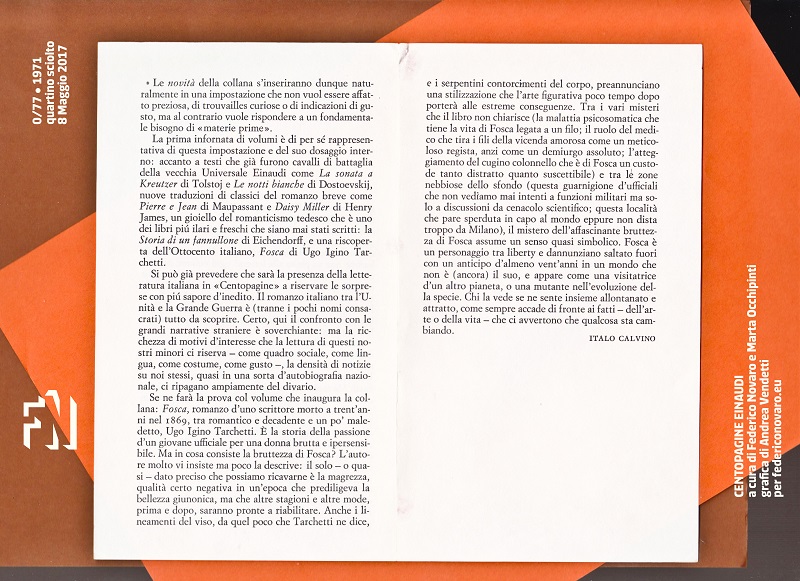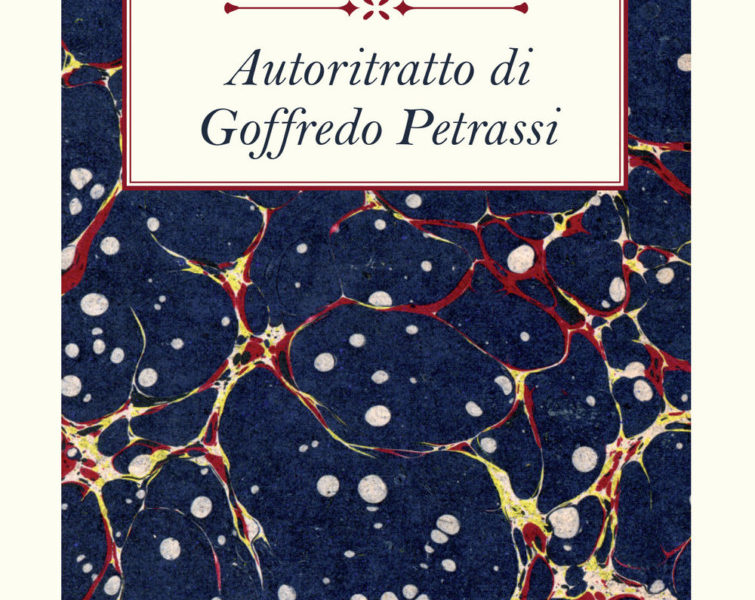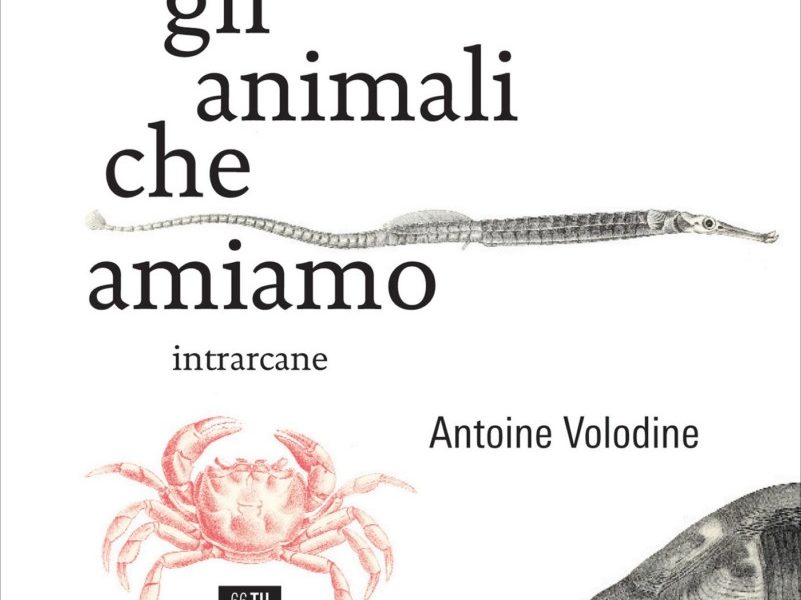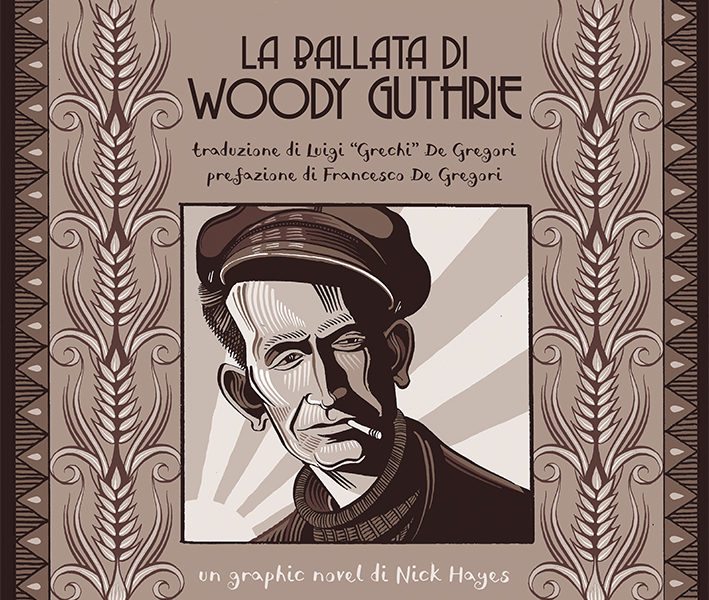«Centopagine è una nuova collezione Einaudi di grandi narratori d’ogni tempo e d’ogni paese, presentati non nelle loro opere monumentali, non nei romanzi di vasto impianto, ma in testi che appartengono a un genere non meno illustre e nient’affatto minore: il “romanzo breve” o il “racconto lungo”». Così scrive Italo Calvino nell’introduzione alla collana da lui ideata e diretta tra il 1971 e il 1985.
Due tappe a Torino, tra ottobre e novembre nello spazio espositivo di via Baretti 31, poi una a Roma nella biblioteca Moby Dick il 9 dicembre scorso. È stato possibile vedere in queste città, solo per un giorno, “FN mostra Centopagine”, un’esposizione-evento dedicata alla collana di Einaudi. Il progetto legato alla mostra è nato all’interno dell’iniziativa di digitalizzazione di materiale editoriale portata avanti sul sito FN dove Federico Novaro, Marta Occhipinti e Andrea Vendetti stanno riunendo i 77 volumi della collana anche con l’intento di proporre una considerazione sul rapporto tra editoria e letteratura, e sul ruolo del Calvino editore.
Scrivono su FN: «Centopagine è una collana breve e rada, sta tutta in un borsone del supermercato; i suoi volumi si trovano abbastanza con facilità sul mercato dell’usato». Si tratta di oggetti non pregiati che, raccolti e mostrati insieme, delineano un percorso che si sviluppa intorno alla costruzione della narrazione visiva dell’involucro editoriale e del suo contenuto, diventando così un evento interessante a diversi livelli. E prima di tutto si tratta di una nuova riflessione su Calvino, un altro tassello che consente di definire meglio la figura professionale dell’autore all’interno di Einaudi. Il Calvino che, nel ruolo di direttore e progettista della collana, dipana la sua idea di letteratura attraverso i volumi, concentrandosi sull’Ottocento con qualche incursione nel Novecento e alcuni titoli tra il Cinquecento e il Settecento, affidando alle note introduttive e alle nuove traduzioni rimandi e allusioni alla letteratura contemporanea.
Riguardo l’aspetto estetico, cioè alla funzione espositiva dell’oggetto-libro, vediamo in mostra le copertine di Bruno Munari, che ne ha curato la grafica fino al 1976 (sostituito da Max Huber tra 1976 e il 1980) e che riprese in mano il progetto negli ultimi anni della collana. Ne viene fuori un’evidente relazione tra il progetto grafico e la visione di Calvino della letteratura, legata alla sua curiosità per le teorie scientifiche, per la geometria spaziale. La grafica di Munari si basa, infatti, sull’uso di forme geometriche sempre nuove realizzate come delle greche ininterrotte che, attraverso le forme intrecciate, guidano come in un labirinto il lettore.
Ho incontrato virtualmente i curatori della mostra e ideatori del progetto, che hanno risposto ad alcune mie curiosità. È diventata una lunga e piacevole conversazione sul passato e sul futuro dell’editoria, sui progetti del sito FN e sugli esiti delle loro iniziative, in bilico tra il recupero e la voglia di confrontarsi.
Ho letto che Calvino era molto entusiasta di questa collana. Su FN avete riportato un ricordo di Bollati: «Ricordo di averlo visto veramente appassionarsi una sola volta a un progetto editoriale che implicava direzione, organizzazione, serietà: quello della collana Centopagine». Perché Calvino era così preso da questo progetto, che apparentemente sembra meno ambizioso e complesso di altri?
MARTA Centopagine nasce e muore con Calvino. Ed è in questa collana in cui si ritrovano i richiami più chiari alla sua idea di letteratura: quella postmoderna e fantascientifica, che coincide con il periodo della sua ideazione. Fu come un esperimento di fiducia verso i suoi lettori, pensato nei minimi dettagli, dagli autori scelti alla cura di quarte e introduzioni. Fu l’unica collana che ideò e diresse personalmente, con una responsabilità pari a quella dei suoi maestri, Vittorini con I Gettoni e Pavese con I coralli. Si può, dunque, pensare che la collana sia stata un suo strumento editoriale per ragionare sulla letteratura, attraverso autori del passato, e strumento letterario per l’editoria. In particolare quella einaudiana, che negli anni Settanta iniziava a sperimentare in ritardo una “tascabilizzazione” con testi rivolti a lettori medio-alti.
Perché avete scelto, per la mostra, Centopagine e non un’altra delle collane analizzate su FN. L’avete definita un unicum in quel particolare momento storico. In che senso? Qual è la sua particolarità?
FEDERICO: Centopagine è la terza mostra di FN, dopo quella su Roland Barthes e Futureworld. Centopagine però offre più cose insieme. Da una parte è una collana ancora viva nella memoria di chi leggeva quei libri, dall’altra ha due nomi che da soli bastano a catalizzare l’attenzione: Calvino e Munari, e questa cosa rende tutto molto più semplice e più accattivante. Fare la stessa cosa con una collana come Prosa contemporanea di Guanda, che è stato un progetto precedente a cura di Mauro Maraschi, sarebbe stato molto più complicato, perché la casa editrice è poco conosciuta, il progetto grafico è un po’ anonimo e noioso nella sua ripetitività. Sarebbe bello farlo un giorno, ma magari affiancandola ad altre cose.
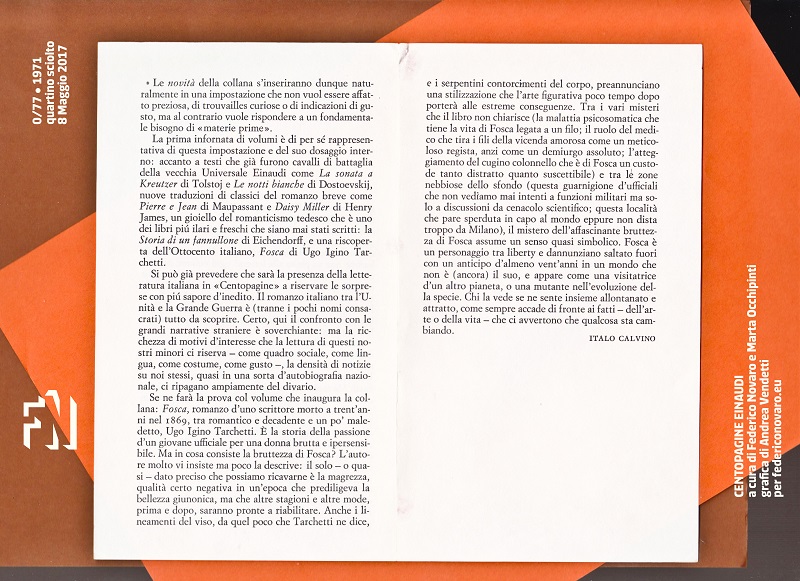
Il progetto di FN, non solo per questa collana, è orientato a fornire una descrizione del libro in ogni sua parte nella sua duplice essenza di oggetto e contenitore, con la mostra, però, avete in qualche modo superato la quarta parete. Pensate che internet da solo non basti, che sia ancora necessario uscire, toccare i libri e che funzione attribuisci a questo evento?
FEDERICO: No, non si può dire che internet non basti. FN cerca di trovare dei modi e uno statuto per portare in rete la materialità dei libri e questo, quindi, è un movimento che parte dal tangibile e arriva al virtuale, ma mi piace l’idea che poi esista un movimento contrario. La mostra, senza ciò che facciamo in rete, avrebbe un senso relativo, le due cose si completano. Poi c’è da dire anche che FN è in rete, ma non è un fenomeno puramente social, invece, è decisamente “social” la mostra. In definitiva, sono due cose differenti, che coesistono e si completano.
ANDREA: Federico ha ragione, c’è da considerare il fatto che FN ha una forte vocazione archivistica e l’archivio non ha una fruibilità immediata, ma bisogna avere qualcosa da cercare. La mostra è invece proprio un hic et nunc, è infatti un evento che dura solo un giorno. Potrà capitare in futuro che i libri saranno esposti più di qualche giorno, secondo le esigenze di chi chiederà la mostra, ma in generale è una cosa estemporanea.
MARTA: Sono pienamente d’accordo con Federico e Andrea. Su FN abbiamo iniziato un importante lavoro di ricostruzione storica ed editoriale dei testi a servizio di appassionati e soprattutto studiosi. Tuttavia, senza il reperimento materiale dei libri tutto ciò non sarebbe stato possibile. La rete ci permette di raggiungere un pubblico più vasto, ma il nostro obiettivo è quello di sfruttare internet per trasmettere un messaggio di ritorno alla cura e alla lettura degli elementi materiali dei libri.
La mostra ha anche una valenza educativa, non solo documentaria?
FEDERICO: Credo piuttosto che la mostra sia un evento mondano, nel senso migliore del termine, si parla di libri, si beve del vino e si creano relazioni. È più vero quindi il contrario, cioè è il lavoro che facciamo in rete che è pedagogico. Certo, il vantaggio della mostra è che è possibile vedere tutti i libri insieme in un solo colpo d’occhio, questo aggiunge molto e ne fa un’esperienza.
ANDREA: Con FN cerchiamo di restituire il più possibile la fisicità del libro in rete. Anche le foto che facciamo non hanno alcuna post-produzione e se su una copertina c’è un prezzo stampato su un’etichetta non la eliminiamo. Le imperfezioni rendono il libro più reale, concreto.
FEDERICO: è il motivo per cui le fotografie sono tutte datate.
MARTA: Come dicevo prima è un lavoro diretto soprattutto agli studiosi. Quando mi sono ritrovata a preparare la mia tesi di laurea, un anno fa, oltre al reperimento di letteratura sull’argomento “editoria”, è stato utile lavorare insieme a Federico su una collezione, sfogliandone i testi. Così si finisce per scoprire sempre qualcosa di nuovo. Confrontarsi su un’intera collezione credo sia importante non solo per un valore documentario, ma soprattutto per la ricerca.

A questo punto, però, ci dilunghiamo a discutere intorno al concetto di fisicità del libro nella sua dematerializzazione digitale. Io dico che il libro immateriale ha una sua materialità, Andrea dice che però su FN si trova l’immagine di un oggetto fisico, non il libro elettronico in sé e Federico dice che sul sito si fa una rappresentazione di un oggetto fisico, secondo delle regole che si sono dati per la sua rappresentazione, così che la rappresentazione non fisica di un oggetto è legata a regole e diventa segno, immagine. A questo punto ci accorgiamo che la discussione potrebbe spostarsi sul piano filosofico e poco prima di approdare al mito della caverna, viriamo verso terreni meno minati.
Certo, parlare di Munari per la grafica di una collana diretta da Calvino è una cosa che risulta decisamente altisonante. Ciononostante non siamo di fronte a un progetto ambizioso, grandioso, ma a qualcosa di semplice, creato con ricercata modestia. Quanto della visione di Munari grafico editoriale c’è in questo lavoro?
ANDREA: C’è tanto Munari, ma soprattutto tanto del Calvino grafico. È evidente che ci sono state molte discussioni e confronti tra i due. Penso, ad esempio, che il fatto di cambiare sempre altezze del testo, i colori, i caratteri e gli elementi grafici, venga in gran parte dalle idee letterarie di Calvino e si sposi perfettamente con i libri presentati nella collana. Detto questo, credo che Munari si sia molto divertito a disegnare questa collana e il Munari che si diverte è proprio quello che ho in testa, è quello che preferisco, immagino il Munari del cucchiaio sull’occhio che lavora a questi libri.
FEDERICO: E aggiungerei che oltre ad essere frutto del confronto tra Calvino e Munari è il risultato del loro dialogo con Giulio Einaudi. L’interesse di questa collana viene anche dal fatto che è una sintesi perfetta dell’Einaudi di quegli anni, sia graficamente che editorialmente. A partire dal fatto che Calvino scrive nell’introduzione che è una collana pensata per i pendolari. Si tratta evidentemente dell’Einaudi pedagogica al massimo suo fulgore.
MARTA: C’è un dialogo fascinoso tra l’idea letteraria di Calvino, da sempre incuriosito da quella macchina matematica che è il linguaggio, e la grafica munariana, che gioca negli spazi e con le ripetizioni degli elementi grafici in copertina. Collane come questa sono la dimostrazione di come in un progetto editoriale l’intera progettazione di un libro parta dalla scelta dei suoi elementi materiali: il primo ingresso alla lettura, oltrepassato il quale ci si addentra in quel godimento più sostanzioso che è la lettura del testo.
Andrea, pensi che questo sia un progetto grafico che a oggi avrebbe senso o credi che, avulso dal contesto storico e letterario in cui è nato, non sarebbe adatto a rappresentare un prodotto editoriale di questo tipo?
ANDREA: Partiamo dal presupposto che pur essendo fuori di trent’anni, sarebbe meglio di gran parte di quello che viene prodotto oggi. Ha i suoi anni e, anche se si vedono, li porta dignitosamente. Ma è soprattutto la progettualità con cui è stato costruito a renderlo fortemente contemporaneo. Il fatto – ripeto – di cambiare sempre altezze del testo, i colori, i caratteri, gli elementi grafici e nonostante questo riuscire a realizzare un qualcosa che risulta sempre familiare, non è semplice. Adesso sarebbe difficile pensare a un editore che cambi il font in ogni volume della stessa collana.

Editorialmente, invece, sarebbe possibile oggi riproporre una collana di questo tipo?
FEDERICO: Sarebbe interessante ripubblicare tale e quale questa collana per vedere cosa accadrebbe. Ma è un esercizio fine a se stesso. Ogni progetto editoriale è un progetto economico, si analizza il mercato e s’identifica il destinatario del bene e si propone qualcosa che s’immagina possa piacere. L’Einaudi di allora immaginava un mercato fatto da un certo tipo di persone disposte ad accogliere un messaggio che aveva una forte componente educativa, pedagogica. Oggi il mercato è regolato da altre istanze e non si capisce bene quale siano, perché i ragionamenti economici sono troppo labili per giustificare le scelte editoriali. Non so se oggi esiste e dove il tipo di ragionamento che troviamo in Calvino, cioè non so quanto effettivamente si cerchi di fotografare delle realtà, di immaginare cosa chiedano i lettori e provare a offrirlo. Allora, se Calvino diceva pendolare, si capiva perfettamente a chi si stava riferendo, oggi non si capisce quali siano i lettori cui si riferiscono molti editori. Il lettore è identificato con il mercato e non c’è più quel processo di autorappresentazione di un desiderio o di proiezione di desideri, che mi sembra estremamente interessante anche come scelta per regolare il mercato.
Quali saranno le nuove tappe della mostra e quando sono previste?
FEDERICO e ANDREA: Non abbiamo ancora date sicure, ma abbiamo delle sedi: Rimini, Milano, Parma e Palermo (durante il festival Una marina di libri, nel secondo week end di giugno). La cosa di cui siamo contenti è che soggetti diversi tra loro, da librerie, ad associazioni e anche i festival, si stanno interessando all’evento.
Pensate che questo progetto si evolverà, si trasformerà ancora, potrà diventare altro?
FEDERICO: Certo, le mostre possono essere più ricche, ma non so verso quale direzione potremo muoverci.
ANDREA: Al momento, oltre la mostra abbiamo anche un catalogo formato poster.
FEDERICO: L’ha realizzato Christel Martinod che si occupa di tutta la grafica di FN, dal sito al cartaceo. Ha già realizzato il catalogo della mostra su Roland Barthes e quella di Futureworld.
ANDREA: Sarebbe bello se questo catalogo, una volta concluse le schede bibliografiche, insieme al materiale che stiamo raccogliendo durante le mostre, comprese le storie che molte persone ci stanno raccontando sull’Einaudi di quegli anni, potesse diventare un catalogo-libro, magari proprio del formato di centopagine. Si creerebbe un bel cortocircuito: partire dai libri per tornare al libro.
MARTA: Perché no, l’idea del catalogo-libro non mi dispiace. Sarebbe anche un modo per far dialogare le due anime della mostra: quella letteraria e quella grafico-editoriale.

Alla fine, andiamo avanti per un po’ a parlare della responsabilità degli intellettuali nel dopoguerra, fino all’onda lunga degli anni Sessanta e Settanta. Abbiamo moti di nostalgia per un’editoria che non esiste più, ridiamo a una battuta di Federico sull’assenza di pluralità in quella che ormai è una diarchia editoriale e concludiamo tra saluti e speranze.