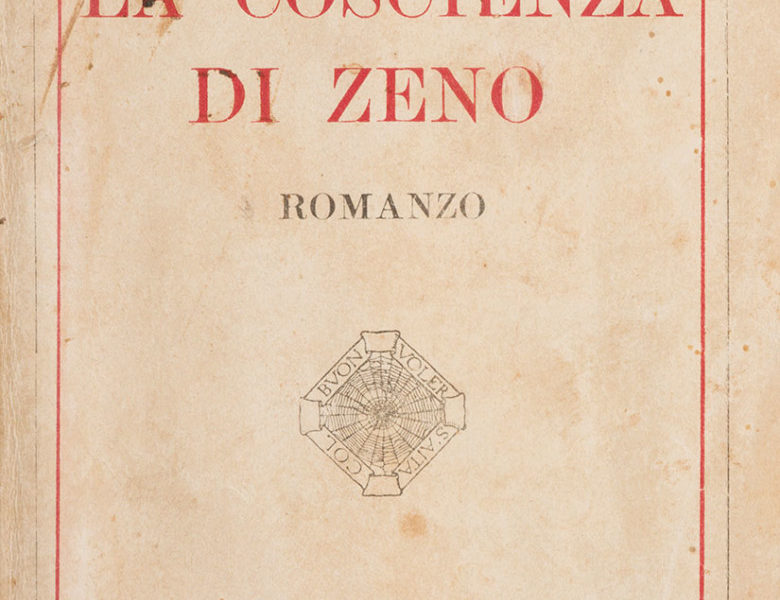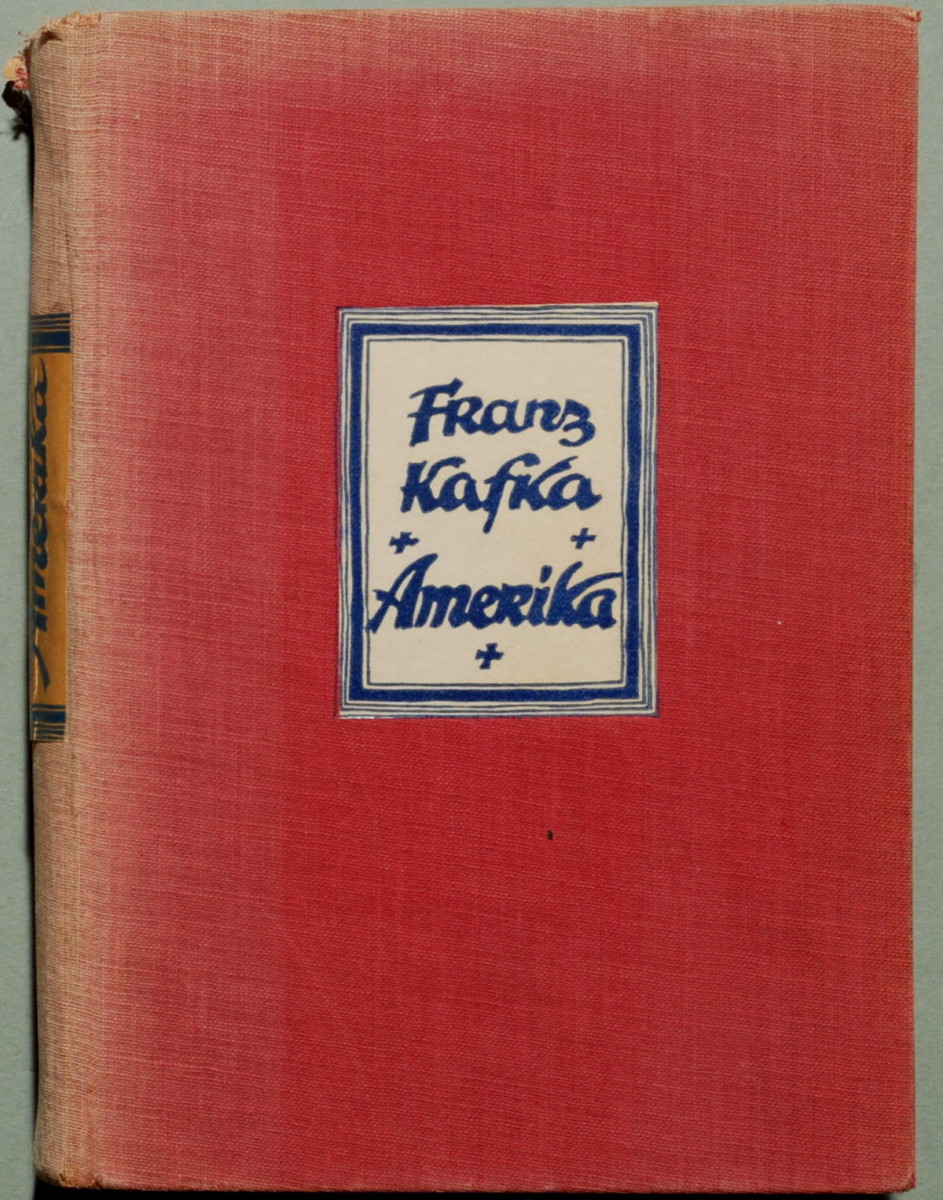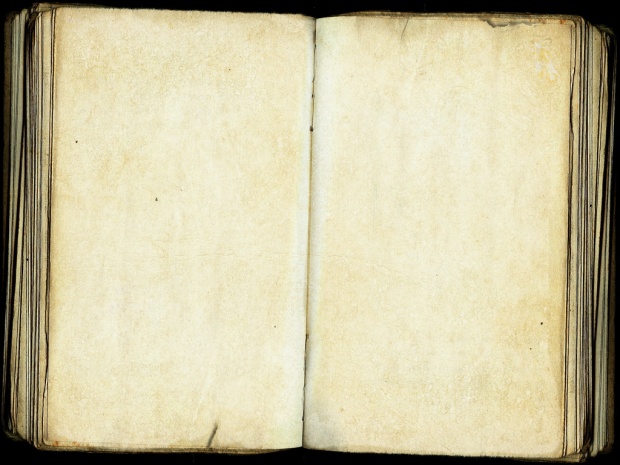Mi ero inizialmente tenuto lontano da Teoria della classe disagiata (minimum fax, 2017) di Raffaele Alberto Ventura perché, a una rapida ricognizione, avevo notato la totale assenza di note e bibliografia, elementi che per un saggio a sfondo economico-esistenziale dovrebbero essere invece o un requisito minimo, o all’opposto una scelta di rottura. Ma nel secondo caso, questa scelta andrebbe motivata nel testo stesso, persino esibita con sfrontatezza – a fronte soprattutto dell’ipercitazionismo.
In ogni caso, incuriosito dalla sequela di elogi, non ultimo quello autorevole di Tiziano Scarpa su Primo Amore, sono andato a vedere se oltre la mia ortodossia metodologica brillasse una stella in grado di orientare un’intera generazione, mostrando nel disagiato cielo una qualche stella polare.
Ho trovato un testo più estetizzante che teorico, più divulgativo che didascalico, più poetico che argomentativo. Dove per “poetico” intendo il motivare le scelte linguistiche dall’interno, modellandole su sensazioni raffinate nell’eloquio. Altrimenti avremmo dei dati contestualizzati, avremmo la delimitazione chiara e netta di un campo di osservazione, una metodologia dichiarata; avremmo delle tesi enunciate poi passate al vaglio, e lo stile cercherebbe di aderire a un’impalcatura di pensiero per farle emergere il più nitide possibile al lettore. Insomma, avremmo ampie tracce di realtà empirica.
Invece già nella premessa si notano tratti stilistici ricorrenti che, per l’appunto, connotano il testo come poetico. Diventa dunque interessante evidenziarli, muovendo così dalle periferie delle scelte stilistiche al cuore dell’opera.
Il primo tratto è la dissimulazione degli enunciati, ottenuta di solito col ricorso a interrogative, a costrutti ipotetici e dubitativi, con il condizionale e il congiuntivo al posto dell’indicativo. Quando accade, l’effetto è quello di far muovere il lettore in una parvenza di concetti, che affascinano ancor prima di provare a convincere. Prendiamo la premessa (p. 7), vera e propria captatio benevolentiae:
«Questo libro inizia da me, come dire che inizia da noi. Inizia con un lamento che è forse il lamento di tutta una generazione, o forse di una singola classe in seno a questa generazione: noi non siamo stati preparati per questa vita agra, ma per un’altra meravigliosa. Il problema è che quella vita non esiste. Non è tragico, non è comico? Qualcuno dice che siamo stati educati a trasgredire i limiti, qualcun altro che i limiti bisogna conoscerli e rispettarli. La nostra tragedia, dico io, è che entro quei limiti non ci stiamo più. È come la storia di Auguste Langlois, avete presente?» [Corsivi miei, anche nelle successive citazioni, ndr.]
C’è un io che si presenta a un pubblico indefinito, con cui è accomunato da una stessa sorte; il tono è empatico e allocutorio – la prima persona plurale è ricorrente nel testo. Chi parla non sembra un saggista, o uno studioso, che di solito delimita con spirito geometrico ciò di cui andrà a trattare, tanto più che alla fine della premessa chi parla si pone addirittura in contrapposizione con queste categorie:
«Chiedo comprensione agli specialisti – di sociologia, di economia, di storia, di critica letteraria, di flosofa… – che vorranno rimproverarmi l’invasione del loro territorio protetto: le risposte alle mie domande nei loro libri non le ho trovate, e ho dovuto andarle a cercare da solo».
Abbiamo una maschera linguistica che sembra dunque quella del poeta. Un poeta ispirato dalle molte letture, e che si rivolge a una platea – come il pubblico di un teatro. Come ogni poeta predilige l’indeterminatezza, che suona più piacevole e non richiede approcci analitici o razionali; il poeta inoltre predilige la possibilità di tradurre i concetti astratti in immagini e suggestioni. Sempre nella premessa i sei capitoli sono per esempio chiamati “movimenti” – termine che rimanda alle parti di una sinfonia.
Un altro tratto stilistico è la generalizzazione dei concetti, o la loro riproposizione variata. L’effetto è di occultare le differenze particolari degli elementi trattati o le eventuali contraddizioni di pensiero. Una prima spia linguistica è l’ambivalente riferirsi a più riprese a uno scenario ora “tragico”, ora “comico” ora “tragicomico”: ovvio che un medesimo scenario non può essere acriticamente definito in tre modi diversi. La stessa “classe disagiata” che dà il titolo al libro, è chiamata con diverse espressioni – tra cui “classe media”, “classi subalterne”, “ceto medio”, ed è così definita (pp. 16-17):
«Il concetto di classe disagiata che propongo include un ampio spettro di casi umani, tutti caratterizzati dall’esperienza disforica della mobilità discendente […] In tutti si produce quello sfasamento tra l’identità sociale percepita e le risorse disponibili che caratterizza la classe disagiata».
Dalla lunga elencazione, presentata stavolta con clinico tono denigratorio («ampio spettro di casi umani») si individua una fascia sociale di nazionalità imprecisata in cui, di base, può rientrare chiunque, tranne un Lapo Elkann o un mendicante. Addirittura a pag. 205 si cita, come figura che “incarna” la «rabbia feroce di chi non trova il posto che gli è stato promesso nella società», John Rambo, paragonando la sua storia di reduce al «destino di un ricercatore in fisica che torna a vivere in Italia».
Il nostro poeta parla poi nel libro di globalizzazione, sistema capitalistico e mondo occidentale, e in molti casi desumiamo che lo scenario di riferimento è quello italiano; tuttavia non mancano menzioni al mondo arabo o alla Cina e a del conflitto economico con gli Usa. Talvolta si parla della generazione tra il 1978 e il 1999 – i Millenials o la Generazione Y. Quanto a ciò di cui il libro parla, troviamo più dichiarazioni:
«Lo scopo di questo libro è appunto ritrovare questa dimensione rimossa per capire la crisi che stiamo vivendo. […] Questo scritto vorrebbe essere un’autocritica impietosa ma si lascia volentieri consumare da una vena di malinconia. […] Nasce come atto di accusa ma suona spesso come un’arringa difensiva. Sulla sua strada prova a decostruire il ruolo delle istituzioni laiche che continuiamo a venerare. (p. 9)
[…] voglio descrivere la condizione di quella larga parte del ceto medio che nell’arco di una generazione è passata da classe agiata, secondo la definizione di Thorstein Veblen, a classe disagiata: ovvero troppo ricca per rinunciare alle proprie aspirazioni, ma troppo povera per poterle realizzare». (p. 11)
«Questo libro vuole essere, come minimo, un archivio di fonti e riferimenti da esplorare. […] L’argomento di questo libro consiste proprio nell’esaminare le disfunzioni di una società quasi interamente popolata da emulatori di Lucien de Rubempré». (p. 29)
Il terzo tratto stilistico è l’ipercitazionismo, che in Teoria della classe disagiata vede un alternarsi di opere letterarie, economiche e sociologiche, con una continua serie di scambi e rimandi, talvolta con lunghe digressioni – seppure interessanti, come nel caso del teatro di Goldoni. Questa difformità di generi, assorbita all’interno del testo, così come il vasto ed eterogeneo eloquio che scandiscono, fa apparire autorevole l’emittente, e quindi affidabile. Ciò impressiona nella misura in cui non si hanno strumenti di decodifica – i letterati hanno minori strumenti per decodificare i testi economici, gli economisti hanno minori strumenti per decodificare i testi letterari. Funzionali a questo effetto risultano dunque l’assenza di note, bibliografia e dati contestualizzati, che avrebbero offerto uno sguardo esterno all’esperienza di lettura del testo vero e proprio, interrompendo la suggestività dell’esperienza estetica offerta dalla lettura.
Ma saltare da un ambito di sapere a un altro significa anche cambiare ordine epistemologico, abituando il lettore a questo continuum: la letteratura, benché non aliena dalla realtà empirica, si muove in un patrimonio codificato di simboli e topoi. Detto più banalmente: il lupo delle favole non è il lupo degli incubi ricorrenti di cui magari parliamo a un terapista, e certo non è utile a comprendere sul piano etologico il lupo comune. Non che siano mondi separati e incompatibili, altrimenti non esisterebbero approcci interdisciplinari, ma è qui che la metodologia fa la differenza, e «leggendo l’economia come fosse letteratura, la letteratura come fosse economia», a ben guardare, è un chiasmo.
In Teoria della classe disagiata questa dissimulazione di metodo contribuisce a plasmare una doppia cornice. La prima, storica ed economica, delinea uno scenario apocalittico, riassumibile in Keynes è morto, siamo fottuti, noi della classe disagiata siamo destinati a una fine rovinosa. Siamo dunque in uno spazio esterno totalizzante, oppressivo e senza via di scampo. Entro questa cornice si trova la seconda, che tematizza la condizione dell’individuo – disagiato – sul piano psichico, con rilevante ricorso a termini clinici, talvolta metaforizzati (la «disforia di classe»), talvolta accompagnate da toni consolatori o assolutori («Non è colpa nostra: ci hanno programmati così, ci hanno cresciuti come signori».). Siamo dunque in uno spazio più interno, dove il poeta ci ha lungamente spiegato che i nostri eventuali strumenti di decodifica critica, acquisiti attraverso l’istruzione, non sono altro che «beni posizionali»: niente più di uno status symbol o di un errore d’investimento.
Attraverso questi tratti stilistici dissimulanti, notiamo che la maschera linguistica prima individuata – il suggestivo e afflitto poeta – ne nasconde un’altra, che entra in azione con più efficacia proprio grazie all’abbassamento di una soglia razionale o critica. Lo vediamo in alcuni passaggi dove troviamo la versione elegante e in punta di piedi di stereotipi o retoriche violente.
Abbiamo zingari che non si vogliono integrare:
«Pare che i rom siano i discendenti di un’antica casta di artisti che lavoravano per i sovrani dell’India. E sebbene siano passati secoli dalla loro epoca gloriosa molti di loro continuano a impuntarsi, rifiutando l’assimilazione per restare fedeli alla loro aristocrazia dello spirito. Piuttosto di accettare le conseguenze del declassamento e piegarsi alla ragione economica dei popoli che li ospitano, loro preferiscono starsene nelle loro baracche a vivere come signori decaduti. E questa è forse un’immagine del nostro destino». (p. 122)
Abbiamo giovani fannulloni che non hanno voglia di sporcarsi le mani:
«Periodicamente un politico incauto lancia una sparata sui giovani fannulloni, così scatenando il subbuglio di mille code di paglia che manifestano il proprio attaccamento allo status acquisito per mezzo degli investimenti formativi: «Ho sette lauree, vacci tu a raccogliere i pomodori!» Non ci si può non porre, allora, la questione della disoccupazione volontaria: non è forse la classe disagiata stessa a rifiutare certi lavori, troppo umili e faticosi per lei?» (p. 181)
Abbiamo la colpevolizzazione allusiva di un ceto intellettuale:
«Fa sempre un certo effetto quando si elencano i nomi dei grandi austriaci e tedeschi della prima metà del secolo passato e si misura la prosperità culturale di quel mondo che avrebbe prodotto – talvolta collaborando, più spesso subendo – l’orrore nazista. Un esercito di registi, pittori, scrittori, drammaturghi, poeti, giuristi, filosofi, storici, sociologi, teologi, musicisti, economisti e scienziati; una concentrazione di eccellenze forse mai vista nell’intera storia dell’umanità, da Fritz Lang a Ernst Lubitsch, da Kurt Schwitters a Otto Dix, da Thomas Mann a Robert Musil, da Bertolt Brecht a Gottfried Benn, da Ludwig Wittgenstein a Theodor Adorno, da Hans Kelsen ad Hannah Arendt, da Erich Auerbach a Martin Buber, da Gershom Scholem a Karl Barth, da Richard Strauss a Schönberg, da Wernher von Braun ad Albert Einstein, da Joseph Schumpeter a Friedrich von Hayek eccetera. Tra questi contiamo qualche suicida ma soprattutto diversi emigrati che trovarono negli Stati Uniti d’America (ma anche in Israele o nel Regno Unito) una terra d’adozione. Invece di chiedersi come sia stato possibile che una civiltà così raffinata abbia prodotto il nazismo, dovremmo chiederci se una simile abbondanza di capitale culturale non sia il sintomo di quello stesso squilibrio che ha messo in moto il meccanismo infernale del Terzo Reich». (pp. 216-217)
Questo passo presenta varie omissioni e riduzionismi. L’espatrio o la fuga per evitare carcere, torture, internamento diventa «trovare una terra d’adozione»; chi si salva è definito «emigrato». La persecuzione, se va male, diventa «qualche suicidio»; è citato un «esercito» di nomi, di cui, curiosamente, non fanno parte quegli intellettuali che finirono in un campo di concentramento, e lì morirono – o forse ci sono, ma sotto un tappeto linguistico («più spesso subendo – l’orrore nazista», «eccetera»). Scompare qualunque cornice legata alle concause che portarono al Terzo Reich. Solo per citarne alcune: la debolezza delle istituzioni democratiche, il disastroso dopoguerra con la Germania economicamente in ginocchio, il terrore anticomunista, gli interessi degli industriali che progressivamente trovarono conveniente sostenere l’ascesa del fascismo, l’antisemitismo e il clima ostile che creava attorno a idee e persone. Come se la vita politica di un paese fosse un tavolo dove gli intellettuali (il «capitale culturale») si siedono con altri esponenti, e se la giocano ad armi pari. Anzi, con mani migliori e più potere, visto che la Germania dell’epoca era una «civiltà così raffinata». E, ancora una volta, il concetto portante è alluso, passa nella comoda e in apparente inoffensiva veste di dubbio.
Infine, per tornare ai giorni nostri, abbiamo i giovani che si lamentano a pancia piena, quando c’è chi sta peggio di loro:
«Ci vediamo nella parte degli oppressi, ma forse non siamo altro che degli oppressori falliti. Rivendichiamo dei diritti, ma non ci accorgiamo che sono dei privilegi. Militiamo a sinistra, ma il nostro partito è quello dello status quo». (p. 38)
Quest’ultimo caso è interessante proprio prendendo in esame come vero e certo il suo enunciato. Se vale il principio, sul piano sociale, del tu forse sei oppressore (fallito) di chi sta peggio di te allora sotto la classe disagiata esiste per l’appunto un’altra classe – chiamiamola classe disperata, che sta peggio. E quindi i disagiati sono oppressori anche sul piano psichico, non dovrebbero nemmeno lamentarsi del loro essere disagiati; diamine, i disperati almeno non rimuovono la loro condizione, non si possono permettere il lusso dell’autoinganno. Ma siamo sicuri che nella piramide della società dei consumi capitalista non esista una classe ancora più oppressa di quella disperata, talmente oppressa che nemmeno il vocabolario riesce a esprimere efficacemente la sua condizione, ma che di sicuro lungo questa catena è oppressa dai disperati e dai disagiati? Certo avrebbero più diritto di tutti a ribellarsi, ma di che mezzi potrebbero disporre?
La stessa distinzione tra lavoro produttivo e improduttivo che fonda buona parte del discorso di tipo economico, al di là delle argomentazioni ad verecundiam, all’atto pratico pone delle problematiche tutt’altro che neutre o “disagiate”. Se i medici sono un lavoro improduttivo (ossia uno spreco di risorse), come dobbiamo considerare i malati? Coerenza vorrebbe in base al loro lavoro, e allora il malato che svolge un lavoro produttivo ha più diritto a essere curato. Ma a prendere in blocco questo schema, dovremmo sterminare tutti i pazienti incurabili – ossia i malati terminali, che non potranno più svolgere nessun tipo di lavoro. Si poteva andare fino in fondo, se non altro per il gusto della provocazione, del paradosso, lungo il canone della satira, no?
Ma se a parlare nel testo è una sola voce – l’autore stesso – allora duplicità e dissimulazione sono i veri tratti della maschera linguistica, e quella del poeta è solo un travestimento. Come potremmo definire allora l’ambigua maschera che caratterizza questa prosa disagiata? La prima ipotesi è che si tratti di una maschera comica: l’unico attore in scena adotta quegli strumenti e quei saperi che bolla come inutili, superflui, e lo fa perché vuole curare il pubblico, che è simile a lui, farne emergere “il rimosso”. Una specie di pazzo talentuoso che recita il ruolo dello psicoterapeuta, e che naturalmente ha atteggiamenti dissociati e contraddittori – da una parte è comprensivo, dall’altra offende e denigra; da una parte è dotto, dall’altra è approssimativo o grossolano. La seconda è che si tratti di un imbonitore che ha bisogno di occultare il suo scopo, e di sembrare qualcos’altro rispetto a ciò che è, per raggiungerlo.
A conti fatti, nell’impossibilità di sciogliere il dubbio, buon senso suggerisce di diffidare di entrambe le maschere – un po’ come se avessimo a che fare con un trollatore sofisticatissimo.
Suona come difesa a posteriori traballante parlare di Teoria della classe disagiata in termini di pamphlet, come a giustificare quelle che, altrimenti, potrebbero essere additate come debolezze: casualmente, sul sito dell’editore non è usata la parola “pamphlet” nella scheda dedicata a Teoria della classe disagiata. Senza contare che nel libro sono elaborati scritti disseminati nel corso degli anni, tra cui una prima versione dello stesso; non sorge dalla contingenza esterna, o da un impeto frontale. Ma, a parte ciò, come dire, sul piano testuale è del pamphlet la veemenza, la brevità della sferragliata semantica, l’entrata a gamba tesa; i caricatori al posto dei “movimenti”, l’oltraggio esplicito che non chiede alcun permesso, la falsificazione senza ritegno. Chi parla in un pamphlet fa vibrare i vetri della stanza di chi legge; tra l’utile e il dilettevole sceglie l’incendiare; se scaglia il sasso rivendica la mano, serrando le dita attorno al medio slanciato; pure i libri scaglia, invece di citarli; e quando ha vicino il bersaglio gli salta addosso e lo massacra dileggiandolo.
In Teoria della classe disagiata troviamo invece dell’arguzia, battute di spirito piazzate là dove è sicuro l’effetto. E troviamo quella modica quantità di ironia che, unita ai tratti dissimulanti, garantisce di fronte alle critiche un comodo campionario di exit strategy – “è ironico, è una provocazione! Non sta a pag. x, ma si desume dalla citazione indiretta in fondo a pag. x! È metametametasatira, possibile che non si capisca? Hai mai letto Tizio, Caio, Sempronio? Il fatto che si critichi questa cosa dimostra la sua fondatezza” eccetera. Senza dunque fornire chiavi di decifratura tra “commedia” e “tragedia”, e palleggiando con la nostra attenzione fra entrambe, l’autore ci infila nel bel mezzo di un carnevale cui non eravamo stati esplicitamente invitati, e alle nostre domande sul perché non abbia avvertito sul tema della festa, ci risponde: “Che sia forse uno scherzo?”, magari ridacchiando soddisfatto tra sé.
(Raffaele Alberto Ventura, Teoria della classe disagiata, minimum fax, 2017, pp. 262, euro 16)