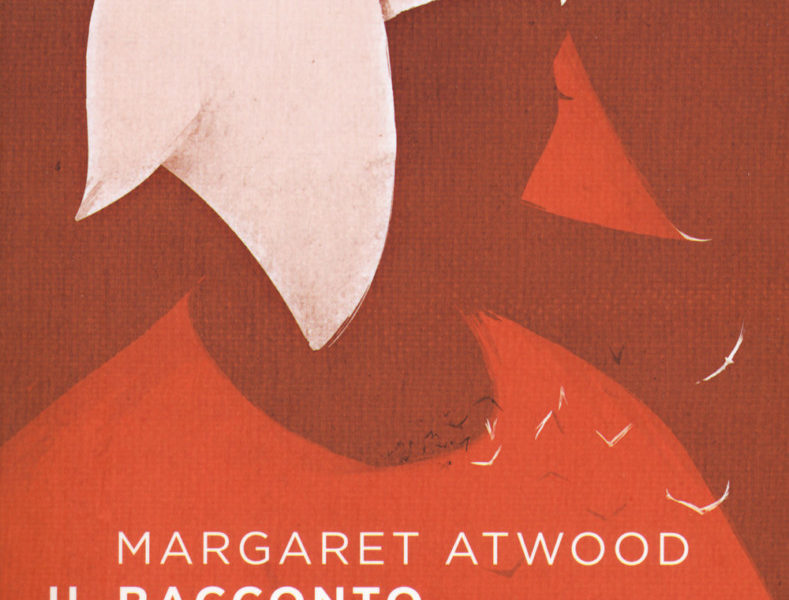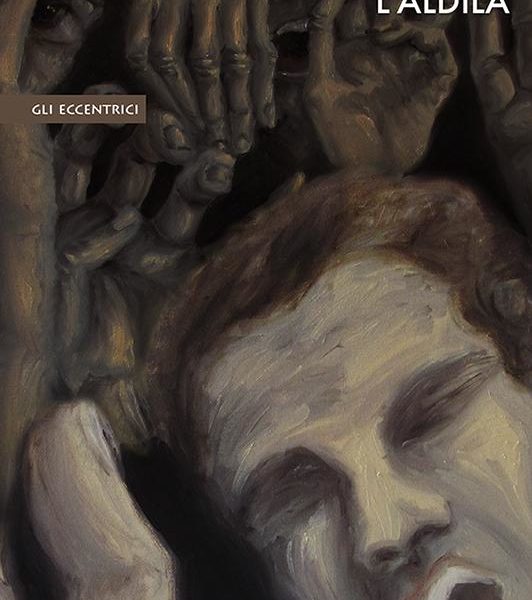Il Satyricon di Petronio e L’asino d’oro di Apuleio, per la maggior parte di noi, non sono che il polveroso ricordo scolastico di due noiosi testi classici, che per giunta ci toccava tradurre dal latino. Viziati da lontani pregiudizi liceali, spesso le consideriamo opere adatte a fare la loro bella figura nella libreria del salotto, ma che difficilmente penseremmo di riprendere in mano. Insomma qualcosa di troppo lontano rispetto alla nostra moderna estetica pop, e che ci contentiamo di etichettare come “interessante”. Dove con questo anemico attributo, usato con nonchalance come sinonimo appena mascherato del suo contrario, si intende una reazione assente, perplessa e affievolita, qualcosa che nella sua astratta genericità vuol dire tutto e non vuol dire niente. Questa deformazione prospettica ha a che fare con il grande conflitto estetico del nostro tempo, quello che vede il tramontare delle tradizionali categorie del Bello e del Sublime in favore del più rassicurante “interessante” di cui sopra, la moneta che spendiamo correntemente nelle svagate chiacchiere da salotto o da dopo mostra, nelle lezioni scolastiche, in certa critica letteraria, nei giudizi correnti. Ciò che è “interessante” è innocuo, mentre il Bello è eversivo. «La bellezza salverà il mondo», ci preannunciava Dostoevskij già nel XIX secolo, ma in fondo chi vuole prendersi la briga di salvarlo, oggi come oggi? Troppa fatica.
Tutto ciò trova il suo opposto speculare nell’altro comune sentire circa la letteratura cosiddetta “d’evasione”, “di consumo” o “d’intrattenimento”, altresì detta “pop”, generico calderone nel quale si getta ogni opera cronologicamente più vicina e che sia capace di farsi icona del nostro immaginario attraverso le vie del fantastico – e non solo – da Alice nel paese delle meraviglie di Carroll al Dracula di Bram Stoker allo Sherlock Holmes di Doyle, giusto per citarne alcune punte di diamante. Qui, a regnare sul kantiano concetto di Bello, il generico e volgare “interessante” cede il posto alle sottocategorie estetiche dei suoi tiepidi parenti, per esempio il “carino”, lo “strano” o il “divertente”.
Ma al di là del dibattito che contrappone una letteratura di serie A a un’altra di serie B, e senza perciò entrare in merito alle opposte fazioni che si contendono la vittoria nello stabilirne il peso ponderale, voglio piuttosto soffermarmi sulla moderna banalizzazione dell’estetica e la sua conseguente pericolosa deriva, l’anestetizzazione del Bello. A questo proposito trovo significativi i tre recenti volumi di Franco Pezzini, studioso dei rapporti tra letteratura, cinema e antropologia, con particolare attenzione agli aspetti mitico-religiosi e al fantastico, editi dalla casa editrice bolognese Odoya, specializzata in saggistica divulgativa: Victoriana. Maschere e miti, demoni e dei del mondo vittoriano (ottobre 2016), L’importanza di essere Lucio. Eros, magia e mistero ne L’asino d’oro di Apuleio (marzo 2017) e L’odissea di Encolpio. Sesso, licantropi e labirinti nel Satyricon di Petronio (giugno 2017).
Il filo rosso che lega questi tre ottimi testi di Pezzini – non a caso animatore della Libera Università dell’Immaginario – è la loro capacità di far riemergere il Bello dalla regressione nella pseudo esperienza estetica degli appiattenti e conformistici “interessante” o “divertente” di cui sopra, apparentemente innocui eppure capaci di anestetizzare la più fiera capacità di giudizio. Salvandoci, per un momento, dalla trasfigurazione del mondo in sbadiglio, dal rassegnato pregiudizio Bello uguale noioso. In un orizzonte culturale in cui cinema, teatro e arti figurative – dalla pittura al fumetto – stratificano suggestioni e ci portano a ripensare l’universo letterario consapevoli della necessità di un approccio e di un linguaggio mutati, Pezzini ci propone un affascinante percorso in cui gli strumenti dell’analisi letteraria e storica più rigorosa dialogano a pari merito con forme e aspetti del nostro immaginario, dalle ancestrali figure archetipiche alla simbologia dei miti moderni. Ma intervistiamo direttamente l’autore.
Franco, iniziamo con una domanda di carattere strutturale. Tu riconosci al Satyricon di Petronio e a L’asino d’oro di Apuleio la natura letteraria del romanzo, specificando però quanto questa sia una definizione moderna senza equivalenti nel mondo antico. Sotto questo aspetto, considerando quanto la realtà soggettiva del romanzo contemporaneo modifichi le coordinate di spazio, tempo e linguaggio (flusso di coscienza, monologo interiore, ecc.) che differenze o analogie vi riscontri rispetto ai due testi di Petronio e Apuleio?
Sì, è chiaro che l’etichetta “romanzo” va utilizzata tenendo conto di una realtà abbastanza diversa dai romanzi antichi in generale (si pensi a quelli greci d’amore e d’avventura) e di questi due in particolare: a loro volta non troppo simili tra loro né per condizione – del Satyricon si è persa gran parte – né per impianto. E già la dice lunga il fatto che nell’antichità una categoria “romanzo”, un termine tecnico per definirlo non esista. Ma a sua volta il romanzo contemporaneo non è sempre somigliante a quello classico dell’ottocento: troviamo una situazione molto più liquida, e dove affluiscono contaminazioni di vario genere, che ormai consideriamo sempre meno “anomale”. In questo senso, rispetto all’accezione odierna – che tende ad aprire sempre più in direzione di ciò che i Wu Ming chiamano oggetti narrativi non identificati (che stanno magari un passo oltre la forma-romanzo come oggi percepita, ma il confine è mobile e tende a spostarsi) – in termini generali è difficile stabilire differenze marcate, senza sbavature. Il Satyricon è troppo malconcio per pretendere di offrirne interpretazioni troppo certe, ma certo la natura di un testo che alterna prosa e poesia è un po’ particolare. Quanto all’Asino d’oro la categoria dell’oggetto narrativo non identificato appare particolarmente intrigante: c’è una strana struttura che include non solo novelle di varia ampiezza ma un micro-romanzo – la storia di Amore e Psiche – a sua volta incluso in un’altra novella, quella di Carite e Tlepolemo; c’è uno straniante gioco di identità dell’io narrante che trascolora, ma a gradi, da un Apuleio (virtuale) al protagonista Lucio e poi di nuovo all’autore (sempre virtuale); e c’è un intento generale dell’autore su cui ancora si discute. Ma tutto sommato per testi narrativi lunghi in gran parte di prosa, con unità di fondo e personalità autorale forte la definizione di romanzi (offerta del resto da un robusto filone critico) non pare incongrua.
Poi, certo, il romanzo moderno non deriva direttamente dall’antico: il suo capostipite, si dice, è il Don Chisciotte, anche se sarebbe più corretto individuarlo nel protomodello del picaresco, quell’opera straordinaria che è il Lazarillo de Tormes. E i romanzi di Petronio e Apuleio mostrano proprio una dimensione che potremmo definire picaresca: lo spazio-tempo autobiografico di un itinerario umano avventuroso e semiserio, lungo e accidentato, malizioso e a volte riprovevole, con le sue miserie e gioie, fino a una qualche realizzazione (nell’Asino d’oro evidente, nel Satyricon ipotizzata).
Se non c’è una diretta derivazione genetica tra antico e moderno, almeno un influsso potente è però avvertibile. Soprattutto L’asino d’oro resta un testo di riferimento, che modella l’immaginario dei secoli seguenti (anche specificamente quello fantastico) e ispirerà in modo diretto o indiretto molti narratori moderni. Se anzi esaminiamo questi romanzi non frettolosamente, ci accorgiamo di quanto da vicino ci parlino a partire dalle forme, dal registro di comunicazione. C’è appunto il discorso della provocazione identitaria, giocata in Petronio con un sofisticato gioco di rifrazioni e stacchi del lettore dall’io narrante, e in Apuleio nella forma ambigua e cangiante quasi pirandelliana di cui accennato; c’è la dimensione del linguaggio, gestita nel Satyricon differenziando pirotecnicamente i registri espressivi a seconda di profilo culturale e persino di livello di sobrietà dei personaggi, e nell’Asino d’oro con un’operazione altrettanto sperimentale di acrobazie lessicali; mentre spazio e tempo appaiono perturbati in storie che (soprattutto nel caso di Apuleio) potrebbero appartenere alla dimensione onirica, a indecidibili visioni d’iniziazione o a un caso di Jung.
Ovviamente le strutture formali sono in dialogo con i contenuti, conturbantemente attuali. Per Petronio pensiamo a quella deriva che da una fuga nel cibo – a prefigurare in modo inquietante l’odierna età dei MasterChef, nuovi guru in un tempo di decadenza – traghetta all’uomo-cibo, al cannibalismo lupesco e predatorio; o alla dimensione del sesso, nelle dimensioni più estreme, di volta in volta (ma non moralisticamente) tristi o grottesche. Mentre per Apuleio, colpisce il mix di disincanto e tentazione del magico (che in qualche modo prefigura certi fiati del fantastico laico e moderno, inteso alla Todorov come incertezza, imbarazzo e ambiguità), di ironia e inquietudine che avvertiamo come paradossalmente vicini. Se i romanzi silfici del settecento mettevano in scena spiritelli guardoni che scrutano le alcove all’insegna di un meraviglioso un po’ birichino, qui a dispetto della wonder di streghe e continue metamorfosi il punto di vista è molto più feriale e ordinario, un asino che guarda… E l’occhieggiare voyeuristico dell’asino curiosus che punta al torbido di un’intera società prefigura le Commedie umane di tutta la letteratura moderna. Entrambe le voci echeggiano in forme e contenuti i grovigli di una società complessa, la crisi delle agenzie di certezza, i tentativi nobili o goffi di farvi fronte.
A proposito di questo, infatti, tu evidenzi quanto uno dei livelli di lettura delle opere classiche del Satyricon e de L’asino d’oro sia certamente quello di un itinerario in progress in cui tutto cambia rapidamente, metamorfizzando in continui colpi di scena, sorta di percorso-guida nell’immaginario i cui personaggi, quando mutano in animali, non possono non ricordarci La metamorfosi di Kafka. Oltre a ciò sottolinei quanto costituiscano una specie di gangster story, di true crime del mondo antico, che con i loro nessi sghembi tra grottesco e violenza rimandano molto da vicino alle atmosfere dei moderni snuff movie o a Pulp fiction di Tarantino. Dunque, al di là dei debiti che la moderna narrativa ha con questi due capolavori del passato, anche il cinema sembrerebbe vantare una certa eredità. In quanto studioso dell’immaginario, se e in che modo pensi che la loro eco possa essere significativa anche in altri ambiti della cultura e della società?
È un fatto che i romanzi in questione impattino sulla cultura ben oltre i limiti della sfera letteraria. Per il Satyricon la ricaduta cinematografica è evidente: oltre al capolavoro di Fellini, si pensi alla coeva e non disprezzabile versione di Polidoro, ma persino alla parodia con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che conferma una popolarità diffusa. Mentre per L’asino d’oro, e a parte la modesta trasposizione di Sergio Spina, occorre considerare le derivazioni dirette (per esempio gli influssi sul Decameron, fino a quello di Pasolini che trattiene proprio uno degli episodi “apuleiani”) e indirette (per dire, da Bella e la bestia a Pinocchio, con tanto di trasposizioni sceniche). Derivazioni neppure sempre coscienti: l’impatto del romanzo di Apuleio sulle arti figurative, la musica e un intero ventaglio di forme di spettacolo è stato strabordante. Al punto che è divertente – ma credo lecito, dal punto di vista di ciò che Petronio e Apuleio ci direbbero (ridacchiando) se potessimo intervistarli – un gioco con le nostre categorie culturali: la sfida a individuare i lasciti di queste pagine latine in opere anche lontanissime.
In Victoriana parli delle strutture-tipo (come per esempio le tentazioni di Sant’Antonio o la fine di Don Giovanni) che per secoli hanno offerto combustibile all’immaginario collettivo, permettendone le più varie declinazioni narrative, pittoriche, musicali, ecc. e soffermandoti in particolare su quella di Salomè, il cui fascino torbido e ingenuo trova ampia eco nell’epoca vittoriana, basti ricordare Oscar Wilde ed Aubrey Beardsley. Ne L’asino d’oro e nel Satyricon analizzi la figura archetipica dell’antica Lamia, l’orchessa che si nutriva del sangue dei bambini, unitamente ad altre epifanie ibride di creature femminili seducenti e mutanti. È dunque già nell’antichità classica che possiamo rintracciare la radice della struttura-tipo del moderno modello di Vamp e di Dark Lady, che dalla Londra vittoriana giunge fino a noi?
Sicuramente, anzi le origini sono addirittura precedenti: diciamo post-neolitiche, in riferimento cioè alla lunga fase in cui il mondo della Grande Madre – schematizzo forzatamente, ma solo per capirci – viene travolto e permeato da culture di allevatori patriarcali. I volti “tranquillizzanti” della Dea diventano tante brave mogli, madri e amanti dei dominatori maschi, quelli inquietanti (in particolare la dea della morte e dei morti) vengono subordinati come caratteristiche secondarie delle dee o decisamente demonizzati. Ripeto, ora sto forzando e banalizzando un quadro infinitamente più complesso, ma la vampira – in senso generico – è un modello arcaicissimo, e non attiene solo al recupero post-settecentesco delle storie di vampiri – ora in senso tecnico – dell’est europeo. Teniamo presente che per migliaia e migliaia d’anni queste orchesse, evocate dalle balie per minacciare i bambini ma anche da operatori del magico in contesti preoccupati o invece spiacevoli, sono rimaste confinate in gran parte nella cultura popolare: gli autori classici le citano quasi per sbaglio, e le recuperano con imbarazzo tirandole un po’ per i capelli nelle biblioteche mitologiche. Più avanti, in età cristiana, questi profili si compenetrano con quelli di dee false e bugiarde o di ultrapeccatrici come Salomè. Salvo riemergere in forme nuove con il mondo moderno: diavolesse, vampire, vamp, femme fatale, dark lady… La Salomè simbolista presidia per esempio vari fronti artistici “alti” ma in parallelo le sue perfide sorelle dilagano nei generi popolari, e un punto d’incontro sarà il cinema. Comunque una svolta importante è legata nell’ottocento alle dee preraffaellite, numinose come Astarte Siriaca, affascinanti come Proserpina, indipendenti come Lady Lilith (per fermarsi a tre icone di Dante Gabriel Rossetti, forse il massimo codificatore del modello): le due o tre generazioni successive, sull’onda di nuove paure (l’inquietudine per le battaglie femminili contro pastoie sociali e istituzionali, i timori nazional-eroicistici sull’indebolimento del maschio, eccetera), le trasformeranno in tante vampire.
La storia di come si siano intrecciati e tramandati i lasciti delle immagini arcaiche è soggetto di notevoli studi. Per esempio dal mondo vittoriano in cui vede il suo definitivo affermarsi, l’archetipo del licantropo è oggi più che mai attuale. Nel Satyricon petroniano troviamo il celeberrimo episodio del lupo mannaro, prima testimonianza narrativa in occidente di licantropia quale mutazione involontaria, e una situazione analoga è presente anche ne L’asino d’oro di Apuleio, episodio che definisci come un «pulp fulminante». Ma i primissimi accenni a questa icona dell’immaginario popolare si hanno già nell’antico Egitto attraverso la figura del dio mutante Anubi dalla testa di sciacallo. Trovi che si possa stabilire un fil rouge con il lupo mannaro oppure ritieni che questa prima forma egizia sia troppo embrionale?
La domanda è molto bella perché fa dialogare il tema lupesco che corre in forme diverse in tutto il Satyricon con le fantasie egizie dell’Asino d’oro… Diciamo che il nesso è indiretto. La facies animale degli dei egizi attiene a una dimensione essenzialmente simbolica, e ritualizzata poi con maschere in certe celebrazioni isiache, ma non si pensa a una condizione metamorfica. Per contro è vero che i canidi – lupi, sciacalli, i cani stessi al di là di ogni giulebbosa retorica sul “miglior amico dell’uomo” – sono associati alla sfera infera almeno dall’immaginario neolitico in avanti: nell’Odissea c’è l’episodio tenerissimo del cane Argo, ma c’è anche il mostro Scilla dal cui tronco femminile si diparte un viluppo di teste di cane (e non a caso imparentato con l’infera Ecate, a sua volta accompagnata da una pluralità ululante e notturna di cani). Il cane custodisce la casa ma anche le soglie degli inferi; i cani vagano sui cambi di battaglia sbranando i cadaveri… Questa tradizione dei cani della morte sopravvive per esempio nel folklore inglese, e Conan Doyle la riprende magistralmente col suo capolavoro sul cane (non mastino, come spesso viene tradotto “hound”) dei Baskerville.
Tornando al lupo e anzi ai lupi del Satyricon – fino all’immagine imbestiata dei cannibali, homo homini lupus, con cui l’opera sopravvissuta si conclude – quest’eco infera è chiara. Sul lupo, animale paradigmaticamente odiato e ammirato, associato a fondatori di regni o sterminato – ancora nell’ottocento – con un sadismo non spiegabile in termini di semplice ostilità verso il predatore delle pecore, grava dunque questo peso simbolico ancestrale. Evidente ancora nelle comparsate di lupi delle fiabe: in fondo è un paradosso che un predatore ben più pericoloso, l’orso, sia associato nelle nostre fantasie a qualcosa di tenero e coccoloso, mentre il lupo fa sempre una pessima figura. Gruppi di guerrieri-lupi, e fenomeni di licantropia rituale – in cui il soggetto “si sente” lupo – sono attestati presso le civiltà più varie. La fine di questi mondi arcaici condurrà i loro ultimi epigoni al triste status di presunti servi del diavolo da bruciare, criminali o pazzi da internare: sono i licantropi miserabili dei processi europei celebrati ancora nella prima età moderna, e quelli poi studiati dagli alienisti.
Vorrei porti un’ultima domanda a proposito di quella misura, di Libertà e Bellezza, che intendi come necessaria per leggere le coordinate di una società liquida in continua trasformazione. Alcune delle opere maggiormente significative dell’immaginario moderno, capaci di rivaleggiare per valore mitico con le grandi icone classiche, vedono la luce durante la pruriginosa epoca vittoriana, vero e proprio bacino di desideri e incubi che matureranno poi nella realtà che conosciamo. Pensando alla Alice di Lewis Carroll e al Peter Pan e ai suoi bambini perduti di James Barrie, rimaniamo sbalorditi di fronte al loro peso conturbante e sessualmente latente. In quel lontano ottocento in cui tutto era peccato, al reverendo Carroll sono state possibili cose – come per esempio fotografare centinaia di bambine spesso nude – per le quali oggi sarebbe immediatamente tacciato di pedofilia, così come l’anarchica ribellione del solitario e crudele Peter Pan verrebbe accusata di non essere “politicamente corretta”. Alla luce di questo evidente paradosso, quale peso ponderale pensi abbia oggi la potenza dell’immaginario, e in che modo è ancora in grado di incidere nella realtà? In sostanza, la capacità salvifica del mito nei confronti dell’anestetizzazione del Bello avrà ancora l’ultima parola?
Mah, in realtà credo che proprio sull’immaginario si giochi oggi una partita fondamentale, a livello personale e interiore come collettivo, sociale, politico. Mai come oggi l’uomo ha potuto disporre di mezzi di comunicazione così sofisticati e pervasivi, in grado di veicolare in modo morbido e inavvertito visioni anche radicalmente deumanizzanti. Lavorare sull’immaginario, dissodarlo, è dunque vitale: sia per smontare e analizzare quello che ci viene di continuo calato addosso, magari pericolosamente velato sotto ogni soglia critica; sia per elaborare immaginario in forme sane, di resistenza culturale e macchine per pensare. Da un immaginario imposto, subìto, a un immaginario insomma strumento di libertà: come quello che per esempio ha prodotto nel tempo la grande letteratura. Che ci fa un gran bene, e ci costringe in fondo a ricordare chi siamo. Cioè esseri umani.