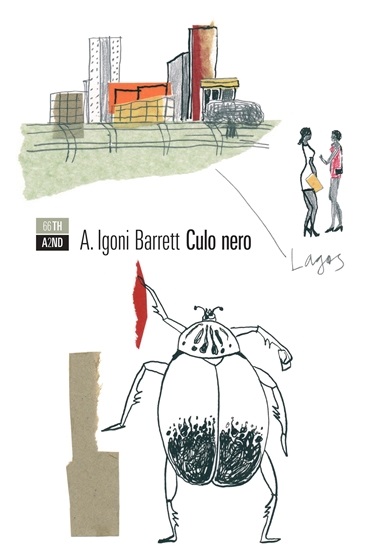Nel 1966 Fernanda Pivano intervistò per la Rai lo scrittore americano Jack Kerouac: quel giorno, gli spettatori italiani speravano di ascoltare le parole del nuovo eroe contemporaneo. Ma davanti a loro, c’era invece un uomo completamente sbronzo, e oltre quella ubriachezza, con una maggiore attenzione, si poteva intravedere anche qualcosa di più ampio: il sentore della distruzione. Del resto la madre di Kerouac aveva appena avuto un ictus e ritrovarsi a discutere per la televisione italiana di On the Road era probabilmente l’ultima cosa che avrebbe voluto fare.
Eppure bisogna riprendere quella intervista, perché ancora oggi il romanzo, che rese celebre lo scrittore in tutto il mondo, riesce a fare parlare di sé: nel 2016 la Mondadori ha pubblicato la prima versione di On the Road. Il “rotolo” del 1951 (nella traduzione di Michele Piumini). La leggenda vuole che il giovane Kerouac abbia riscritto completamente l’opera, pubblicata nel 1957, solo dopo avere ricevuto una lunga lettera dall’amico Neal Cassady: fu in quelle pagine, dunque, che lo scrittore ebbe l’intuizione dello stile beat. La versione originaria, che viene finalmente pubblicata per la prima volta in Italia, fu invece composta di getto sopra un rotolo di carta, ma senza che lo scrittore padroneggiasse ancora quello stile che gli giunse poi come un’illuminazione.
Rimane allora aperta una questione critica importante: benché il romanzo sia diventato anche il manifesto dello stesso movimento beat, come bisogna inserire quella singolare esperienza nella poetica generale di Kerouac? A questa domanda, Kerouac risponde una prima volta di avere scritto On the Road esclusivamente perché: «Ero giovane […] E avevo bisogno di 2000 dollari». L’alcol però c’entrava poco, perché di nuovo con estrema lucidità ribadisce la stessa cosa più avanti nel 227th Chorus della raccolta poetica Mexico City Blues (Newton Compton, 2006):
«e sono stato pagato
per un lavoro fatto
quand’ero giovane […]».
L’opera alla quale lo scrittore era meno legato sarebbe allora la testimonianza di un fallimento interiore, non della possibilità del viaggio. Un’intera generazione aveva sognato di mettersi sulla strada senza direzione: Kerouac sembrava cioè indagare l’archetipo umano per eccellenza. Ma grazie al confronto diretto tra la prima versione e quella definitiva, scopriamo invece che non era questo ciò che voleva dirci: esisteva al contrario per Kerouac una meta precisa da seguire, uno speciale principio di imitazione che si personificava nella corporalità di Neal Cassady. Ecco cosa rappresenta davvero On the Road: una tensione fallimentare verso l’ideale. E insieme, quella ricerca finale del padre che Cassady non troverà mai, la consapevolezza spaventosa del superamento di ogni ideale e la ricerca consequenziale di una regressione impossibile alla condizione precedente dell’idealista, perché come scrive anche nel 33rd Chorus:
«[…] Sono un idealista
che ha superato
il mio idealismo
non ho niente da fare
per il resto della vita
tranne che fare niente
e il resto della vita
per farlo».
E allora il cerchio come una simbiosi si completa: Cassady cerca un (o il) padre, commette cioè una regressione verso il fagotto di credenze che ha lasciato sulla strada quando invocava la liberazione dell’anima, ma che ora ha perso per sempre (eppure non può tornare indietro, perché dentro il riformatorio dove lo avevano sbattuto per l’intera giovinezza, ha creduto con tutto se stesso all’allucinazione della libertà); Kerouac invece, che non aveva mai voluto o potuto lasciare niente, colma il nuovo vuoto con la persona di Neal, si identifica con Neal, ma non sarà mai Neal. Anzi, prima ancora di cominciare, sa bene che il vagabondare eterno non ha una risposta definitiva: «Ma prima o poi ci sarà una nuova generazione di giovani che svegliandosi dal torpore, nel quale il potere li ha intrappolati, rovisteranno nelle soffitte impolverate dei loro genitori e troveranno uno zaino e un sacco a pelo e a questo punto andranno “lungo la strada” a riprendere il cammino interrotto».
È lo zaino di Kerouac, il quale tornerà a vivere da sua madre. Ma anche quello di Neal Cassady, che muore assiderato lungo le rotaie di un treno. L’immagine si nasconde forse dietro un’atmosfera di poeticità: ma bisogna guardare oltre, verso il non detto. Tutti i giovani proveranno prima o poi «il desolato stillicidio della vecchiaia», ognuno di loro sarà di nuovo «genitore» un giorno. E l’eredità continuerà senza sosta, una strada dopo l’altra, di generazione in generazione: ma nessuno, nessuno riuscirà mai a capire dove il padre di Neal Cassady si trovi nascosto.
A questo punto è quanto mai necessario riallacciare l’esperienza della Beat Generation a quella della poesia francese maledetta, e in particolare alla scrittura di Rimbaud e Verlaine. Il movimento viene fondato alla Columbia University per opera di Lucien Carr, che cita come principio base della «Nuova visione» proprio «lo sregolamento di tutti i sensi» rimbaudiano, assieme alla nuda espressione del sé: ma la base psicologica gioca in questa liberazione spirituale uno degli elementi chiave. Così come per Verlaine, Kerouac infatti rimase ancorato a una morale individuale che non riuscirà mai a trascendere definitivamente e che anzi condizionerà tutta la propria esistenza (che coincide con la produzione letteraria). Il romanzo postumo Pic: storia di un vagabondo sulla strada doveva terminare con l’incontro, dopo l’immenso vagabondare, tra i protagonisti del libro e quelli di On the Road: Sal Paradise e Dean Moriarty. Tuttavia la madre di Kerouac, che non approvava questo finale, costrinse il figlio a rielaborare la vicenda: nella nuova versione Pic e il fratello maggiore, assieme alla famiglia della compagna, cominciano una vita sicura a San Francisco, dove trovano lavoro. In senso più ampio, è evidente come la morale familiare eserciti sullo scrittore una pressione tale, da soffocare ogni possibilità di liberazione spirituale: piuttosto meglio il lavoro appunto, una casa, la sicurezza economica.
Kerouac rimarrebbe allora soltanto il teorico del lento passaggio dalla Nuova visione alla forma estetica beat: «Voglio essere considerato un poeta jazz che suona un lungo blues in una jam session d’una domenica pomeriggio» scrive in apertura a Mexico City Blues. Liberare la coscienza era cioè l’unico espediente di sincerità artistica: per esprimere la coscienza invece, bisognava trasformare la scrittura stessa in una suonata jazz. Ma poi quando cerca di vivere isolato sopra una montagna come un bhikkhu, viene colpito da «una crisi di abbandono» e si trasferisce a casa di Neal Cassady dove scrive il romanzo Angeli di desolazione; ci riprova nel 1960, nella baita di Lawrence Ferlinghetti vicino a Big Sur, ma questa volta, rimasto solo, ha le allucinazioni e scappa a piedi, di notte, lungo le pendici della catena montuosa: dopo una sbronza, torna nuovamente a casa della madre. La forma musicale permane, la liberazione della coscienza si scontra invece con la realtà dell’uomo Kerouac.
Ma come dicevamo all’inizio, la stessa idea dello stile beat nasce grazie alla lettera di diciotto pagine che Neal Cassady gli scrive sotto l’effetto dell’anfetamina nel 1950 e che lo porta a una riscrittura completa, in sole tre settimane, del primo vero romanzo del movimento: On the Road. Non bisognerebbe neppure dimenticare una solida base intertestuale, fino a considerare una possibile iniziazione stilistica anche nella lettura del Céline di Viaggio al termine della notte o nel Joyce dell’Ulisse.
Ecco quindi riaffiorare puntualmente Neal Cassady e la madre, la madre e Neal Cassady: l’idealismo e la morale di Kerouac non trovano mai una via d’uscita personale, una boccata d’aria. «Per me l’unica gente possibile sono i pazzi, quelli che sono pazzi di vita, pazzi per parlare, pazzi per essere salvati, vogliosi di ogni cosa allo stesso tempo, quelli che mai sbadigliano o dicono un luogo comune, ma bruciano, bruciano, bruciano, come favolosi fuochi artificiali color giallo che esplodono come ragni attraverso le stelle e nel mezzo si vede la luce azzurra dello scoppio centrale e tutti fanno Oooohhh!»: è l’occhio dello scrittore a parlare, una confessione senza mezzi termini dove l’interesse si concentra sempre all’esterno, mai all’interno, sulle persone che sono come Kerouac vorrebbe essere, non su come Kerouac effettivamente è. Anzi, quando poi ci prova anche lui a saltare da una stella all’altra scrive: «A me piacciono troppe cose nello stesso momento e mi ritrovo sempre confuso e impegolato a correre da una stella cadente all’altra finché non precipito». Nessuna danza rimbaudiana, ma solo confusione, distruzione.
E così, mentre Ginsberg e Burroughs utilizzano la droga per ampliare la percezione del reale, quando Neal Cassady, muore Kerouac si getta avidamente nell’alcol; quando la madre si ammala, Kerouac peggiora. Beve fino alla morte non per raggiungere una visione particolare, ma perché:
«Tutti prendiamo qualche scorciatoia
per la Valle della Morte […]»
(9th Chorus, Mexico City Blues)
E nemmeno nel «sesso libero» Kerouac trova una sicurezza. Come per Fitzgerald negli anni venti, la liberalizzazione sessuale americana non riesce a convincere davvero lo scrittore. Sulla strada verso casa incontra Beatrice Kozera, la ragazza messicana con cui ha una relazione amorosa per quindici giorni e che segue a lavorare nei campi di cotone; vivono insieme in una tenda e per Kerouac sono i giorni più felici della sua vita. Senza una spiegazione però, torna di nuovo dalla madre: sembra come se una qualsiasi felicità significhi anche l’allontanamento dal nido famigliare, e questa contrapposizione tra guadagno spirituale e rinuncia morale non gli sembra possibile. Ancora un altro esempio: nel 1953 conosce Alene Lee, ma quando l’amico Gregory Corso gli confida di esserci andato a letto, Jack in lacrime scrive il romanzo pessimista I sotterranei e nel 5th Chorus della raccolta poetica afferma poi lapidario: «Io non sono Gregory Corso».
Insomma, da qualsiasi angolazione ci si avvicini a Kerouac, ogni volta la sensazione è quella di ascoltare qualcuno che descrive come necessario ciò che però non riesce a concretizzare nemmeno lui. Ed è questa forte umanità o mancata perfezione a costituire la forza principale della poetica kerouacchiana: Ginsberg o gli altri personaggi beat si concentrano sulla realizzazione spirituale, scrivono dalla vetta della montagna. Ma come arrivare fino al traguardo, è una storia di coraggio che riguarda soltanto Jack Kerouac: sulla strada e non la strada – lungo la strada quindi. Eppure senza la ricerca fallimentare di Moriarty Senior, non ci sarebbe mai stato l’Urlo dalla cima, perché prima delle nuvole:
«Sono stato io il primo pazzo
che ho conosciuto».
(88th Chorus, Mexico City Blues)