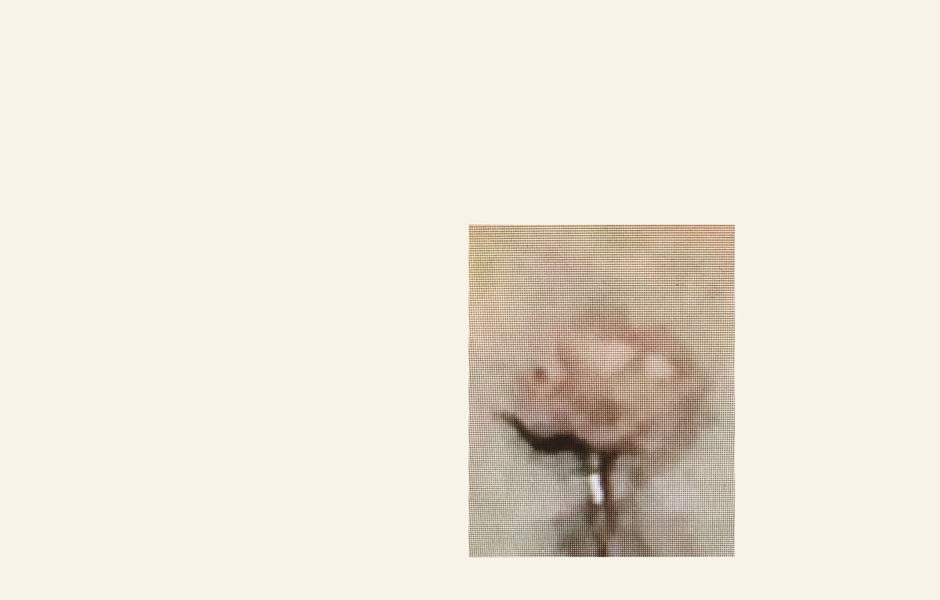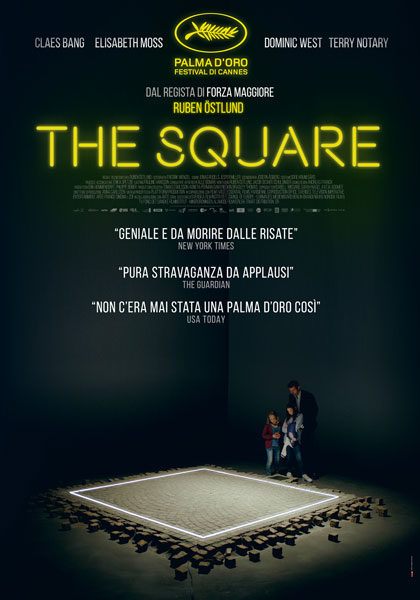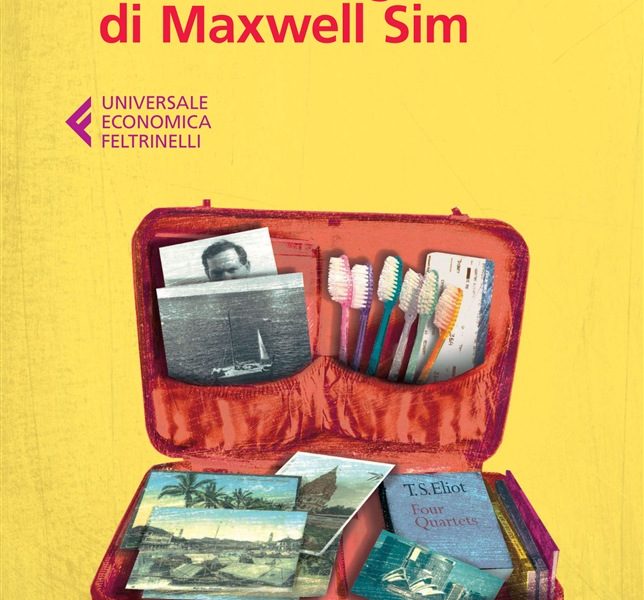Ann Patchett è una libraia. E questo ha un significato. Almeno per me, che, scollata di miglia e di mari da Nasheville e dalla sua Parnassus Books, metto in scena da anni lo stesso mestiere.
Significa ossessione e condanna; redenzione e supplizio. Oppure noia e aria sciatta. Tutto nella condensa macchiata di mani di una creatura chiamata libro. Un corpo a forma di storia.
Significa sempre pensare a chi legge. Perché su ogni scaffale c’è un condominio di ipotetici consigli.
L’appiglio del giorno, la soluzione della notte. Così quando ho scoperto che l’autrice di Il bene comune (Ponte alle Grazie, 2017) non ha deciso “solamente” di scrivere romanzi, ma anche di venderli, mi è sembrato un compimento perfetto. Un circuito virtuoso e autoinnaffiato.
Vicenda corale, articolata e semplicissima. Il rompicapo quotidiano e inestricabile di una famiglia americana. Parte da lontano la trama. Da una festa di battesimo californiana. Da grovigli di scarpe e coreografici abbracci. Fix e Beverly hanno invitato molto più del loro quartiere per l’arrivo di Franny. Secondogenita tonda e chiarissima. Lui è un poliziotto, lei è meravigliosa. Talmente tanto che per l’evento trova modo d’imbucarsi anche Albert, viceprocuratore ben lontano da ogni lista d’inclusione. In ufficio fiuta il miele dell’incontro e si presenta alla porta senza l’affanno dei preamboli. Lui ha già tre figli. E una moglie, Teresa, con la pancia impegnata dal quarto fagotto. Eppure, quel pomeriggio alberato d’aranci, con la casa allagata di gente, proprio niente gli impedisce di raggiungere Beverly nella stanza appartata e di baciarla, con la neonata in braccio.
Da lì gli avvenimenti scrosciano. Quello non è solo uno scontro fortuito. Ma il debutto di una collisione astrale. Quel minuscolo faticatissimo ordine deflagra di colpo, perché Albert e Beverly si amano davvero. E si sposano. Le due tribù di figli sono perciò costrette a unirsi ed è ben facile desumere che ne derivi un pandemonio.
Genitori distratti, assordati dalla scia della loro stessa vita, dispersa nei trasbordi tra la Virginia e Los Angeles. E ragazzi allo sbando, disciplinati soltanto dagli editti dei fratelli maggiori. Sono cani eccitati, in pasto a qualunque occasione. E per rabbonire Albie, il più piccolo, il più scomodo da trascinare in giro, gli antistaminici si usano come caramelle.
Attraverso continui salti temporali, Ann Patchett riassesta il mosaico in cui tasselli distanti coesistono e si annusano. Seguiamo la vicenda di Franny, cresciuta carina ma non abbastanza da credersi tale, cameriera eternamente sospesa che una sera impatta in un cliente eccezionale, l’uomo di cui ha letto ogni successo.
Non occorrono avvitamenti tattici, prodezze da escapologo.
È tutto fin troppo fluido e ben presto la ragazza si ritrova promossa a musa ispiratrice del suo anziano
scrittore preferito.
Così quell’infanzia deragliata, le faglie dei lutti, le bravate spinte all’estremo, la morte di Cal ancora nebbiosa, piantata nel cuore di Teresa come un seme di spine, scolano dirette nei racconti che Franny riserva al suo compagno romanziere, e diventano un titolo, una vicenda di carta chiamata proprio Il bene comune. Così quel terreno di esperienze annodate controvoglia si trasforma in un bestseller da cui addirittura deve sgorgare un film. Dove i veri protagonisti della storia si ritrovano loro malgrado, nudi, eterni e deformati. Così come succede quando reale e verosimile sembrano esistere solo per diluirsi a vicenda.
Ann Patchett scoperchia con fare chirurgico un magma familiare debordante e frequentissimo, l’arcipelago non più nuovo di nuclei complessi, dove i ruoli si assottigliano e si moltiplicano, dove le architetture degli affetti si affastellano all’infinito e reperire Il bene comune vuol dire andare a caccia di stelle scalciando sott’acqua.
Gli esempi editoriali non mancano. L’età ingrata di Francesca Segal, Famiglia, femminile plurale di Emilia Marasco o l’eccellente Una famiglia americana di Joyce Carol Oates sono pugni sull’ordine agognato.
Il peso delle “libere” scelte adulte spiove sui figli in modo inappellabile, depositando ansie, fratture, sedimenti inespressi. Resiste sempre nell’altro più intimo (che sia figlio, genitore o fratello) una traccia insondata, inaddomesticabile e forse solo la vecchiaia, l’ultima corsa verso l’uscita rappresenta l’appuntamento col perdono o quanto meno col trasversale umanissimo senso d’impotenza.
Agli anni non importa di essere clementi, loro grondano e modellano, segano cime, cementano prati, invecchiano e affossano.
Nell’erosione ineluttabile si riscopre Fix alla fine del viaggio, malato e sfinito, accompagnato dalle figlie per il suo presunto ultimo compleanno alla prima di quel lungometraggio in cui si riscodella il suo dolore, il terremoto dei divorzi e dei distacchi, il cataclisma di un amore che si giurava imperturbato. E quando padre e figlie sono appese a quell’ultimo gancio Franny scocca il suo rimpianto, l’amarezza cosciente di una perdita che oltrepassa quel guscio indebolito: «Tutte le storie se ne vanno con te, pensò Franny chiudendo gli occhi. Tutto quello che non ho ascoltato, che non riesco a ricordare, che non avevo mai capito, che non ero lì a vedere. Tutte le strade che portano a Torrance».
(Ann Patchett, Il bene comune, trad. di M. Baiocchi e A. Tagliavini, Ponte alle Grazie, 2017, pp. 332, euro 16,80)