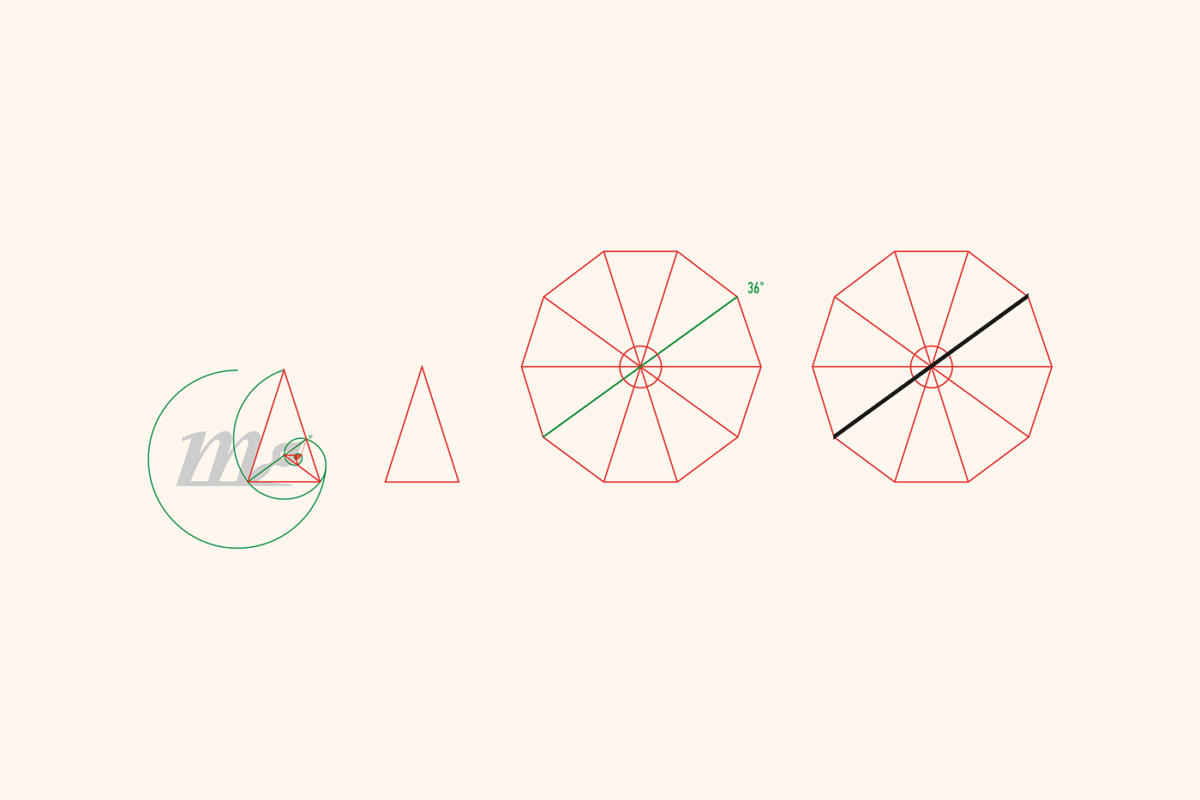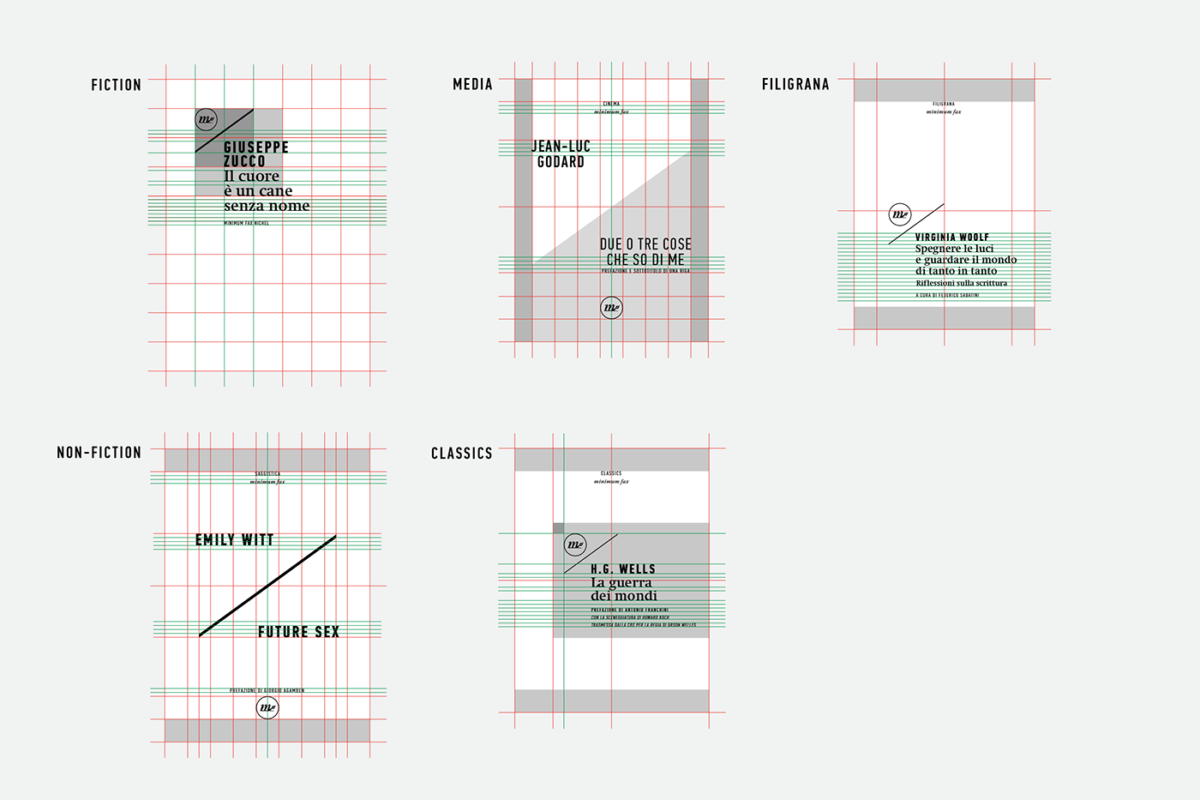Donald Barthelme non è uno di quegli scrittori di cui sentirete facilmente parlare. Nonostante l’estrema originalità del suo stile, non è stato riscoperto che recentemente, a causa dell’esplosione di un altro grande scrittore, lui sì, mediaticamente molto appetibile, che ne è allievo: David Foster Wallace.
È proprio da Barthelme che Wallace ha appreso l’infinità di potenziali strade che l’umorismo rende percorribili, e sebbene abbia un rapporto complicato, per non dire combattuto, con l’umorismo, non ho difficoltà a definire l’ironia di Wallace barthelmiana.
Infatti, proprio come nel caso di romanzi classici quali Vita e opinioni di Tristram Shandy e il meno conosciuto Il buon soldato Sc’veik, l’ironia non è soltanto un modo di raccontare, ma una via per giungere alla deformazione della realtà e spesso, di pari passo, della forma-racconto e della forma-romanzo. Parliamo di ironia, quindi un altro campo rispetto alle speculazioni pirandelliane su comico e umoristico.
Si tratta dunque di un realismo deformato (qui participio passato), che, attenzione, non va confuso col sur-realismo onirico di scrittori come Raymond Queneau: scrittori che si muovono in un ambito sfumato, letterariamente intellettuale e senza nessuna pretesa di raffigurazione anche solo verosimile. Procedono con accostamenti inconsci che assurgono a quasi-allegorici-o-meglio-simbolici all’interno della forma-testo, il cui flusso è comunque sempre il regolare flusso narrativo della storia, sebbene particolarmente colorito. Lo scopo non è decostruire, la parodia è estranea a un testo come I fiori blu, la cui chiave di lettura andrebbe piuttosto cercata in un gioco letterario-filosofico-psicanalitico che fa dello slittamento freudiano una strategia narrativa.
Non accade così con Barthelme. La sua ironia scaturisce dallo straniamento che riesce a costruire, partendo da premesse verosimili, in una maniera perfettamente speculare e simmetrica a quella di un autore come Kafka, anche se, va detto, non si tratta del todoroviano fantastico (rovesciato in Kafka). Barthelme è in questo senso allievo del gioco intellettuale di scrittori come Sterne e Gogol’, ed è facile notare una certa filiazione con un racconto come Il naso, sebbene Barthelme vada oltre il mero impiego occasionale di questo elemento fantastico, e costruisca sistematicamente le proprie narrazioni, perlopiù brevi – come fosse, ogni racconto, un diverso esercizio di stile –, non rispettando altro che una sostanziale anarchia della prosa, con un andamento sintattico che potremmo definire cubista, quando non astratto (e c’è, forse, dell’astrattismo, la stessa volontà di situare la creazione dell’opera nell’immediato e irripetibile atto della scrittura, scagionando qualunque progettazione), fino al punto di rendere l’opera quasi irricevibile («entra il cuoco col roastbeef, strappa alla madre la coppetta d’argento e ne beve una sorsata, senza smettere di fissare negli occhi la sua amante. L’amante del torero passa la cinepresa alla madre del torero […]») – certo impossibile da decodificare secondo i criteri tradizionali – e tuttavia riuscendo comunque a darle – qui la sua grandezza di scrittore – un’impronta autoriale, a far sentire la propria voce. Dove voce non sta solo per stile, ma anche per presenza. La propria presenza empirica, corporea, resa attraverso le frequenti rotture della quarta parete che fanno dell’autore stesso (autore modello, per dirla con Eco) un personaggio dei propri racconti.
Racconta John Barth – un altro importante scrittore maestro di Wallace – che alla domanda di una studentessa: «Perché scrive come scrive?», (tautologia che sembra fuori luogo a chiunque non abbia letto Barthelme: costoro la comprenderanno perfettamente) Barthelme abbia risposto: «Perché Samuel Beckett ha già scritto quel che ha scritto». È questo un aneddoto molto interessante che aiuta a inquadrare Barthelme nel solco di quella stessa ricerca che Beckett, che pure aveva un rapporto diverso con l’umorismo, compie sul linguaggio. Ricerca non costruttiva, ma destrutturante tanto del senso, in polemica come Sartre (così almeno dice Adorno), quanto perfino dei sensi: arrivano a essere colpiti i dialoghi finanche i morfemi (Hamm, per fare un esempio, mutilazione beckettiana di Hamlet, un procedimento simile a Malone, M-alone, M solo, secondo Frasca). È infatti il linguaggio, prima che il testo (ma sarebbe meglio dire: la dimensione testuale) a essere al centro dell’opera di decostruzione di Barthelme. Eccone degli esempi, tratti dalla raccolta Dilettanti (minimum fax, 2015):
«Alcuni di noi avevano minacciato il nostro amico Colby già da tempo, per via di come si comportava. E adesso aveva esagerato così abbiamo deciso di impiccarlo. Colby sosteneva che solo perché aveva esagerato (e non negava di aver esagerato) non significava che dovesse essere sottoposto a impiccagione. Esagerare, diceva, è una cosa che capita a tutti, prima o poi. Non abbiamo prestato molta attenzione alla sua difesa. Gli abbiamo chiesto che musica avrebbe voluto alla sua impiccagione. Lui ha detto che ci avrebbe pensato su ma che ci avrebbe messo un po’ a decidersi».
«Il presidente osservò che alla finestra c’era un uomo che guardava dentro. I membri del comitato volsero gli occhi in direzione della finestra e constatarono che l’informazione del presidente era corretta: alla finestra c’era un uomo che guardava dentro. Il sig. Mackey presentò una mozione affinché il fatto fosse messo a verbale. Il signor O’Donoghue l’appoggiò. La mozione fu approvata. La sig. Brown si chiese se non fosse il caso che qualcuno di loro uscisse per parlare con l’uomo alla finestra».
«E così ho comprato una cittadina (Galveston, Texas), e ho detto a tutti che potevano restare, sarebbe stata una cosa graduale, molto rilassata, senza grandi sconvolgimenti dalla sera alla mattina».
«Dov’è mia figlia? Perché è là? Quale errore cruciale ho commesso? Ce n’è stato più di uno? Perché mi sono fatto carico di un compito al di sopra delle mie capacità? Essendomi fatto carico di un compito al di sopra delle mie possibilità perché lo perseguo con tutto l’entusiasmo di qualcuno che si ritiene in grado di portarlo a termine?»
Questi quattro incipit ovviamente non forniscono che una vaghissima idea del genio immaginifico di Donald Barthelme, ma possono forse essere lo spunto per qualche considerazione. La prima: la presenza quasi tangibile dello sperimentalismo joyciano. Nell’albero genealogico di Barthelme c’è molto dello sprezzo di Joyce per la convenzione in quanto tale, l’amore sadomasochista per la scomposizione (creativa, non negativa come Beckett né meta-teatrale come Ionesco) del racconto tradizionale attraverso l’esaurimento di ogni tecnica, il saturamento di ogni canone. Sebbene, questo è importante notarlo, l’operazione fosse per Joyce parte di un percorso duro e accidentato, che culminava nella distruzione completa, a livello anche sintattico, con Finnegans Wake, un percorso verso l’oblio simile all’evoluzione del teatro beniano («Lacan faceva dell’inconscio un linguaggio, io faccio del linguaggio un inconscio») che arriva a trascendere il significato e l’azione; laddove invece, per Barthelme non è che un modo di procedere, un ritmo. Incomprensibile, conturbante, alienato, ma costante: siamo lontani dalle fantasmagorie verbali wallaciane o anche solo dall’intellettualismo meta-letterario (e, dispiace dirlo, a volte pedantemente manierista) di un pur simile John Barth. Il testo qui implode; il racconto, rifiutando di creare un’aspettativa, e prendere posizione di fronte alla totipotenza, si avvolge su se stesso, i significati sono sostituiti da altro: il gusto morboso per l’elencazione, la ripetizione con varianti, la parodizzazione, lo scherno, la rottura della quarta parete, il rimestare nella spazzatura culturale, rielaborata alla maniera della pop-art come materia letteraria e inscritta nel racconto. La forma scavalca e prevarica ogni possibile contenuto, la forma diventa totalizzante.
C’è molto di Joyce ma anche di Beckett. I racconti di Barthelme hanno qualche lampante parentela con le prose beckettiane, i “testi per nulla”, racconti-non-racconti in serie, estremamente oscuri, estremamente più seriosi, ma simili per intenti. Ma se Beckett decostruiva il linguaggio attraverso l’astrazione, l’allontanamento, l’oscurità della raffigurazione, Barthelme lo fa piuttosto scivolando nell’assurdo, esprimendo l’insensatezza, con la sintassi impeccabile, perfetta, che scorre verso il grottesco, mentre l’assurdità si palesa sempre più, fino al culmine: ecco il finale del racconto Il pallone, in cui un gigantesco pallone si ferma nel cielo di New York, oscurando anche il sole. I cittadini rinunciano presto a comprendere il significato del pallone, preferendo darne ognuno la propria versione, esplorando la propria interiorità. Quella che sembra a tutti gli effetti essere un’allegoria dell’impossibilità di cogliere il Senso, si conclude così: «Ci incontrammo sotto il pallone, al tuo ritorno dalla Norvegia. Mi chiedesti se era il mio; ti risposi di sì. Il pallone, dissi, è una spontanea apertura autobiografica, connessa con il disagio da me provato in tua assenza, e con l’astinenza sessuale, ma ora che il tuo soggiorno a Bergen è terminato, esso non è più necessario e neppure pertinente. Rimuovere il pallone non fu difficile: autofurgoni con rimorchio portarono via il telone ormai sgonfio, che ora giace in un magazzino nel West Virginia, in attesa di un nuovo periodo d’infelicità. Un giorno, chissà, quando io e te avremo litigato».
Siamo chiaramente al di là di Barthes, nello sconfinato deserto postmodernista, in cui, superato ogni limite, la sola possibilità è cercare di ri-flettere la realtà, come David Foster Wallace, tenendoci a distanza tramite il dispositivo dell’ironia; o cercare, ricostruendo i limiti, di salvare il linguaggio dalla pena capitale cui sembrava destinato: spezzato, deflagrato in Beckett; parodiato, ridicolizzato (a volte in modo fastidiosamente didascalico) in Ionesco, qui torna con una nuova consapevolezza. Inseguendo la realtà si è esaurita ogni forma, e, scagionata la trama (Woolf, Mansfield, per dirne solo due), ed esaurita ogni strategia fino all’esplosione definitiva (Joyce; il nuovo linguaggio di Finnegans Wake), mentre molti postmodernisti, invece di sostare davanti alle rovine, ripercorrono vecchi sentieri: il realismo Roth, la distopia DeLillo, il racconto fantastico (termine qui usato in modo improprio e non-todoroviano) Pynchon; Barthelme non si scoraggia, e, chinandosi sulle rovine del linguaggio, ne raccoglie i pezzi, li colleziona, li assembla.
Ne risulta una scrittura bizzarra, consapevole, autoironica, caleidoscopicamente eterogenea. Ciò che ci comunica, ciò che rappresenta l’ironia di Barthelme è ciò che davvero siamo, o siamo stati. Siamo ciò che mangiamo e dunque ciò che defechiamo. Ciò che rifiutiamo: qui inteso in senso letterale, ciò di cui facciamo rifiuto; questo Barthelme l’ha sempre saputo, e ne ha fatto un’opera d’arte.