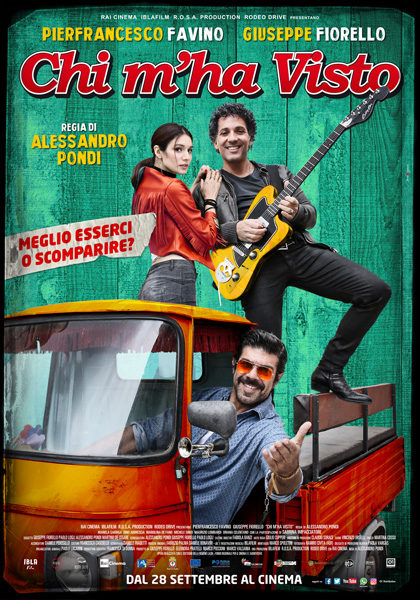Roma è stata la penultima tappa del Transeuropa Discovery Tour, un laboratorio itinerante che Giulio Milani – editore di Transeuropa – accompagnato dalla sua famiglia, ha portato avanti per oltre un mese, andando alla ricerca di nuovi scrittori e nuove scritture. E visto che a Flanerí ed effe piace fare scouting, ho deciso di andare ad assistere alla serata romana e scambiare due chiacchiere con l’editore. Ci incontriamo a “La pecora elettrica”, una libreria-caffetteria di Centocelle all’angolo di un palazzo di fronte un parco urbano costeggiato da pinserie (dove si mangia la pinsa: un prodotto della panificazione diffusosi recentemente, ma che si rifarebbe a una tradizione tanto antica da risalire a prima dell’introduzione del pomodoro sulle nostre tavole). Lì, tra una mediterranea oliva e una monastica birra, chiedo a Milani come si guida quel furgone camperizzato da cui l’ho visto scendere poco prima. Sorride, e mi racconta che hanno rischiato di non partire, perché quello è un vecchio furgone postale tedesco e sono stati costretti ad attendere fino alla fine di luglio per avere le targhe.
Fortuna che la burocrazia non vi ha fermati e che il 1° agosto siete riusciti a partite per questo laboratorio itinerante. Il progetto è quello di andare in libreria, incontrare scrittori e, va da sé, anche lettori per avere un confronto diretto sui manoscritti.
Sì, questo perché la casa editrice ha sempre fatto scouting: Transeuropa nasce nel segno di Pier Vittorio Tondelli, e conserva tutto lo spirito di ricerca che lo caratterizzava. Una ricerca di narratori che Tondelli spingeva sino ai ventenni, e nessuno ai suoi tempi ricercava e pubblicava autori così giovani. Invece lui, ricordandosi di come era andata nel suo caso – pubblicò Altri libertini a venticinque anni – decise di aprire un laboratorio che aveva già proposto a Bompiani e Feltrinelli, ma che i due editori non ebbero il coraggio di organizzare. Fu quindi la Transeuropa ad attivarsi, lanciando un concorso che coinvolse circa settecento aspiranti scrittori. Ne nacquero tre antologie under 25 che di fatto costruirono gli inizi di quello che sarebbe poi diventato una specie – come lo ha definito ultimamente Carlo Carabba – di genere a sé; quello dell’esordiente. Stiamo parlando degli anni in cui esordiscono Lara Cardella, Enrico Brizzi, prima ancora c’erano stati Silvia Balestra, Giuseppe Culicchia, Gabriele Romagnoli. Ma anche Pino Cacucci ha esordito in quelle antologie. Sono tantissimi, è impossibile ricordarli tutti.
E in questo panorama Giulio Milani dov’è?
Io sono nell’ultima ondata, in quell’antologia uscita dopo la scomparsa di Tondelli. E sono rimasto in Transeuropa a fare il mio apprendistato di editor. Mi interessava e mi piaceva ascoltare i libri degli altri. È iniziato tutto da lì, da questa mia disponibilità a confrontarmi con le scritture degli altri. Nel 2000 Transeuropa era entrata in crisi dopo l’abbraccio e l’unificazione del catalogo con Theoria, Castelvecchi e Costa & Nolan. Massimo Canalini, che partecipò a Transeuropa sin dalle origini, si trovava senza casa editrice; io ero giovane e avevo voglia di lavorare nel settore e gli proposi di rifondarla insieme. E lo facemmo. Poi per una serie di situazioni successive le strade si separarono e nel 2005 decisi di trasferire gli impianti in Toscana
E da quel momento cosa pubblica Transeuropa?
Abbiamo ripreso la ricerca sugli esordienti, sugli emergenti. Pubblichiamo l’antologia I persecutori, che parte da alcune idee di René Girard e le applica alla narrativa in modo consapevole. Lì figurano autori come Helena Janeczek; c’è l’esordio col racconto di Giorgio Vasta, ma ci sono anche Christian Raimo, Francesco Forlani, Marco Rovelli. In altri termini, si realizzano le circostanze per rilanciare, a partire dal 2008, la narrativa: Fabio Genovesi e Giuseppe Catozzella sono i primi due autori che pubblichiamo ed entrambi vanno poi con grandi case editrici e vincono il Premio Strega Giovani. In questa maniera Transeuropa ha riconfermato sin da subito il suo ruolo quantomeno di trampolino di lancio.
Tutto ciò però in maniera statica, non vi siete dovuti muovere con un camper…
All’epoca funzionava ancora il vecchio metodo, che è quello del “me l’ha detto uno scrittore amico”, oppure si scovava tra le riviste. Nel 2011 eravamo a quaranta pubblicazioni l’anno, di cui tredici esordienti assoluti di poesia con la collana Inaudita, che metteva insieme una plaquette di poesia in un formato spillato, possiamo dire da guerrilla, e un CD. Era un connubio che funzionava molto a livello di prenotazioni in libreria, ma non di vero e proprio venduto. Quindi noi avevamo l’impressione di vendere anche la poesia perché prenotavamo molto bene, ma incappammo in quella fase in cui i lettori forti crollarono di 700.000 unità in un colpo solo. Lettori che si pensava fossero passati all’ebook, mentre invece erano semplicemente spariti nel nulla, risucchiati – scoprimmo dopo – dal successo dei social network.
Distratti da altro, insomma: ciò ha danneggiato solo la collana di poesia?
No, anche la narrativa. Pubblicammo Tiziano Scarpa e Carlo Lucarelli, di cui stampammo le scritture per così dire più difficili: il teatro, la sceneggiatura. Ma non funzionarono per via di questa crisi. Perciò pochi anni dopo ci ritrovammo nella situazione di dover interpretare un mercato molto più difficile. Ho passato qualche anno in profondità come un sommergibile, e poi è venuta l’idea di contattare quegli autori che mi mandavano un manoscritto interessante, ma troppo acerbo per essere pubblicato, e di proporgli di partecipare a un laboratorio, come fosse un apprendistato di formazione. Intendo dire che esistono romanzi che nessuno pubblicherebbe come sono perché i loro autori hanno bisogno di ricevere delle indicazioni, di essere orientati, avere delle bussole concrete per potenziare il manoscritto. I risultati sono stati positivi, i laboratori sono cresciuti e ho avuto l’opportunità di valutare, mappare una serie di scritture che prima non avevo l’occasione di considerare. Perciò m’è venuta l’idea di estendere questa cosa a livello nazionale attraverso i laboratori itineranti.
Dunque sono laboratori di autori nei quali riconosci qualcosa da portare a maturazione. È una cosa diversa da una scuola di scrittura creativa? Non lo è?
Non è una scuola di scrittura creativa per tanti motivi. Uno di questi è che non è rivolta genericamente a chi vuole imparare a scrivere un libro. È rivolta a persone che sono già capaci di scrivere un libro, ma vogliono trasformare questa loro passione in una attività professionale vera e propria. Quindi devono trovare quella che è la “necessità di essere letti”, come la chiamo io. Cioè trasformare la voglia di raccontare e raccontarsi nella necessità di essere letti. Così si fa un passetto in più, ma per compierlo occorrono dei saperi. Il laboratorio è un confronto uno a uno con lo scrittore. Questa cosa non la trovi nelle scuole di scrittura: le scuole di scrittura sono aperte a un pubblico, e quando una cosa è aperta al pubblico è tutto più difficile. Poi sono frequentate da altri scrittori, e non è detto che si crei una buona amalgama. Invece nel rapporto uno a uno possiamo ragionare e pensare al libro insieme. Tanti arrivano con un testo e ne escono con una nuova idea, completamente diversa, perché mi hanno raccontato la loro vita, che magari è molto più interessante di quello che hanno nel dattiloscritto.
Perché questo sarebbe un lavoro diverso da quello di molti altri editori?
Perché si ragiona molto sui testi. E questo è di per sé un lavoro che quasi non si fa più. Recentemente Giulio Mozzi ha rilasciato delle dichiarazioni chiare e vere riguardo ai criteri di selezione dei libri, ossia che ultimamente, per fare selezione, gli editori vogliono il libro già bell’e fatto, e lo si valuta in cinque o sei minuti sulla base di opinioni scambiate fra l’editore e il direttore commerciale. E quindi, diceva Mozzi, forse non serve più un editor ma uno statistico.
Questo però rende paludato lo scouting, perché se si ragiona solo sulla base di trend già esistenti si perde ogni possibilità di un guizzo nuovo.
Esatto. Entri in un filone e a quel punto non importa più il tuo livello, importa solo il filone di riferimento, che tira perché c’è una generazione di lettori che lo legge. E quindi la ricerca dov’è? Non ci può essere. E in quei casi non ci può essere – mi viene da dire – strutturalmente, perché comunque chi ragiona in quel modo lavora per case editrici che hanno bisogno di rispettare severamente un conto economico. Perciò non possono permettersi di fare una ricerca in cui una volta può andare bene e un’altra male, devono concentrarsi su quello che già funziona. Io ora mi trovo in una occasione di massima libertà proprio perché ho rinunciato a fare l’editoria tradizionale, che è quella che deve rispettare solo i conti economici, e mi sono messo in cerca io dell’autore.
Ma ricevi solo suggestioni o hai una idea di libro che porti avanti e proponi agli autori?
Ho un progetto, ho una visione, chiamiamola così, ho un’idea di narrazioni che possono essere interessanti. Sul come raccontare il paese, per esempio.
Continua.
Chi lo racconta il paese? E come? Esiste un genere letterario che possa dirci qualcosa di questo paese di cui altrimenti conosciamo le cose solo attraverso la televisione e le inchieste? Sono partito da queste domande per studiare un modo diverso per raccontare l’Italia anche dal punto di vista letterario, e sto cercando persone interessate ad affrontare con me questo percorso, questo – chiamiamolo così – nuovo metodo. Quindi non cerco solo semplicemente nuovi scrittori, ma nuove scritture, cioè un modo diverso da quello che conosciamo, con un nuovo genere.
Un genere che hai in mente ben chiaro?
Certo che ce l’ho in mente, lo lancerò a febbraio con una collana ad hoc che si occuperà proprio di questo genere letterario parente dell’autofiction, che è detta anche io possibile; perciò al momento lo possiamo chiamare realtà possibile.
E lo lancerete a febbraio con una collana il cui nome esiste o lo state ragionando? Come pensi che verrà accolto dal mercato?
Il nome esiste ma non lo svelo. Il filone della realtà possibile è un filone non commerciale al momento, ma che potrebbe avere importanti risvolti commerciali come l’ha avuta l’autofiction con Walter Siti e adesso con Teresa Ciabatti, per esempio.
Allora cosa ti aspetti dall’autunno, finito questo tour, il frutto di questo itinerario quale speri che sia?
Io spero che quelli che hanno assistito ai laboratori prendano spunto dalle occasioni discorsive che abbiamo messo in campo, per riversarle nella pratica della loro scrittura e presentare dei manoscritti che vadano verso le indicazioni ricevute, verso le suggestioni di cui ho parlato con loro rompendo – attraverso questo contatto diretto – l’opacità della macchina editoriale.
Questo tour è un modo per assumere un atteggiamento importantissimo, ossia quello di continuare un dialogo con il me stesso più giovane che ancora pretende che mi indigni per determinate situazioni. Continuo a indignarmi per lo stato dell’editoria e mostro l’esistenza di un’editoria diversa mettendomi sulla strada. Più chiaro di così. Poi puoi dire che uno lo fa per dare visibilità alla casa editrice, mettici quello che vuoi, ma farsi un po’ di pubblicità non basta a giustificare il fatto di prendere la famiglia, i figli, macinare chilometri su e giù per tutta Italia e fare notte fonda in serate performative solo per dialogare con gli scrittori. Devi necessariamente essere spinto da ragioni più profonde.
Tutto ciò raccontando il paese…
Qui si apre un altro discorso importante, che è quello della mappa e del territorio. Molti classici sono bellissimi ma ci raccontano luoghi che non esistono più. Oggi hai davanti un territorio diverso: lo devi rimappare. Sì, è vero che devi conoscere le mappe precedenti, ma devi raccontare un territorio che è quello di oggi, non certo quello di Dostoevskij, di Joyce o di qualunque altro classico. E non puoi nemmeno affidarti agli scrittori del Novecento italiano perché quelli hanno fatto i conti con esperienze diverse, magari con la guerra. Lo scrittore di oggi deve saper leggere i traumi di questa epoca. E dunque il problema vero non è tanto di natura tecnica, ma di natura esistenziale e spirituale; cioè devi decidere, se vuoi fare lo scrittore, di metterti in gioco profondamente. Essere sincero in forma disarmante, una sincerità che ti separa dagli altri, anziché unirti con gli altri. Molti si autoaffondano perché scrivendo volevano fare bella figura in società. Ma allora fai un’altra cosa, fai prima e soffri meno. Perché di qua soffrirai tanto e guadagnerai molto poco. È una cosa difficile, perché più vai dentro la scrittura più è difficoltoso curare le amicizie, la relazione col partner, i rapporti umani in generale, perché devi raccontare delle cose di cui in teoria non dovresti parlare. Sei costretto a dire delle cose che non dovresti neanche pensare.