Altre Narratività
12/L’ultima regione continentale: la Campania
di Eleonora Cugini e Gianluca Bernardo / 10 dicembre
.jpg)
Ripartiamo da Lamezia Terme nella tarda mattinata, dopo aver armeggiato inutilmente con la vespa. Scopriremo solo due mesi dopo, a Roma, che l’intero pacco frizione si è disintegrato, abbassando così ulteriormente la guidabilità del nostro destriero. Quando “er Mariani” – nostro meccanico luminare – ci mostrerà quello che resta del pezzo, la sue considerazioni saranno lapidarie: «Fateje na foto».
Tutto questo, però, noi non potevamo ancora saperlo. Nel caldo di ottobre riprendiamo l’infinita SS18, continuando a costeggiare il mare, in quel tratto tirrenico poco noto a coloro che, viaggiando sulla SA-RC tendono, a questo punto, ad addentrarsi tra i monti, abbandonando la costa.
Ancora sole in abbondanza e cemento armato in eccedenza, proprio sul mare, a distruggere quella che doveva essere una terra meravigliosa e che ormai è gravemente compromessa per lunghi tratti del proprio litorale. Impieghiamo così oltre cinque ore per raggiungere la nostra destinazione, Tortora, ultimo paese della Calabria che si apre su un dolce golfo dal tramonto mozzafiato.
Qui incontriamo Biagio, guerrigliero del biologico, musico e teatrante, boicottatore di supermercati e cavaliere donchisciottiano a dorso di Clementina, il suo asino. Barricati nel “ricetto” – la base operativa del suo progetto di turismo responsabile – parliamo a lungo e animatamente di tutte le questioni che abbiamo affrontato, dall’alimentazione, all’economia, al paesaggio, alla cultura, alla terra, alla mafia, all’inquinamento.
Dormiamo così a pochi passi dal Noce, il fiume che segna il confine con la Basilicata, nell’ultimo lembo di una terra che ci ha stupiti e rigenerati al di là di ogni previsione. La Calabria: un posto duro e difficile ma ricco di enzimi e di spunti, di cani randagi che si ribellano alle catene più per rabbia che per scienza o calcolo e fuggono via, come fecero i briganti tanto tempo fa.

Il Cilento
Lo stacco che l’ingresso in Basilicata porta con sé fa quasi sorridere tanto è marcato, persino parodistico. Improvvisamente sembra di essere finiti da qualche parte nel Nord Europa, dove tutto funziona e le tutele ambientali e umane hanno una ragion d’essere nelle persone, prima ancora che nelle istituzioni. Così la Basilicata tirrenica è un piccolo tratto di paradiso assolutamente intatto e di una bellezza senza rivali, con le sue scogliere a picco sul mare, i suoi boschi di pini e querce, i suoi paesini curatissimi e la statale antica e morbida, che si insinua tra portentosi terrapieni scavati con discrezione nella roccia che precipita ripidissima sul mare. Dietro la curva si apre però un nuovo scorcio, definitivo, custodito dallo stretto golfo che dà sbocco sul mare alla cittadina di Sapri. Sullo sfondo ci sono delle montagne importanti, gravide. Siamo entrati in Campania, l’ultima regione continentale che visiteremo e quello che vediamo davanti a noi è il famoso Cilento, una terra che si annuncia bella e misteriosa. Scattiamo una foto dall’alto e scendiamo per addentrarci. È appena passata l’ora di pranzo.
Per arrivare a Morigerati, dove ci aspettano Antonio, Dario e Claudia, dobbiamo affrontare una lunga salita che sfonda la barriera della costa e penetra tra i monti, dove i paesi sono nascosti alla nostra vista come lo furono nei secoli precedenti a quella dei saraceni e dei pirati. Il Cilento si mostra da subito per quella che ci sembrerà la sua caratteristica principale: una terra impervia e racchiusa tra i monti, capace di custodire ricchezze e conoscenze oltre l’immaginabile. Un dedalo di paesini che distano una decina di chilometri uno dall’altro e che costellano un’area decisamente vasta, collegata a stento nel suo interno e con un densità abitativa tra le più basse in Italia. Un paesaggio sinceramente appenninico, montano, subito a ridosso di uno splendido mare. Un luogo che non ha paragoni nel nostro paese e che, per certi aspetti, ci ricorda la rada di Donostia, nel Paese Basco, più che altri luoghi già visitati in questo viaggio.
Passiamo il pomeriggio, breve ma intensissimo, con i nostri nuovi amici “resilienti” (la resilienza è la capacità di un materiale di assorbire un urto e di tornare nella posizione originaria – così loro vogliono che faccia il Cilento con la società del consumo di massa), intavolando una di quelle discussioni che ti lascia quel raro senso di soddisfazione intellettuale, di scambio, di compenetrazione delle idee e dei bisogni. Uno dei momenti più importanti da quando, oltre quaranta giorni prima e una vita fa, abbiamo lasciato la nostra città.

Gomorra
Ripartiamo sotto una fredda pioggia. La vespa si accende solo dopo una decina di minuti buoni. La candela, con cui abbiamo girato mezza Europa e tutta l’Italia ha fatto il suo corso e con l’umidità la corrente non arriva più tanto bene. Alla fine ci buttiamo giù dalla discesa del paese e ingraniamo energicamente la seconda, facendo partire per forza di cose il motore. Poi sfoggiamo nuovamente i nostri kit contro le intemperie e ci imbarchiamo sbracciando grandi saluti in un percorso che ci dovrà portare fino a Napoli, a oltre 200 km a Nord dal punto in cui ci troviamo.
Impieghiamo parecchie ore a guadagnare l’ingresso di Agropoli, la prima cittadina della piana di Salerno, “perdendoci” volentieri lungo il tracciato della ex SS18, che si inerpica tra paesini in quota dove i castagni appenninici si uniscono agli ulivi mediterranei in un mix inedito, simile a quelli che si possono trovare nell’entroterra della Corsica.
Sulla strada per Salerno veniamo attaccati da un forte acquazzone, che affrontiamo con piglio eroico, iniziando a vedere i primi segni di quel tipico “degrado” campano, fatto di personaggi un po’ minacciosi, prostituzione e munnizza ai lati della strada, ma anche delle rovine della splendida città di Paestum. Arte assoluta e diossina, ricchezza e miseria nello stesso piatto. È l’Italia, e se non la capisci per quello che è o te ne vai o prendi le armi, che è poi quello che succede da sempre senza nessun risultato apprezzabile.
Raggiungiamo Napoli in autostrada, rinunciando all’impresa di affrontare i paesi ai piedi del Vesuvio con la frizione in pessime condizioni e l’orologio che ci mette fretta. Attraversiamo tutta la città dall’alto, sopra la tangenziale, da dove si gode di una vista bellissima, su uno dei luoghi più indecifrabili e affascinanti di sempre. Una vera e propria città-stato, un grumo culturale e sociale indipendente, un luogo eterno, capace di sopravvivere a sé stesso per secoli e di restare incantevole.
A Fuorigrotta raggiungiamo Luigi, che ci scorta con la macchina lungo la via Domiziana, verso litorale domizio, dove lasceremo vespa e bagagli per cenare in un paese che non ha bisogno di presentazioni: Casal di Principe, provincia di Caserta, la «terra dei fuochi». Quello che troviamo là è per tanti aspetti l’apice del nostro viaggio, il punto più alto che ci è concesso nel ribaltamento degli schemi con cui siamo indottrinati a “conoscere” l’Italia. Una grossa fortuna che arriva quasi al termine del nostro percorso. A Casal di Principe troviamo un luogo pieno di umanità, di militanza, di consapevolezza. Proprio in fondo a uno dei vicoli del paese veniamo accolti in una palazzina confiscata alla camorra e gestita da un gruppo di persone che l’ha trasformata in una struttura per malati mentali gravi, al cui interno i “pazienti” abitano serenamente, senza costrizioni e dove è aperto anche il buonissimo ristorante del piano terra, in cui abbiamo il piacere di passare la serata. Parliamo con i ragazzi della cooperativa, ascoltiamo i racconti e i progetti che hanno realizzato e che hanno in mente. Oggi si discute del progetto di bonifica dal basso delle terre contaminate dai rifiuti tossici, il vero dramma di questa zona, attraverso un sistema di colture legate alla produzione di fibra tessile e a una mappatura dettagliata dei terreni ancora sani. Ci spiegano che è proprio nella relazione sociale che sta tutta la forza necessaria a creare legami ed economie alternative a quelle camorristiche. Sono la Nuova Cooperativa Organizzata, che già nel nome fa il verso alla NCO di Raffaele Cutolo, boss di qualche tempo fa e ne rappresenta la necessaria successione, la vittoria dei “giusti” su chi per denaro ha svenduto la sua terra e la sua gente. Il livello di analisi della situazione mette i brividi, così come lasciano senza parole le pratiche che da questa analisi scaturiscono, dalla cura dei malati mentali dell’ex OPG di Aversa al perfetto inserimento di una simile struttura e delle sue attività all’interno di un paese che la stampa descrive come l’Inferno e che noi per primi avevamo avvicinato con paura. E invece è proprio qui, nell’ultimo dei posti, che incontriamo quelli con la schiena più dritta e gli occhi più grandi. Ora, per noi che lo abbiamo visto davvero, Casal di Principe sarà sempre il posto dove Peppe vive coi suoi pazzi, ridisegnando quelle vie in cui spadroneggiavano i leggendari capiclan, tessendo giorno dopo giorno la trama del paese reale, fatto di persone in carne e ossa che si alzano la mattina e vanno a rischiare e a combattere in prima persona. Senza che nessuno scriva nulla su di loro.
.jpg)


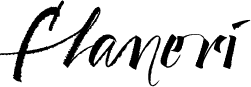
 www.flaneri.com
www.flaneri.com