“Proust e Vermeer” di Lorenzo Renzi
di Mario Massimo / 30 ottobre 2012
La mostra Vermeer, il secolo d’oro dell’arte olandese, attualmente in corso alle Scuderie del Quirinale, e già segnalata da Flanerí, sembra riproporre, con splendidi risultati poetici, il tema del rapporto fra realtà e invenzione; esso è, quasi manualisticamente, squadernato avanti alla nostra attenzione, intanto nei vertici assoluti di almeno sei degli otto dipinti del maestro eponimo: in quelli, soprattutto, in cui una figura femminile, sola entro uno spazio domestico stagliato, si direbbe, nel silenzio, viene visitata da strepitose emanazioni di luce diurna che, per quanto accenda nitidezze di diamante nei vetri attraverso cui passa, non arriva, per il fenomeno di una misteriosa legge fisica di cui solo la mente (o forse, pascalianamente?, il cuore) dell’artista conosce il segreto, a dissipare la parvenza brumosa dell’umana carne alle braccia, alle mani, al volto.
Ma con chiarezza forse perfino più commovente, ciò risulta nel modo in cui nelle opere degli epigoni irrompe, a farsi epica di un borghese hic et nunc, la vita quotidiana: le stanze da letto da rigovernare, i cortili, gli interni che fanno da teatro al femminile spaccarsi le reni su un pavimento da tirare a lucido, o ancora, delle donne, il gesto di silenzioso orgoglio con cui, infreddolite entro la giacca da camera bordata di pelliccia, si sigilla una lettera (ci sarà un invito d’amore? Saranno solo pettegolezzi fra donne? In ogni caso: un affermare se stesse, alla faccia del mondo) e la si consegna alla servente per il riservato recapito.
E che dire, della sfacciata, lenticolare precisione con cui un Pieter de Hooch, nel “Ritratto di famiglia in un cortile di Delft”, da Vienna, scandisce i tratti del viso del patriarca seduto, nelle sue vesti tutte in rigoroso nero, a guardare negli occhi l’osservatore, quasi gettandogli in faccia il modo in cui, ancora a proprio agio in un mondo dove il suo Signore gli ha consentito di far buoni affari, e mantenere moglie, la sorella anziana, i due poco fattivi figli maschi, la quadrata figlia e il genero con la sua eleganza da damerino di provincia, non mostra il minimo desiderio di staccarsene?
Ma ancor meglio, direi, di quando è Vermeer a imporle le sue meditative leggi, la “verità” dell’invenzione trionfa quando è poi lui stesso, Vermeer, a farsi oggetto dell’alchemica deformazione operata, sull’opera sua, da un altro creatore: come ci ricorda proprio in questi giorni Lorenzo Renzi con l’edizione rivista del suo Proust e Vermeer. Apologia dell’Imprecisone (Il Mulino, 2012).
La “Veduta di Delft”,nella cui contemplazione, a metà di La prisonniére, lo scrittore Bergotte viene colto dal colpo apoplettico che lo ucciderà – con la stupenda metafora dei suoi libri, spalancati come ali di cherubini a vegliarne la salma, che anche Visconti recuperò per lo pseudo-D’Annuzio del suo Filippo Arborio nell’Innocente,e che qui Renzi sottopone a un’ironica quanto divertita verifica d’impraticabilità – non contiene affatto, come appunto Renzi stesso ci accompagna per mano a verificare, il «piccolo lembo di muro giallo» che riempie di stupore Bergotte. Ma eccolo, allora, il trionfo sublime dell’invenzione: proprio come la luce squisitamente selettiva del maestro di Delft, la parola dello scrittore vince la sua scommessa ogni volta che ci rende “vera” la sua più splendida menzogna, il suo meraviglioso “non-essere” come nella realtà che ci stanca i sensi ogni giorno.
(Lorenzo Renzi, Proust e Vermeer. Apologia dell’Imprecisone, Il Mulino, 2012, pp. 128, euro 10)


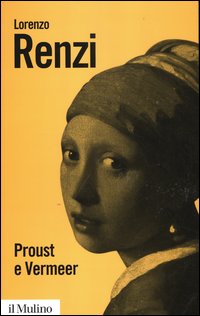



Comments