“L’uomo di Kiev”
di Bernard Malamud
di Lorenza Starace / 1 ottobre 2014
Speditissimi, i primi due capitoli de L’uomo di Kiev di Bernard Malamud (minimum fax, 2014), raccontano il viaggio di Yakov Bok dall’Ucraina alla Russia, la voglia di riscattarsi dal disonore inflittogli da una moglie sterile e infedele, l’assunzione in una fabbrica di mattoni, l’arresto per un crimine non commesso. Esemplificano, con quella frettolosità che non temporeggia né psicologicamente né descrittivamente né dialogicamente, la poetica di Bernard Malamud: «Storie, storie, storie: per me non esiste altro». Un incontro amoroso si esaurisce in mezza pagina, il dilemma di un ebreo sul lavorare per un antisemita viene spazzato via dal narratore in una dozzina di righe, un interrogatorio passa dai convenevoli a un dibattito su Spinoza in poche battute.
Come scrive Alessandro Piperno nell’introduzione, «Malamud elude programmaticamente qualsiasi piacioneria, non concede niente allo spettatore. E questo è un rischio immenso per uno scrittore. Devi avere fegato, carattere e una straordinaria fiducia nella storia che ti accingi a raccontare per non blandire il lettore sin dalla prima riga».
Dal terzo capitolo, all’andamento iperprogressivo s’addiziona un movimento ciclico, un va-e-vieni di pensieri, di ricordi, di ritorni a fatti manipolati da procuratori, preti e testimoni incolleriti col popolo eletto: «nessun ebreo è innocente», perché «gli ebrei dominano il mondo, e noi sentiamo il peso del loro giogo», urla Grubeshov. Il lettore viene segregato nei pochi metri quadri di una cella e, non visto, assiste inerte agli strazi del protagonista – ingiustamente accusato, come Mendel Beilis nel 1911, d’aver «ucciso e dissanguato a scopi rituali» un bambino.
«Non c’era una “ragione”, c’era soltanto un complotto contro un ebreo, un ebreo qualsiasi, e lui era l’uomo scelto casualmente come capro espiatorio. L’avrebbero processato perché era stata formulata un’accusa, non c’era bisogno di altre ragioni. Nascere ebreo significava essere vulnerabili alla storia e ai suoi errori più spaventosi».
Malamud anticipa di pochi anni la riflessione di René Girard sul capro espiatorio, ed è acutissimo a focalizzarsi sulla figura di Cristo – «se è andata così, e questo fa parte della loro religione e loro ci credono, come possono tenermi in prigione sapendo che sono innocente?» – e a cogliere la dimensione collettiva del meccanismo sacrificale, suffragata dall’interesse dello zar in persona al caso di Yakov – «Lo zar lo voleva condannato e punito».
Se scrivi di persecuzione ebraica ante-Shoah nel 1966, è improbabile che la tua storia ambientata nella Russia zarista del 1911 non rievochi quelle delle vittime del Nazismo. Come loro, Yakov soffre fisicamente – «I suoi piedi tumefatti […] erano come sacchetti gonfiati e pronti a scoppiare» – e mentalmente – col terrore di, che pian piano diventa desiderio di morire. Come loro, familiarizza col degrado: «Uno scarafaggio nella scodella non gli dava più noia, ora: lo tirava fuori e continuava a mangiare, e dopo leccava pure la ciotola». Come loro, e soprattutto come Primo Levi, trova sollievo nella memoria delle «cose che aveva letto». Si differenzia, invece, in quanto isolato e inattivo – stati che ne condizionano la percezione temporale: «Il terzo giorno è il primo, il quarto è il primo, il settantunesimo è il primo. Il primo giorno è il tremillesimo».
Se leggi L’uomo di Kiev, è vero che te ne stai rinchiuso in quella cella senza far nulla, ma quando, finito il romanzo, ne evadi, sai che «la storia è piena di limiti e di barriere, come se in una casa avessero inchiodato le porte e per uscire bisognasse saltar già dalla finestra», e ti viene un’indomabile voglia di schiodare quelle porte.
(Bernard Malamud, L’uomo di Kiev, trad. di Ida Omboni, minimum fax, 2014, pp. 405, euro 14,50)


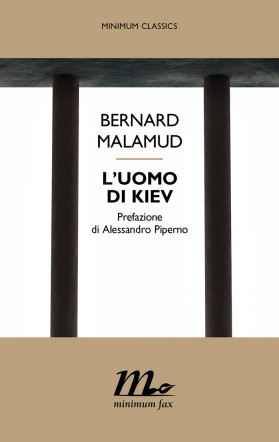



Comments