“Democracy”
di Joan Didion
di Lorenza Starace / 19 dicembre 2014
Nel 1992 Joyce Carol Oates concepì un romanzo breve – inusualmente breve, se si pensa alla sua torrenziale produzione romanzesca – sulla base di alcune annotazioni prese nel 1979. Quelle annotazioni (che riguardavano un evento di cronaca nera) divennero poi il fulcro di Black Water, la storia dell’incontro tra il Senatore e Kelly, dell’auto di lui che sbanda e finisce nell’Indian River, dell’acqua nera che li inghiottisce entrambi, la storia della palude da cui solo il Senatore riemerge e, lui, solo, si salva. Di questo piccolo e potente nucleo, carico di allusioni alla tracotanza del potere e all’inafferrabile ingerenza che questo ha sulla vita del singolo, sembra figlio anche Democracy (edizioni e/o, Roma, 2014), quarto romanzo di Joan Didion. Pubblicato negli Stati Uniti nel 1984 (ma ambientato nel 1975) di nuovo sulla scorta di alcune note (relative stavolta alle sensazioni che le immagini della caduta di Saigon evocarono nell’autrice), Democracy sembra comporre con Acqua nera uno splendido dittico. Come nel romanzo della Oates, anche al centro di Democracy ci sono un senatore, Harry Victor, e una giovane donna, sua moglie, Inez Victor, nata Christian. E come la Kelly di Acqua nera finisce per soccombere, intrappolata nel sedile dell’auto del Senatore, anche Inez Victor, pare arrendersi di fronte alle manipolazioni del marito, della stampa, delle continue incombenze che la vita di moglie di senatore le impone; manipolazioni senza le quali la vita di Inez non sembra neppure concepibile: Inez è la figlia di Paul Christian, è «conosciuta sul posto [le Hawaii] come la nipote di Dwight Christian», è, naturalmente, la moglie di Harry Victor. La sua identità è continuamente presentata attraverso un referente esterno, come se l’autrice stessa non sapesse introdurla altrimenti, come se neppure agli occhi di Joan Didion Inez fosse sufficientemente interessante nella sua singolarità: a p. 22 è la Didion stessa ad ammettere: «Dapprima delle due figlie mi interessava più Janet, la sorella minore».
Così, mentre il marito è all’apice della carriera (ha persino corso per la presidenza degli Stati Uniti) questa inafferrabile ed eterea Inez (più eterea che inafferrabile, forse, vale a dire più evanescente che enigmatica) assiste, apparentemente inerte, al lento sfacelo della sua vita privata. Ma se il colore del romanzo della Oates è quello scuro e implacabile della melma della palude, Democracy si apre con il tenue color pastello della luce dell’alba: «La luce dell’alba durante i test del Pacifico era qualcosa da vedere. Qualcosa da contemplare. Qualcosa che ti faceva quasi pensare d’aver visto Dio». Perché Inez, a differenza di Kelly, ha qualcos’altro oltre Harry, il senatore. Inez ha anche Jack Lovett, ha forse solo Jack Lovett, «solo» perché è l’unico frammento della sua esistenza non mediato (e mediatizzato) dalle dichiarazioni del marito, da quelle dei suoi fidati portavoce, della stampa e neppure dalla Didion stessa. È infatti Jack è il solo personaggio che Joan Didion sembra rinunciare a delineare con nettezza: figura ambigua, forse trafficante d’armi, forse agente segreto, incontrato da un’Inez ancora quindicenne (lui è di vent’anni più vecchio) a Honolulu, dove viveva con la famiglia del padre. Tra Honolulu e il Sudest asiatico, tra San Francisco e Washington, sullo sfondo della politica internazionale, si snodano le vicende alterne di Harry Victor e Inez (che nel 1975, anno della disfatta vietnamita, sono sposati ormai da vent’anni), e di Inez e Jack Lovett, la cui relazione extraconiugale a tratti sembra non essere neppure mai stata consumata.
Di Acqua nera Democracy è però più (splendido) controcanto che speculare esperimento narrativo. Se nel racconto di Kelly infatti Oates autrice si dileguava nel monologo fiume della ragazza morente, in Democracy Didion procede per frammenti giustapposti, intervenendo ogni volta che può proprio en tant que autrice, a volte per puntualizzare a volte per esprimere le sue stesse incertezze: fingendo di aver conosciuto Inez (mentre lavoravano assieme alla redazione di Vogue, cui effettivamente Joan Didion ha lavorato in quegli anni) la Didion fa del suo romanzo un’inchiesta romanzesca metanarrativa la cui cifra ibrida si riflette in ogni suo aspetto, dall’intento alla struttura, dall’invadente presenza dell’io autoriale allo stile. «Io non ho un modo univoco per cominciarlo [il romanzo], benché abbia certe cose in mente» dice la Didion. «Ho in mente» continua «Colori, umidità, calore, l’aria abbastanza azzurra, le parole che Inez stessa usò per spiegare perché si era fermata a Kuala Lumpur». Da questo lirico nucleo centrale Joan Didion sceglie di non narrare («Ecco i cocci del romanzo che non scriverò più, l’isola, la famiglia, la situazione. Ho perso la pazienza. O me n’è mancato il coraggio») la storia dell’ascesa e della caduta della famiglia di Inez, tema che avrebbe sicuramente avuto bisogno di una struttura narrativa più canonica, ma di lasciare la storia snodarsi da sé, attraverso le sue differenti versioni e la mimesi dei generi più vari (storia d’amore, cinica analisi politica, autofiction, persino il giallo), in uno stile sempre bilanciato (ed è questa la prima e la maggiore forza del romanzo) tra indagine documentaristica e impulso lirico, tra toni distaccati e toni più ironici: e il titolo è l’ironia suprema, quella democracy nell’anno che di una certa idea di democrazia ha segnato la fine.
(Joan Didion, Democracy, trad. di Rossella Bernascone, e/o, 2014, pp. 224, euro 14,50)


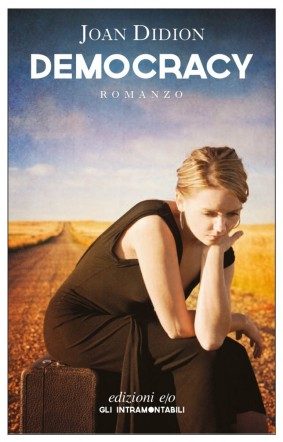



Comments