“L’ultimo arrivato”
di Marco Balzano
Tra i finalisti del Premio Campiello 2015
di Chiara Gulino / 10 luglio 2015
Chissà se anche mio nonno, prima di emigrare a Roma da un paesino sperduto in provincia di Palermo, mangiava per colazione un’acciuga spalmata su una fetta di pane in cassetta e questo parco pasto doveva bastargli fino a sera, venendo così tormentato per tutto il giorno dai morsi della fame come Ninetto Giacalone, voce narrante de L’ultimo arrivato di Marco Balzano (Sellerio, 2014), finalista al Premio Campiello 2015.
Non l’ho mai chiesto a mio nonno. Di certo, la denutrizione è stata un’innaturale, spietata erosione dell’innocenza primordiale di quei tanti «picciriddi» degli anni Cinquanta-Sessanta, nati in un Meridione arretrato e reso ancora più povero dalla guerra.
Molti prendevano brutte strade: «Così se qualcuno con le mie stesse calorie in corpo mi proponeva di andare a rubare, io subito ci stavo». Pochi erano quelli che potevano permettersi di andare a scuola.
A Ninetto la scuola piaceva. Era curioso e sveglio e aveva sviluppato un particolare affetto per il maestro Vincenzo che gli aveva trasmesso l’amore per le poesie che mandava a memoria come sorsi di acqua fresca. Al maestro voleva bene più che al padre da cui riceveva solo mazzate: «Quanto alle mazzate che certe sere mi tirava, invece, non c’è da filosofare troppo o fare i sofisticati. I genitori a San Cono tiravano tutti mazzate, punto e basta. Come per il cielo è normale piovere, per una vacca muggire, per un albero far cadere le foglie, per un genitore di San Cono era naturale sganciare mazzate».
La vita di Ninetto ha una svolta la notte del 10 ottobre 1959 quando la madre è colpita da un ictus. Il ragazzino, che ha appena nove anni, è così costretto ad abbandonare gli studi per andare con il padre «a fare lo jurnataru» presso il podere di don Alfio.
Ben presto però Ninetto viene indotto ad andare a cercare fortuna al Nord. La madre infatti viene ricoverata in uno squallido ospizio e il padre si dà alle carte sperperando quel poco denaro guadagnato: «Comunque non è che sono emigrato da un giorno all’altro. Non è che un piccriddu piglia e parte in quattro e quattr’otto. Prima mi hanno fatto venire a schifo tutte cose, ho collezionato litigate, digiuni, giornate di nervi impizzati, e solo dopo me ne sono andato via».
Balzano ci parla con un’intensa forza narrativa ed emotiva di un tema storico del nostro Paese, tragicamente attuale, soffermandosi su un aspetto poco noto del fenomeno: quello che a partire per il Nord Italia fossero spesso bambini fra i nove e i tredici anni, accompagnati da un compare (ovvero un quasi parente) o un semplice paesano.
Emigrare allargava il campo, facendo apparire il proprio paesino con annessa piazza per quello che era: un paesino di poche anime e la piazza poco più grande di un cortile. La città invece profumava di mondo pur in un’Italia ancora molto provinciale.
Ogni persona è diversa, ma sempre diversamente umana, fragile e forte, vittima e artefice del proprio destino.
Ninetto ha una visione del mondo drammaticamente realistica. Quando il maestro Vincenzo gli prospetta che a Milano avrebbe potuto anche trovare la felicità, essere finalmente felice, avverte tutta l’insensatezza di quella parola: «Disse proprio felice e ricordo che la parola mi sembrò come i pantaloni per la campagna. Grande e male adatta».
È con questa scrittura limpida, di un’immediatezza mimetica dell’italiano dialettale, che l’autore sollecita senza posa l’emozione del lettore quando racconta attraverso le avventure del protagonista la storia del nostro Paese dal dopoguerra a oggi: l’emigrazione interna; il razzismo verso i meridionali immigrati sprezzantemente soprannominati «terroni, rubapane, napulì, morti di fame»; lo sfruttamento minorile sottopagato e in nero; l’alienante lavoro in fabbrica; la catena di montaggio e le lotte sindacali; il carcere; il difficile ritorno ad una vita normale in una società cambiata ma ugualmente colpita da una diversa crisi e disoccupazione.
Ninetto pagherà caro, con dieci anni di detenzione, un errore commesso per la sua ignoranza nell’esprimere nel giusto modo il suo amore per la figlia. All’uscita dalla prigione troverà tutto cambiato: laddove prima c’erano «fabbriche e fabbrichette, file di tetti puntuti e capannoni di lamiera», ora non è rimasto più niente tranne quello che chiamava «alveare», quel palazzone dai muri scrostati e dall’odore di varia umanità inasprita dal puzzo dei bagni, dove si era rifugiato a dormire al suo arrivo a Milano, ora occupato dai nuovi immigrati, africani, rumeni e altri «poveri cristi». E arriverà a un’amara conclusione: «Non ci sono storie, è fuori dal carcere la vera pena da scontare».
L’ultimo arrivato, frutto di interviste sapientemente amalgamate in una storia commovente e fortemente italiana, mi ha fatto riflettere su un particolare rimosso delle mie origini familiari. E leggere il suo romanzo è stato come essere abbracciati da qualcuno con il calore e la varietà dei sentimenti umani. Del resto, gli scrittori hanno di speciale quello di fare caso ai dettagli che le persone normalmente non notano. Si soffermano, li analizzano, ricavandone intuizioni illuminanti.
E chissà se anche mio nonno aveva la stessa faccia sporca di strada di Ninetto a nove anni. Avrei dovuto chiederglielo.
(Marco Balzano, L’ultimo arrivato, Sellerio, 2014, pp. 212, euro 15)
LA CRITICA
L’ultimo arrivato di Marco Balzano è un feroce viaggio nelle nostre origini quando la necessità e l’indigenza si traducevano in una lotta darwiniana alla sopravvivenza.


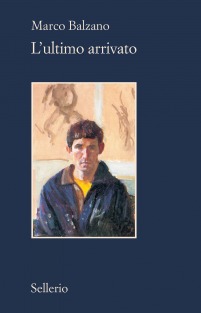



Comments